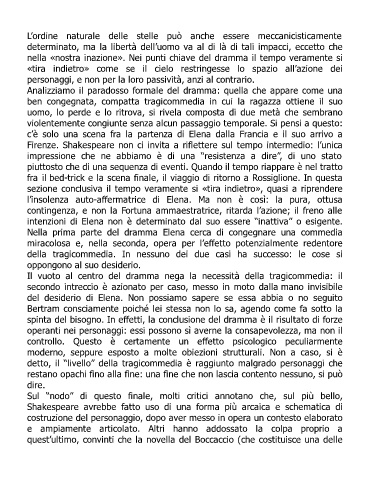Page 640 - Shakespeare - Vol. 3
P. 640
L’ordine naturale delle stelle può anche essere meccanicisticamente
determinato, ma la libertà dell’uomo va al di là di tali impacci, eccetto che
nella «nostra inazione». Nei punti chiave del dramma il tempo veramente si
«tira indietro» come se il cielo restringesse lo spazio all’azione dei
personaggi, e non per la loro passività, anzi al contrario.
Analizziamo il paradosso formale del dramma: quella che appare come una
ben congegnata, compatta tragicommedia in cui la ragazza ottiene il suo
uomo, lo perde e lo ritrova, si rivela composta di due metà che sembrano
violentemente congiunte senza alcun passaggio temporale. Si pensi a questo:
c’è solo una scena fra la partenza di Elena dalla Francia e il suo arrivo a
Firenze. Shakespeare non ci invita a riflettere sul tempo intermedio: l’unica
impressione che ne abbiamo è di una “resistenza a dire”, di uno stato
piuttosto che di una sequenza di eventi. Quando il tempo riappare è nel tratto
fra il bed-trick e la scena finale, il viaggio di ritorno a Rossiglione. In questa
sezione conclusiva il tempo veramente si «tira indietro», quasi a riprendere
l’insolenza auto-affermatrice di Elena. Ma non è così: la pura, ottusa
contingenza, e non la Fortuna ammaestratrice, ritarda l’azione; il freno alle
intenzioni di Elena non è determinato dal suo essere “inattiva” o esigente.
Nella prima parte del dramma Elena cerca di congegnare una commedia
miracolosa e, nella seconda, opera per l’effetto potenzialmente redentore
della tragicommedia. In nessuno dei due casi ha successo: le cose si
oppongono al suo desiderio.
Il vuoto al centro del dramma nega la necessità della tragicommedia: il
secondo intreccio è azionato per caso, messo in moto dalla mano invisibile
del desiderio di Elena. Non possiamo sapere se essa abbia o no seguito
Bertram consciamente poiché lei stessa non lo sa, agendo come fa sotto la
spinta del bisogno. In effetti, la conclusione del dramma è il risultato di forze
operanti nei personaggi: essi possono sì averne la consapevolezza, ma non il
controllo. Questo è certamente un effetto psicologico peculiarmente
moderno, seppure esposto a molte obiezioni strutturali. Non a caso, si è
detto, il “livello” della tragicommedia è raggiunto malgrado personaggi che
restano opachi fino alla fine: una fine che non lascia contento nessuno, si può
dire.
Sul “nodo” di questo finale, molti critici annotano che, sul più bello,
Shakespeare avrebbe fatto uso di una forma più arcaica e schematica di
costruzione del personaggio, dopo aver messo in opera un contesto elaborato
e ampiamente articolato. Altri hanno addossato la colpa proprio a
quest’ultimo, convinti che la novella del Boccaccio (che costituisce una delle