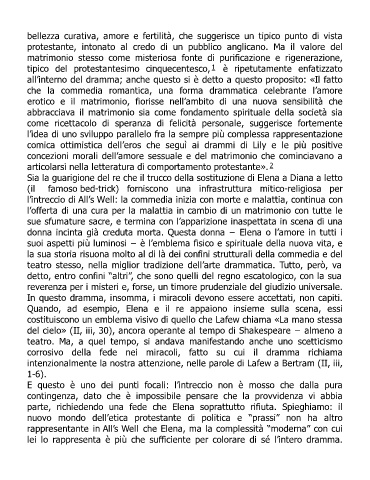Page 638 - Shakespeare - Vol. 3
P. 638
bellezza curativa, amore e fertilità, che suggerisce un tipico punto di vista
protestante, intonato al credo di un pubblico anglicano. Ma il valore del
matrimonio stesso come misteriosa fonte di purificazione e rigenerazione,
1
tipico del protestantesimo cinquecentesco, è ripetutamente enfatizzato
all’interno del dramma; anche questo si è detto a questo proposito: «Il fatto
che la commedia romantica, una forma drammatica celebrante l’amore
erotico e il matrimonio, fiorisse nell’ambito di una nuova sensibilità che
abbracciava il matrimonio sia come fondamento spirituale della società sia
come ricettacolo di speranza di felicità personale, suggerisce fortemente
l’idea di uno sviluppo parallelo fra la sempre più complessa rappresentazione
comica ottimistica dell’eros che seguì ai drammi di Lily e le più positive
concezioni morali dell’amore sessuale e del matrimonio che cominciavano a
articolarsi nella letteratura di comportamento protestante». 2
Sia la guarigione del re che il trucco della sostituzione di Elena a Diana a letto
(il famoso bed-trick) forniscono una infrastruttura mitico-religiosa per
l’intreccio di All’s Well: la commedia inizia con morte e malattia, continua con
l’offerta di una cura per la malattia in cambio di un matrimonio con tutte le
sue sfumature sacre, e termina con l’apparizione inaspettata in scena di una
donna incinta già creduta morta. Questa donna − Elena o l’amore in tutti i
suoi aspetti più luminosi − è l’emblema fisico e spirituale della nuova vita, e
la sua storia risuona molto al di là dei confini strutturali della commedia e del
teatro stesso, nella miglior tradizione dell’arte drammatica. Tutto, però, va
detto, entro confini “altri”, che sono quelli del regno escatologico, con la sua
reverenza per i misteri e, forse, un timore prudenziale del giudizio universale.
In questo dramma, insomma, i miracoli devono essere accettati, non capiti.
Quando, ad esempio, Elena e il re appaiono insieme sulla scena, essi
costituiscono un emblema visivo di quello che Lafew chiama «La mano stessa
del cielo» (II, iii, 30), ancora operante al tempo di Shakespeare − almeno a
teatro. Ma, a quel tempo, si andava manifestando anche uno scetticismo
corrosivo della fede nei miracoli, fatto su cui il dramma richiama
intenzionalmente la nostra attenzione, nelle parole di Lafew a Bertram (II, iii,
1-6).
E questo è uno dei punti focali: l’intreccio non è mosso che dalla pura
contingenza, dato che è impossibile pensare che la provvidenza vi abbia
parte, richiedendo una fede che Elena soprattutto rifiuta. Spieghiamo: il
nuovo mondo dell’etica protestante di politica e “prassi” non ha altro
rappresentante in All’s Well che Elena, ma la complessità “moderna” con cui
lei lo rappresenta è più che sufficiente per colorare di sé l’intero dramma.