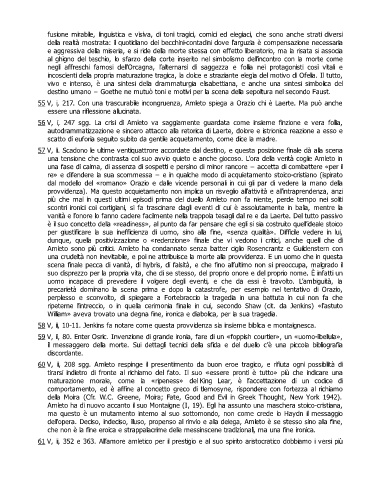Page 384 - Shakespeare - Vol. 3
P. 384
fusione mirabile, linguistica e visiva, di toni tragici, comici ed elegiaci, che sono anche strati diversi
della realtà mostrata: il quotidiano dei becchini-contadini dove l’arguzia è compensazione necessaria
e aggressiva della miseria, e si ride della morte stessa con effetto liberatorio, ma la risata si associa
al ghigno del teschio, lo sfarzo della corte inserito nel simbolismo dell’incontro con la morte come
negli affreschi famosi dell’Orcagna, l’alternarsi di saggezza e follia nei protagonisti così vitali e
incoscienti della propria maturazione tragica, la dolce e straziante elegia del motivo di Ofelia. Il tutto,
vivo e intenso, è una sintesi della drammaturgia elisabettiana, e anche una sintesi simbolica del
destino umano − Goethe ne mutuò toni e motivi per la scena della sepoltura nel secondo Faust.
55 V, i, 217. Con una trascurabile incongruenza, Amleto spiega a Orazio chi è Laerte. Ma può anche
essere una riflessione allucinata.
56 V, i, 247 sgg. La crisi di Amleto va saggiamente guardata come insieme finzione e vera follia,
autodrammatizzazione e sincero attacco alla retorica di Laerte, dolore e istrionica reazione a esso e
scatto di euforia seguito subito da gentile acquetamento, come dice la madre.
57 V, ii. Scadono le ultime ventiquattrore accordate dal destino, e questa posizione finale dà alla scena
una tensione che contrasta col suo avvio quieto e anche giocoso. L’ora della verità coglie Amleto in
una fase di calma, di assenza di sospetti e persino di minor rancore − accetta di combattere «per il
re» e difendere la sua scommessa − e in qualche modo di acquietamento stoico-cristiano (ispirato
dal modello del «romano» Orazio e dalle vicende personali in cui gli par di vedere la mano della
provvidenza). Ma questo acquietamento non implica un risveglio all’attività e all’intraprendenza, anzi
più che mai in questi ultimi episodi prima del duello Amleto non fa niente, perde tempo nei soliti
scontri ironici coi cortigiani, si fa trascinare dagli eventi di cui è assolutamente in balia, mentre la
vanità e l’onore lo fanno cadere facilmente nella trappola tesagli dal re e da Laerte. Del tutto passivo
è il suo concetto della «readiness», al punto da far pensare che egli si sia costruito quell’ideale stoico
per giustificare la sua inefficienza di uomo, sino alla fine, «senza qualità». Difficile vedere in lui,
dunque, quella positivizzazione o «redenzione» finale che vi vedono i critici, anche quelli che di
Amleto sono più critici. Amleto ha condannato senza batter ciglio Rosencrantz e Guildenstern con
una crudeltà non inevitabile, e poi ne attribuisce la morte alla provvidenza. E un uomo che in questa
scena finale pecca di vanità, di hybris, di falsità, e che fino all’ultimo non si preoccupa, malgrado il
suo disprezzo per la propria vita, che di se stesso, del proprio onore e del proprio nome. È infatti un
uomo incapace di prevedere il volgere degli eventi, e che da essi è travolto. L’ambiguità, la
precarietà dominano la scena prima e dopo la catastrofe, per esempio nel tentativo di Orazio,
perplesso e sconvolto, di spiegare a Fortebraccio la tragedia in una battuta in cui non fa che
ripeterne l’intreccio, o in quella cerimonia finale in cui, secondo Shaw (cit. da Jenkins) «l’astuto
William» aveva trovato una degna fine, ironica e diabolica, per la sua tragedia.
58 V, ii, 10-11. Jenkins fa notare come questa provvidenza sia insieme biblica e montaignesca.
59 V, ii, 80. Enter Osric. Invenzione di grande ironia, fare di un «foppish courtier», un «uomo-libellula»,
il messaggero della morte. Sui dettagli tecnici della sfida e del duello c’è una piccola bibliografia
discordante.
60 V, ii, 208 sgg. Amleto respinge il presentimento da buon eroe tragico, e rifiuta ogni possibilità di
tirarsi indietro di fronte al richiamo del fato. Il suo «essere pronti è tutto» più che indicare una
maturazione morale, come la «ripeness» del King Lear, è l’accettazione di un codice di
comportamento, ed è affine al concetto greco di tlemosyne, rispondere con fortezza al richiamo
della Moira (Cfr. W.C. Greene, Moira; Fate, Good and Evil in Greek Thought, New York 1942).
Amleto ha di nuovo accanto il suo Montaigne (I, 19). Egli ha assunto una maschera stoico-cristiana,
ma questo è un mutamento interno al suo sottomondo, non come crede lo Haydn il messaggio
dell’opera. Deciso, indeciso, illuso, propenso al rinvio e alla delega, Amleto è se stesso sino alla fine,
che non è la fine eroica e strappalacrime delle messinscene tradizionali, ma una fine ironica.
61 V, ii, 352 e 363. All’amore amletico per il prestigio e al suo spirito aristocratico dobbiamo i versi più