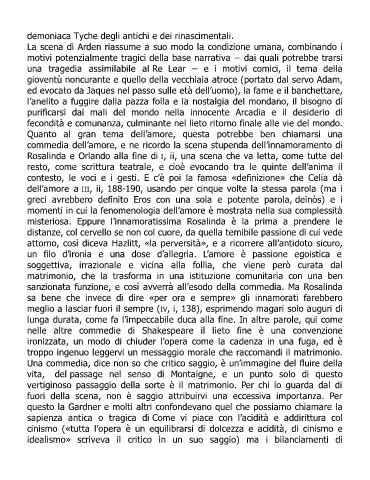Page 1762 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1762
demoniaca Tyche degli antichi e dei rinascimentali.
La scena di Arden riassume a suo modo la condizione umana, combinando i
motivi potenzialmente tragici della base narrativa − dai quali potrebbe trarsi
una tragedia assimilabile al Re Lear − e i motivi comici, il tema della
gioventù noncurante e quello della vecchiaia atroce (portato dal servo Adam,
ed evocato da Jaques nel passo sulle età dell’uomo), la fame e il banchettare,
l’anelito a fuggire dalla pazza folla e la nostalgia del mondano, il bisogno di
purificarsi dai mali del mondo nella innocente Arcadia e il desiderio di
fecondità e comunanza, culminante nel lieto ritorno finale alle vie del mondo.
Quanto al gran tema dell’amore, questa potrebbe ben chiamarsi una
commedia dell’amore, e ne ricordo la scena stupenda dell’innamoramento di
Rosalinda e Orlando alla fine di I, ii, una scena che va letta, come tutte del
resto, come scrittura teatrale, e cioè evocando tra le quinte dell’anima il
contesto, le voci e i gesti. E c’è poi la famosa «definizione» che Celia dà
dell’amore a III, ii, 188-190, usando per cinque volte la stessa parola (ma i
greci avrebbero definito Eros con una sola e potente parola, deinòs) e i
momenti in cui la fenomenologia dell’amore è mostrata nella sua complessità
misteriosa. Eppure l’innamoratissima Rosalinda è la prima a prendere le
distanze, col cervello se non col cuore, da quella temibile passione di cui vede
attorno, così diceva Hazlitt, «la perversità», e a ricorrere all’antidoto sicuro,
un filo d’ironia e una dose d’allegria. L’amore è passione egoistica e
soggettiva, irrazionale e vicina alla follia, che viene però curata dal
matrimonio, che la trasforma in una istituzione comunitaria con una ben
sanzionata funzione, e così avverrà all’esodo della commedia. Ma Rosalinda
sa bene che invece di dire «per ora e sempre» gli innamorati farebbero
meglio a lasciar fuori il sempre (IV, i, 138), esprimendo magari solo auguri di
lunga durata, come fa l’impeccabile duca alla fine. In altre parole, qui come
nelle altre commedie di Shakespeare il lieto fine è una convenzione
ironizzata, un modo di chiuder l’opera come la cadenza in una fuga, ed è
troppo ingenuo leggervi un messaggio morale che raccomandi il matrimonio.
Una commedia, dice non so che critico saggio, è un’immagine del fluire della
vita, del passage nel senso di Montaigne, e un punto solo di questo
vertiginoso passaggio della sorte è il matrimonio. Per chi lo guarda dal di
fuori della scena, non è saggio attribuirvi una eccessiva importanza. Per
questo la Gardner e molti altri confondevano quel che possiamo chiamare la
sapienza antica o tragica di Come vi piace con l’acidità e addirittura col
cinismo («tutta l’opera è un equilibrarsi di dolcezza e acidità, di cinismo e
idealismo» scriveva il critico in un suo saggio) ma i bilanciamenti di