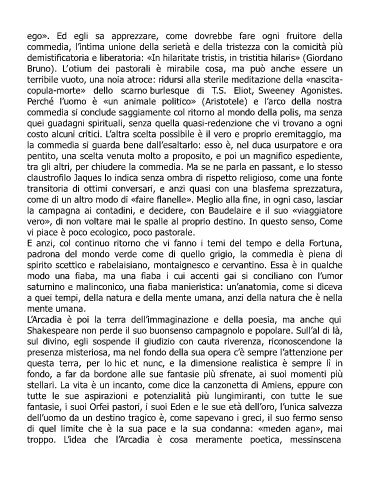Page 1759 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1759
ego». Ed egli sa apprezzare, come dovrebbe fare ogni fruitore della
commedia, l’intima unione della serietà e della tristezza con la comicità più
demistificatoria e liberatoria: «In hilaritate tristis, in tristitia hilaris» (Giordano
Bruno). L’otium dei pastorali è mirabile cosa, ma può anche essere un
terribile vuoto, una noia atroce: ridursi alla sterile meditazione della «nascita-
copula-morte» dello scarno burlesque di T.S. Eliot, Sweeney Agonistes.
Perché l’uomo è «un animale politico» (Aristotele) e l’arco della nostra
commedia si conclude saggiamente col ritorno al mondo della polis, ma senza
quei guadagni spirituali, senza quella quasi-redenzione che vi trovano a ogni
costo alcuni critici. L’altra scelta possibile è il vero e proprio eremitaggio, ma
la commedia si guarda bene dall’esaltarlo: esso è, nel duca usurpatore e ora
pentito, una scelta venuta molto a proposito, e poi un magnifico espediente,
tra gli altri, per chiudere la commedia. Ma se ne parla en passant, e lo stesso
claustrofilo Jaques lo indica senza ombra di rispetto religioso, come una fonte
transitoria di ottimi conversari, e anzi quasi con una blasfema sprezzatura,
come di un altro modo di «faire flanelle». Meglio alla fine, in ogni caso, lasciar
la campagna ai contadini, e decidere, con Baudelaire e il suo «viaggiatore
vero», di non voltare mai le spalle al proprio destino. In questo senso, Come
vi piace è poco ecologico, poco pastorale.
E anzi, col continuo ritorno che vi fanno i temi del tempo e della Fortuna,
padrona del mondo verde come di quello grigio, la commedia è piena di
spirito scettico e rabelaisiano, montaignesco e cervantino. Essa è in qualche
modo una fiaba, ma una fiaba i cui accenti gai si conciliano con l’umor
saturnino e malinconico, una fiaba manieristica: un’anatomia, come si diceva
a quei tempi, della natura e della mente umana, anzi della natura che è nella
mente umana.
L’Arcadia è poi la terra dell’immaginazione e della poesia, ma anche qui
Shakespeare non perde il suo buonsenso campagnolo e popolare. Sull’al di là,
sul divino, egli sospende il giudizio con cauta riverenza, riconoscendone la
presenza misteriosa, ma nel fondo della sua opera c’è sempre l’attenzione per
questa terra, per lo hic et nunc, e la dimensione realistica è sempre lì in
fondo, a far da bordone alle sue fantasie più sfrenate, ai suoi momenti più
stellari. La vita è un incanto, come dice la canzonetta di Amiens, eppure con
tutte le sue aspirazioni e potenzialità più lungimiranti, con tutte le sue
fantasie, i suoi Orfei pastori, i suoi Eden e le sue età dell’oro, l’unica salvezza
dell’uomo da un destino tragico è, come sapevano i greci, il suo fermo senso
di quel limite che è la sua pace e la sua condanna: «meden agan», mai
troppo. L’idea che l’Arcadia è cosa meramente poetica, messinscena