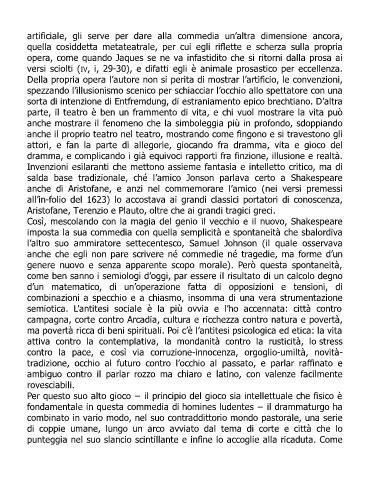Page 1760 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1760
artificiale, gli serve per dare alla commedia un’altra dimensione ancora,
quella cosiddetta metateatrale, per cui egli riflette e scherza sulla propria
opera, come quando Jaques se ne va infastidito che si ritorni dalla prosa ai
versi sciolti (IV, i, 29-30), e difatti egli è animale prosastico per eccellenza.
Della propria opera l’autore non si perita di mostrar l’artificio, le convenzioni,
spezzando l’illusionismo scenico per schiacciar l’occhio allo spettatore con una
sorta di intenzione di Entfremdung, di estraniamento epico brechtiano. D’altra
parte, il teatro è ben un frammento di vita, e chi vuol mostrare la vita può
anche mostrare il fenomeno che la simboleggia più in profondo, sdoppiando
anche il proprio teatro nel teatro, mostrando come fingono e si travestono gli
attori, e fan la parte di allegorie, giocando fra dramma, vita e gioco del
dramma, e complicando i già equivoci rapporti fra finzione, illusione e realtà.
Invenzioni esilaranti che mettono assieme fantasia e intelletto critico, ma di
salda base tradizionale, ché l’amico Jonson parlava certo a Shakespeare
anche di Aristofane, e anzi nel commemorare l’amico (nei versi premessi
all’in-folio del 1623) lo accostava ai grandi classici portatori di conoscenza,
Aristofane, Terenzio e Plauto, oltre che ai grandi tragici greci.
Così, mescolando con la magia del genio il vecchio e il nuovo, Shakespeare
imposta la sua commedia con quella semplicità e spontaneità che sbalordiva
l’altro suo ammiratore settecentesco, Samuel Johnson (il quale osservava
anche che egli non pare scrivere né commedie né tragedie, ma forme d’un
genere nuovo e senza apparente scopo morale). Però questa spontaneità,
come ben sanno i semiologi d’oggi, par essere il risultato di un calcolo degno
d’un matematico, di un’operazione fatta di opposizioni e tensioni, di
combinazioni a specchio e a chiasmo, insomma di una vera strumentazione
semiotica. L’antitesi sociale è la più ovvia e l’ho accennata: città contro
campagna, corte contro Arcadia, cultura e ricchezza contro natura e povertà,
ma povertà ricca di beni spirituali. Poi c’è l’antitesi psicologica ed etica: la vita
attiva contro la contemplativa, la mondanità contro la rusticità, lo stress
contro la pace, e così via corruzione-innocenza, orgoglio-umiltà, novità-
tradizione, occhio al futuro contro l’occhio al passato, e parlar raffinato e
ambiguo contro il parlar rozzo ma chiaro e latino, con valenze facilmente
rovesciabili.
Per questo suo alto gioco − il principio del gioco sia intellettuale che fisico è
fondamentale in questa commedia di homines ludentes − il drammaturgo ha
combinato in vario modo, nel suo contraddittorio mondo pastorale, una serie
di coppie umane, lungo un arco avviato dal tema di corte e città che lo
punteggia nel suo slancio scintillante e infine lo accoglie alla ricaduta. Come