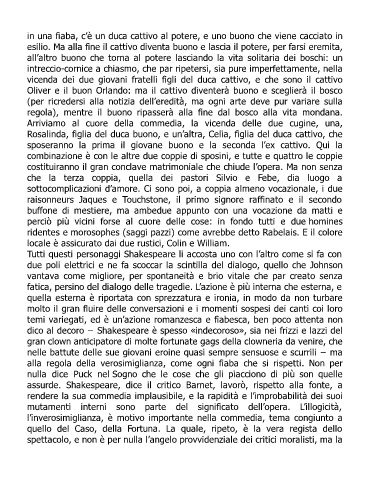Page 1761 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1761
in una fiaba, c’è un duca cattivo al potere, e uno buono che viene cacciato in
esilio. Ma alla fine il cattivo diventa buono e lascia il potere, per farsi eremita,
all’altro buono che torna al potere lasciando la vita solitaria dei boschi: un
intreccio-cornice a chiasmo, che par ripetersi, sia pure imperfettamente, nella
vicenda dei due giovani fratelli figli del duca cattivo, e che sono il cattivo
Oliver e il buon Orlando: ma il cattivo diventerà buono e sceglierà il bosco
(per ricredersi alla notizia dell’eredità, ma ogni arte deve pur variare sulla
regola), mentre il buono ripasserà alla fine dal bosco alla vita mondana.
Arriviamo al cuore della commedia, la vicenda delle due cugine, una,
Rosalinda, figlia del duca buono, e un’altra, Celia, figlia del duca cattivo, che
sposeranno la prima il giovane buono e la seconda l’ex cattivo. Qui la
combinazione è con le altre due coppie di sposini, e tutte e quattro le coppie
costituiranno il gran conclave matrimoniale che chiude l’opera. Ma non senza
che la terza coppia, quella dei pastori Silvio e Febe, dia luogo a
sottocomplicazioni d’amore. Ci sono poi, a coppia almeno vocazionale, i due
raisonneurs Jaques e Touchstone, il primo signore raffinato e il secondo
buffone di mestiere, ma ambedue appunto con una vocazione da matti e
perciò più vicini forse al cuore delle cose: in fondo tutti e due homines
ridentes e morosophes (saggi pazzi) come avrebbe detto Rabelais. E il colore
locale è assicurato dai due rustici, Colin e William.
Tutti questi personaggi Shakespeare li accosta uno con l’altro come si fa con
due poli elettrici e ne fa scoccar la scintilla del dialogo, quello che Johnson
vantava come migliore, per spontaneità e brio vitale che par creato senza
fatica, persino del dialogo delle tragedie. L’azione è più interna che esterna, e
quella esterna è riportata con sprezzatura e ironia, in modo da non turbare
molto il gran fluire delle conversazioni e i momenti sospesi dei canti coi loro
temi variegati, ed è un’azione romanzesca e fiabesca, ben poco attenta non
dico al decoro − Shakespeare è spesso «indecoroso», sia nei frizzi e lazzi del
gran clown anticipatore di molte fortunate gags della clowneria da venire, che
nelle battute delle sue giovani eroine quasi sempre sensuose e scurrili − ma
alla regola della verosimiglianza, come ogni fiaba che si rispetti. Non per
nulla dice Puck nel Sogno che le cose che gli piacciono di più son quelle
assurde. Shakespeare, dice il critico Barnet, lavorò, rispetto alla fonte, a
rendere la sua commedia implausibile, e la rapidità e l’improbabilità dei suoi
mutamenti interni sono parte del significato dell’opera. L’illogicità,
l’inverosimiglianza, è motivo importante nella commedia, tema congiunto a
quello del Caso, della Fortuna. La quale, ripeto, è la vera regista dello
spettacolo, e non è per nulla l’angelo provvidenziale dei critici moralisti, ma la