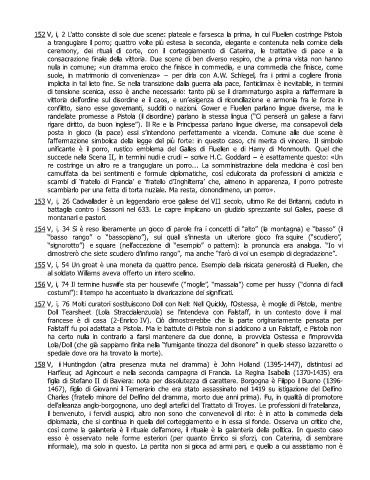Page 1752 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1752
152 V, i, 2 L’atto consiste di sole due scene: plateale e farsesca la prima, in cui Fluellen costringe Pistola
a trangugiare il porro; quattro volte più estesa la seconda, elegante e contenuta nella cornice della
ceremony, dei rituali di corte, con il corteggiamento di Caterina, le trattative di pace e la
consacrazione finale della vittoria. Due scene di ben diverso respiro, che a prima vista non hanno
nulla in comune; «un dramma eroico che finisce in commedia, e una commedia che finisce, come
suole, in matrimonio di convenienza» − per dirla con A.W. Schlegel, fra i primi a cogliere l’ironia
implicita in tal lieto fine. Se nella transizione dalla guerra alla pace, l’anticlimax è inevitabile, in termini
di tensione scenica, esso è anche necessario: tanto più se il drammaturgo aspira a riaffermare la
vittoria dell’ordine sul disordine e il caos, e un’esigenza di riconciliazione e armonia fra le forze in
conflitto, siano esse governanti, sudditi o nazioni. Gower e Fluellen parlano lingue diverse, ma le
randellate promesse a Pistola (il disordine) parlano la stessa lingua (“Ci penserà un gallese a farvi
rigare diritto, da buon inglese”). Il Re e la Principessa parlano lingue diverse, ma consapevoli della
posta in gioco (la pace) essi s’intendono perfettamente a vicenda. Comune alle due scene è
l’affermazione simbolica della legge del più forte: in questo caso, chi merita di vincere. Il simbolo
unificante è il porro, rustico emblema del Galles di Fluellen e di Harry di Monmouth. Quel che
succede nella Scena II, in termini nudi e crudi − scrive H.C. Goddard − è esattamente questo: «Un
re costringe un altro re a trangugiare un porro... La somministrazione della medicina è così ben
camuffata da bei sentimenti e formule diplomatiche, così edulcorata da professioni di amicizia e
scambi di ‘fratello di Francia’ e ‘fratello d’Inghilterra’ che, almeno in apparenza, il porro potreste
scambiarlo per una fetta di torta nuziale. Ma resta, cionondimeno, un porro».
153 V, i, 26 Cadwallader è un leggendario eroe gallese del VII secolo, ultimo Re dei Britanni, caduto in
battaglia contro i Sassoni nel 633. Le capre implicano un giudizio sprezzante sul Galles, paese di
montanari e pastori.
154 V, i, 34 Si è reso liberamente un gioco di parole fra i concetti di “alto” (la montagna) e “basso” (il
“basso rango” o “bassopiano”), sui quali s’innesta un ulteriore gioco fra squire (“scudiero”,
“signorotto”) e square (nell’accezione di “esempio” o pattern): la pronuncia era analoga. “Io vi
dimostrerò che siete scudiero d’infimo rango”, ma anche “farò di voi un esempio di degradazione”.
155 V, i, 54 Un groat è una moneta da quattro pence. Esempio della risicata generosità di Fluellen, che
al soldato Williams aveva offerto un intero scellino.
156 V, i, 74 Il termine huswife sta per housewife (“moglie”, “massaia”) come per hussy (“donna di facili
costumi”): il tempo ha accentuato la divaricazione dei significati.
157 V, i, 76 Molti curatori sostituiscono Doll con Nell: Nell Quickly, l’Ostessa, è moglie di Pistola, mentre
Doll Tearsheet (Lola Straccialenzuola) se l’intendeva con Falstaff, in un contesto dove il mal
francese è di casa (2-Enrico IV). Ciò dimostrerebbe che la parte originariamente pensata per
Falstaff fu poi adattata a Pistola. Ma le battute di Pistola non si addicono a un Falstaff, e Pistola non
ha certo nulla in contrario a farsi mantenere da due donne, la provvida Ostessa e l’improvvida
Lola/Doll (che già sappiamo finita nella “fumigante tinozza del disonore” in quello stesso lazzaretto o
spedale dove ora ha trovato la morte).
158 V, ii Huntingdon (altra presenza muta nel dramma) è John Holland (1395-1447), distintosi ad
Harfleur, ad Agincourt e nella seconda campagna di Francia. La Regina Isabella (1370-1435) era
figlia di Stefano II di Baviera: nota per dissolutezza di carattere. Borgogna è Filippo il Buono (1396-
1467), figlio di Giovanni il Temerario che era stato assassinato nel 1419 su istigazione del Delfino
Charles (fratello minore del Delfino del dramma, morto due anni prima). Fu, in qualità di promotore
dell’alleanza anglo-borgognona, uno degli artefici del Trattato di Troyes. Le professioni di fratellanza,
il benvenuto, i fervidi auspici, altro non sono che convenevoli di rito: è in atto la commedia della
diplomazia, che si continua in quella del corteggiamento e in essa si fonde. Osserva un critico che,
così come la galanteria è il rituale dell’amore, il rituale è la galanteria della politica. In questo caso
esso è osservato nelle forme esteriori (per quanto Enrico si sforzi, con Caterina, di sembrare
informale), ma solo in questo. La partita non si gioca ad armi pari, e quello a cui assistiamo non è