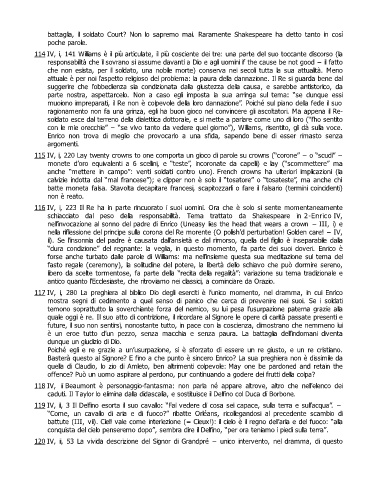Page 1748 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1748
battaglia, il soldato Court? Non lo sapremo mai. Raramente Shakespeare ha detto tanto in così
poche parole.
114 IV, i, 141 Williams è il più articulate, il più cosciente dei tre: una parte del suo toccante discorso (la
responsabilità che il sovrano si assume davanti a Dio e agli uomini if the cause be not good − il fatto
che non esista, per il soldato, una nobile morte) conserva nei secoli tutta la sua attualità. Meno
attuale è per noi l’aspetto religioso del problema: la paura della dannazione. Il Re si guarda bene dal
suggerire che l’obbedienza sia condizionata dalla giustezza della causa, e sarebbe antistorico, da
parte nostra, aspettarcelo. Non a caso egli imposta la sua arringa sul tema: “se dunque essi
muoiono impreparati, il Re non è colpevole della loro dannazione”. Poiché sul piano della fede il suo
ragionamento non fa una grinza, egli ha buon gioco nel convincere gli ascoltatori. Ma appena il Re-
soldato esce dal terreno della dialettica dottorale, e si mette a parlare come uno di loro (“l’ho sentito
con le mie orecchie” − “se vivo tanto da vedere quel giorno”), Williams, risentito, gli dà sulla voce.
Enrico non trova di meglio che provocarlo a una sfida, sapendo bene di esser rimasto senza
argomenti.
115 IV, i, 220 Lay twenty crowns to one comporta un gioco di parole su crowns (“corone” − o “scudi” −
monete d’oro equivalenti a 6 scellini, e “teste”, incoronate da capelli) e lay (“scommettere” ma
anche “mettere in campo”: venti soldati contro uno). French crowns ha ulteriori implicazioni (la
calvizie indotta dal “mal francese”); e clipper non è solo il “tosatore” o “tosateste”, ma anche chi
batte moneta falsa. Stavolta decapitare francesi, scapitozzarli o fare il falsario (termini coincidenti)
non è reato.
116 IV, i, 223 Il Re ha in parte rincuorato i suoi uomini. Ora che è solo si sente momentaneamente
schiacciato dal peso della responsabilità. Tema trattato da Shakespeare in 2-Enrico IV,
nell’invocazione al sonno del padre di Enrico (Uneasy lies the head that wears a crown − III, i) e
nella riflessione del principe sulla corona del Re morente (O polish’d perturbation! Golden care! − IV,
ii). Se l’insonnia del padre è causata dall’ansietà e dal rimorso, quella del figlio è inseparabile dalla
“dura condizione” del regnante: la veglia, in questo momento, fa parte dei suoi doveri. Enrico è
forse anche turbato dalle parole di Williams: ma nell’insieme questa sua meditazione sul tema del
fasto regale (ceremony), la solitudine del potere, la libertà dello schiavo che può dormire sereno,
libero da scelte tormentose, fa parte della “recita della regalità”: variazione su tema tradizionale e
antico quanto l’Ecclesiaste, che ritroviamo nei classici, a cominciare da Orazio.
117 IV, i, 280 La preghiera al biblico Dio degli eserciti è l’unico momento, nel dramma, in cui Enrico
mostra segni di cedimento a quel senso di panico che cerca di prevenire nei suoi. Se i soldati
temono soprattutto la soverchiante forza del nemico, su lui pesa l’usurpazione paterna grazie alla
quale oggi è re. Il suo atto di contrizione, il ricordare al Signore le opere di carità passate presenti e
future, il suo non sentirsi, nonostante tutto, in pace con la coscienza, dimostrano che nemmeno lui
è un eroe tutto d’un pezzo, senza macchia e senza paura. La battaglia dell’indomani diventa
dunque un giudizio di Dio.
Poiché egli e re grazie a un’usurpazione, si è sforzato di essere un re giusto, e un re cristiano.
Basterà questo al Signore? E fino a che punto è sincero Enrico? La sua preghiera non è dissimile da
quella di Claudio, lo zio di Amleto, ben altrimenti colpevole: May one be pardoned and retain the
offence? Può un uomo aspirare al perdono, pur continuando a godere dei frutti della colpa?
118 IV, ii Beaumont è personaggio-fantasma: non parla né appare altrove, altro che nell’elenco dei
caduti. Il Taylor lo elimina dalla didascalia, e sostituisce il Delfino col Duca di Borbone.
119 IV, ii, 3 Il Delfino esorta il suo cavallo: “Fai vedere di cosa sei capace, sulla terra e sull’acqua”. −
“Come, un cavallo di aria e di fuoco?” ribatte Orléans, ricollegandosi al precedente scambio di
battute (III, vii). Ciel! vale come interiezione (= Cieux!): il cielo è il regno dell’aria e del fuoco: “alla
conquista del cielo penseremo dopo”, sembra dire il Delfino, “per ora teniamo i piedi sulla terra”.
120 IV, ii, 53 La vivida descrizione del Signor di Grandpré − unico intervento, nel dramma, di questo