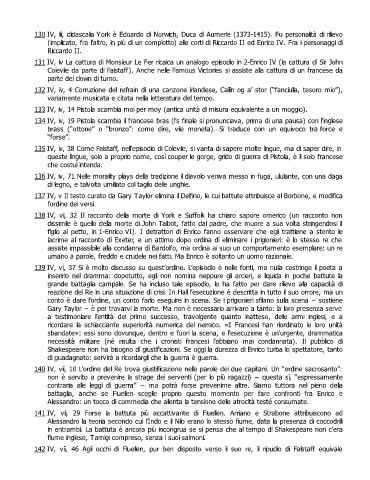Page 1750 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1750
130 IV, iii, didascalia York è Edoardo di Norwich, Duca di Aumerle (1373-1415). Fu personalità di rilievo
(implicato, fra l’altro, in più di un complotto) alle corti di Riccardo II ed Enrico IV. Fra i personaggi di
Riccardo II.
131 IV, iv La cattura di Monsieur Le Fer ricalca un analogo episodio in 2-Enrico IV (la cattura di Sir John
Colevile da parte di Falstaff). Anche nelle Famous Victories si assiste alla cattura di un francese da
parte del clown di turno.
132 IV, iv, 4 Corruzione del refrain di una canzone irlandese, Cailin og a’ stor (“fanciulla, tesoro mio”),
variamente musicata e citata nella letteratura del tempo.
133 IV, iv, 14 Pistola scambia moi per moy (antica unità di misura equivalente a un moggio).
134 IV, iv, 19 Pistola scambia il francese bras (l’s finale si pronunciava, prima di una pausa) con l’inglese
brass (“ottone” o “bronzo”: come dire, vile moneta). Si traduce con un equivoco tra force e
“forse”.
135 IV, iv, 38 Come Falstaff, nell’episodio di Colevile, si vanta di sapere molte lingue, ma di saper dire, in
queste lingue, solo a proprio nome, così couper le gorge, grido di guerra di Pistola, è il solo francese
che costui intenda.
136 IV, iv, 71 Nelle morality plays della tradizione il diavolo veniva messo in fuga, ululante, con una daga
di legno, e talvolta umiliato col taglio delle unghie.
137 IV, v Il testo curato da Gary Taylor elimina il Delfino, le cui battute attribuisce al Borbone, e modifica
l’ordine dei versi.
138 IV, vi, 32 Il racconto della morte di York e Suffolk ha chiaro sapore omerico (un racconto non
dissimile è quello della morte di John Talbot, fatto dal padre, che muore a sua volta stringendosi il
figlio al petto, in 1-Enrico VI). I detrattori di Enrico fanno osservare che egli trattiene a stento le
lacrime al racconto di Exeter, e un attimo dopo ordina di eliminare i prigionieri: è lo stesso re che
assiste impassibile alla condanna di Bardolfo, ma ordina ai suoi un comportamento esemplare: un re
umano a parole, freddo e crudele nei fatti. Ma Enrico è soltanto un uomo razionale.
139 IV, vi, 37 Si è molto discusso su quest’ordine. L’episodio è nelle fonti, ma nulla costringe il poeta a
inserirlo nel dramma: dopotutto, egli non nomina neppure gli arcieri, e liquida in poche battute la
grande battaglia campale. Se ha incluso tale episodio, lo ha fatto per dare rilievo alla capacità di
reazione del Re in una situazione di crisi. In Hall l’esecuzione è descritta in tutto il suo orrore, ma un
conto è dare l’ordine, un conto farlo eseguire in scena. Se i prigionieri sfilano sulla scena − sostiene
Gary Taylor − è per trovarvi la morte. Ma non è necessario arrivare a tanto: la loro presenza serve
a testimoniare l’entità del primo successo, travolgente quanto inatteso, delle armi inglesi, e a
ricordare la schiacciante superiorità numerica del nemico. «I Francesi han riordinato le loro unità
sbandate»: essi sono dovunque, dentro e fuori la scena, e l’esecuzione è un’urgente, drammatica
necessità militare (né risulta che i cronisti francesi l’abbiano mai condannata). Il pubblico di
Shakespeare non ha bisogno di giustificazioni. Se oggi la durezza di Enrico turba lo spettatore, tanto
di guadagnato: servirà a ricordargli che la guerra è guerra.
140 IV, vii, 10 L’ordine del Re trova giustificazione nelle parole dei due capitani. Un “ordine sacrosanto”:
non è servito a prevenire la strage dei serventi (per lo più ragazzi) − questa sì, “espressamente
contraria alle leggi di guerra” − ma potrà forse prevenirne altre. Siamo tuttora nel pieno della
battaglia, anche se Fluellen sceglie proprio questo momento per fare confronti fra Enrico e
Alessandro: un tocco di commedia che allenta la tensione delle atrocità testé consumate.
141 IV, vii, 29 Forse la battuta più accattivante di Fluellen. Arriano e Strabone attribuiscono ad
Alessandro la teoria secondo cui l’Indo e il Nilo erano lo stesso fiume, data la presenza di coccodrilli
in entrambi. La battuta è ancora più incongrua se si pensa che al tempo di Shakespeare non c’era
fiume inglese, Tamigi compreso, senza i suoi salmoni.
142 IV, vii, 46 Agli occhi di Fluellen, pur ben disposto verso il suo re, il ripudio di Falstaff equivale