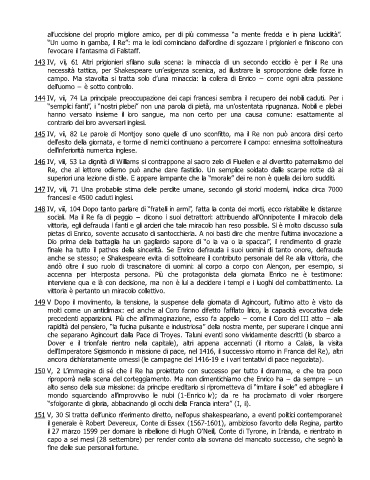Page 1751 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1751
all’uccisione del proprio migliore amico, per di più commessa “a mente fredda e in piena lucidità”.
“Un uomo in gamba, il Re”: ma le lodi cominciano dall’ordine di sgozzare i prigionieri e finiscono con
l’evocare il fantasma di Falstaff.
143 IV, vii, 61 Altri prigionieri sfilano sulla scena: la minaccia di un secondo eccidio è per il Re una
necessità tattica, per Shakespeare un’esigenza scenica, ad illustrare la sproporzione delle forze in
campo. Ma stavolta si tratta solo d’una minaccia: la collera di Enrico − come ogni altra passione
dell’uomo − è sotto controllo.
144 IV, vii, 74 La principale preoccupazione dei capi francesi sembra il recupero dei nobili caduti. Per i
“semplici fanti”, i “nostri plebei” non una parola di pietà, ma un’ostentata ripugnanza. Nobili e plebei
hanno versato insieme il loro sangue, ma non certo per una causa comune: esattamente al
contrario dei loro avversari inglesi.
145 IV, vii, 82 Le parole di Montjoy sono quelle di uno sconfitto, ma il Re non può ancora dirsi certo
dell’esito della giornata, e torme di nemici continuano a percorrere il campo: ennesima sottolineatura
dell’inferiorità numerica inglese.
146 IV, viii, 53 La dignità di Williams si contrappone al sacro zelo di Fluellen e al divertito paternalismo del
Re, che al lettore odierno può anche dare fastidio. Un semplice soldato dalle scarpe rotte dà ai
superiori una lezione di stile. E appare lampante che la “morale” dei re non è quella dei loro sudditi.
147 IV, viii, 71 Una probabile stima delle perdite umane, secondo gli storici moderni, indica circa 7000
francesi e 4500 caduti inglesi.
148 IV, viii, 104 Dopo tanto parlare di “fratelli in armi”, fatta la conta dei morti, ecco ristabilite le distanze
sociali. Ma il Re fa di peggio − dicono i suoi detrattori: attribuendo all’Onnipotente il miracolo della
vittoria, egli defrauda i fanti e gli arcieri che tale miracolo han reso possibile. Si è molto discusso sulla
pietas di Enrico, sovente accusato di santocchieria. A noi basti dire che mentre l’ultima invocazione a
Dio prima della battaglia ha un gagliardo sapore di “o la va o la spacca!”, il rendimento di grazie
finale ha tutto il pathos della sincerità. Se Enrico defrauda i suoi uomini di tanto onore, defrauda
anche se stesso; e Shakespeare evita di sottolineare il contributo personale del Re alla vittoria, che
andò oltre il suo ruolo di trascinatore di uomini: al corpo a corpo con Alençon, per esempio, si
accenna per interposta persona. Più che protagonista della giornata Enrico ne è testimone:
interviene qua e là con decisione, ma non è lui a decidere i tempi e i luoghi del combattimento. La
vittoria è pertanto un miracolo collettivo.
149 V Dopo il movimento, la tensione, la suspense della giornata di Agincourt, l’ultimo atto è visto da
molti come un anticlimax: ed anche al Coro fanno difetto l’afflato lirico, la capacità evocativa delle
precedenti apparizioni. Più che all’immaginazione, esso fa appello − come il Coro del III atto − alla
rapidità del pensiero, “la fucina pulsante e industriosa” della nostra mente, per superare i cinque anni
che separano Agincourt dalla Pace di Troyes. Taluni eventi sono vividamente descritti (lo sbarco a
Dover e il trionfale rientro nella capitale), altri appena accennati (il ritorno a Calais, la visita
dell’Imperatore Sigismondo in missione di pace, nel 1416, il successivo ritorno in Francia del Re), altri
ancora dichiaratamente omessi (le campagne del 1416-19 e i vari tentativi di pace negoziata).
150 V, 2 L’immagine di sé che il Re ha proiettato con successo per tutto il dramma, e che tra poco
riproporrà nella scena del corteggiamento. Ma non dimentichiamo che Enrico ha − da sempre − un
alto senso della sua missione: da principe ereditario si riprometteva di “imitare il sole” ed abbagliare il
mondo squarciando all’improvviso le nubi (1-Enrico iv); da re ha proclamato di voler risorgere
“sfolgorante di gloria, abbacinando gli occhi della Francia intera” (I, ii).
151 V, 30 Si tratta dell’unico riferimento diretto, nell’opus shakespeariano, a eventi politici contemporanei:
il generale è Robert Devereux, Conte di Essex (1567-1601), ambizioso favorito della Regina, partito
il 27 marzo 1599 per domare la ribellione di Hugh O’Neill, Conte di Tyrone, in Irlanda, e rientrato in
capo a sei mesi (28 settembre) per render conto alla sovrana del mancato successo, che segnò la
fine delle sue personali fortune.