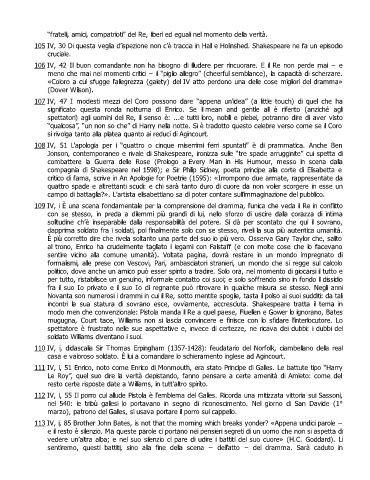Page 1747 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1747
“fratelli, amici, compatrioti” del Re, liberi ed eguali nel momento della verità.
105 IV, 30 Di questa veglia d’ispezione non c’è traccia in Hall e Holinshed. Shakespeare ne fa un episodio
cruciale.
106 IV, 42 Il buon comandante non ha bisogno di illudere per rincuorare. E il Re non perde mai − e
meno che mai nei momenti critici − il “piglio allegro” (cheerful semblance), la capacità di scherzare.
«Coloro a cui sfugge l’allegrezza (gaiety) del IV atto perdono una delle cose migliori del dramma»
(Dover Wilson).
107 IV, 47 I modesti mezzi del Coro possono dare “appena un’idea” (a little touch) di quel che ha
significato questa ronda notturna di Enrico. Se il mean and gentle all è riferito (anziché agli
spettatori) agli uomini del Re, il senso è: ...e tutti loro, nobili e plebei, potranno dire di aver visto
“qualcosa”, “un non so che” di Harry nella notte. Si è tradotto questo celebre verso come se il Coro
si rivolga tanto alla platea quanto ai reduci di Agincourt.
108 IV, 51 L’apologia per i “quattro o cinque miserrimi ferri spuntati” è di prammatica. Anche Ben
Jonson, contemporaneo e rivale di Shakespeare, ironizza sulle “tre spade arrugginite” cui spetta di
combattere la Guerra delle Rose (Prologo a Every Man in His Humour, messo in scena dalla
compagnia di Shakespeare nel 1598); e Sir Philip Sidney, poeta principe alla corte di Elisabetta e
critico di fama, scrive in An Apologie for Poetrie (1595): «Irrompono due armate, rappresentate da
quattro spade e altrettanti scudi: e chi sarà tanto duro di cuore da non voler scorgere in esse un
campo di battaglia?». L’artista elisabettiano sa di poter contare sull’immaginazione del pubblico.
109 IV, i È una scena fondamentale per la comprensione del dramma, l’unica che veda il Re in conflitto
con se stesso, in preda a dilemmi più grandi di lui, nello sforzo di uscire dalla corazza di intima
solitudine ch’è inseparabile dalla responsabilità del potere. Si dà per scontato che qui il sovrano,
dapprima soldato fra i soldati, poi finalmente solo con se stesso, riveli la sua più autentica umanità.
È più corretto dire che rivela soltanto una parte del suo io più vero. Osserva Gary Taylor che, salito
al trono, Enrico ha crudelmente tagliato i legami con Falstaff (e con molte cose che lo facevano
sentire vicino alla comune umanità). Voltata pagina, dovrà restare in un mondo impregnato di
formalismi, alle prese con Vescovi, Pari, ambasciatori stranieri, un mondo che si regge sul calcolo
politico, dove anche un amico può esser spinto a tradire. Solo ora, nel momento di giocarsi il tutto e
per tutto, ristabilisce un genuino, informale contatto coi suoi; e solo soffrendo sino in fondo il dissidio
fra il suo Io privato e il suo Io di regnante può ritrovare in qualche misura se stesso. Negli anni
Novanta son numerosi i drammi in cui il Re, sotto mentite spoglie, tasta il polso ai suoi sudditi: da tali
incontri la sua statura di sovrano esce, ovviamente, accresciuta. Shakespeare tratta il tema in
modo men che convenzionale: Pistola manda il Re a quel paese, Fluellen e Gower lo ignorano, Bates
mugugna, Court tace, Williams non si lascia convincere e finisce con lo sfidare l’interlocutore. Lo
spettatore è frustrato nelle sue aspettative e, invece di certezze, ne ricava dei dubbi: i dubbi del
soldato Williams diventano i suoi.
110 IV, i, didascalia Sir Thomas Erpingham (1357-1428): feudatario del Norfolk, ciambellano della real
casa e valoroso soldato. È lui a comandare lo schieramento inglese ad Agincourt.
111 IV, i, 51 Enrico, noto come Enrico di Monmouth, era stato Principe di Galles. Le battute tipo “Harry
Le Roy”, quel suo dire la verità depistando, fanno pensare a certe amenità di Amleto: come del
resto certe risposte date a Williams, in tutt’altro spirito.
112 IV, i, 55 Il porro cui allude Pistola è l’emblema del Galles. Ricorda una mitizzata vittoria sui Sassoni,
nel 540: le tribù gallesi lo portavano in segno di riconoscimento. Nel giorno di San Davide (1°
marzo), patrono del Galles, si usava portare il porro sul cappello.
113 IV, i, 85 Brother John Bates, is not that the morning which breaks yonder? «Appena undici parole −
e il resto è silenzio. Ma queste parole ci portano nei pensieri segreti di un uomo che non si aspetta di
vedere un’altra alba; e nel suo silenzio ci pare di udire i battiti del suo cuore» (H.C. Goddard). Li
sentiremo, questi battiti, sino alla fine della scena − dell’atto − del dramma. Sarà caduto in