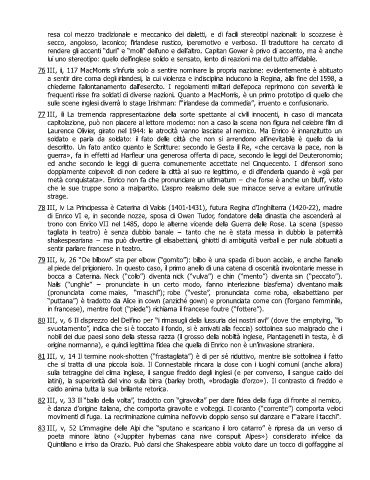Page 1744 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1744
resa col mezzo tradizionale e meccanico dei dialetti, e di facili stereotipi nazionali: lo scozzese è
secco, angoloso, laconico; l’irlandese rustico, iperemotivo e verboso. Il traduttore ha cercato di
rendere gli accenti “duri” e “molli” dell’uno e dell’altro. Capitan Gower è privo di accento, ma è anche
lui uno stereotipo: quello dell’inglese solido e sensato, lento di reazioni ma del tutto affidabile.
76 III, ii, 117 MacMorris s’infuria solo a sentire nominare la propria nazione: evidentemente è abituato
a sentir dire corna degli irlandesi, la cui violenza e indisciplina inducono la Regina, alla fine del 1598, a
chiederne l’allontanamento dall’esercito. I regolamenti militari dell’epoca reprimono con severità le
frequenti risse fra soldati di diverse nazioni. Quanto a MacMorris, è un primo prototipo di quello che
sulle scene inglesi diverrà lo stage Irishman: l’“irlandese da commedia”, irruento e confusionario.
77 III, iii La tremenda rappresentazione della sorte spettante ai civili innocenti, in caso di mancata
capitolazione, può non piacere al lettore moderno: non a caso la scena non figura nel celebre film di
Laurence Olivier, girato nel 1944: le atrocità vanno lasciate al nemico. Ma Enrico è innanzitutto un
soldato e parla da soldato: il fato delle città che non si arrendono all’inevitabile è quello da lui
descritto. Un fato antico quanto le Scritture: secondo le Gesta il Re, «che cercava la pace, non la
guerra», fa in effetti ad Harfleur una generosa offerta di pace, secondo le leggi del Deuteronomio;
ed anche secondo le leggi di guerra comunemente accettate nel Cinquecento. I difensori sono
doppiamente colpevoli: di non cedere la città al suo re legittimo, e di difenderla quando è «già per
metà conquistata». Enrico non fa che pronunciare un ultimatum − che forse è anche un bluff, visto
che le sue truppe sono a malpartito. L’aspro realismo delle sue minacce serve a evitare un’inutile
strage.
78 III, iv La Principessa è Caterina di Valois (1401-1431), futura Regina d’Inghilterra (1420-22), madre
di Enrico VI e, in seconde nozze, sposa di Owen Tudor, fondatore della dinastia che ascenderà al
trono con Enrico VII nel 1485, dopo le alterne vicende della Guerra delle Rose. La scena (spesso
tagliata in teatro) è senza dubbio banale − tanto che ne è stata messa in dubbio la paternità
shakespeariana − ma può divertire gli elisabettiani, ghiotti di ambiguità verbali e per nulla abituati a
sentir parlare francese in teatro.
79 III, iv, 26 “De bilbow” sta per elbow (“gomito”): bilbo è una spada di buon acciaio, e anche l’anello
al piede del prigioniero. In questo caso, il primo anello di una catena di oscenità involontarie messe in
bocca a Caterina. Neck (“collo”) diventa nick (“vulva”) e chin (“mento”) diventa sin (“peccato”).
Nails (“unghie” − pronunciate in un certo modo, fanno interiezione blasfema) diventano mails
(pronunciata come males, “maschi”); robe (“veste”, pronunciata come roba, elisabettiano per
“puttana”) è tradotto da Alice in cown (anziché gown) e pronunciata come con (l’organo femminile,
in francese), mentre foot (“piede”) richiama il francese foutre (“fottere”).
80 III, v, 6 Il disprezzo del Delfino per “i rimasugli della lussuria dei nostri avi” (dove the emptying, “lo
svuotamento”, indica che si è toccato il fondo, si è arrivati alla feccia) sottolinea suo malgrado che i
nobili dei due paesi sono della stessa razza (il grosso della nobiltà inglese, Plantageneti in testa, è di
origine normanna), e quindi legittima l’idea che quella di Enrico non è un’invasione straniera.
81 III, v, 14 Il termine nook-shotten (“frastagliata”) è di per sé riduttivo, mentre isle sottolinea il fatto
che si tratta di una piccola isola. Il Connestabile rincara la dose con i luoghi comuni (anche allora)
sulla tetraggine del clima inglese, il sangue freddo degli inglesi (e per converso, il sangue caldo dei
latini), la superiorità del vino sulla birra (barley broth, «brodaglia d’orzo»). Il contrasto di freddo e
caldo anima tutta la sua brillante retorica.
82 III, v, 33 Il “ballo della volta”, tradotto con “giravolta” per dare l’idea della fuga di fronte al nemico,
è danza d’origine italiana, che comporta giravolte e volteggi. Il coranto (“corrente”) comporta veloci
movimenti di fuga. La recriminazione culmina nell’ovvio doppio senso sul danzare e l’“alzare i tacchi”.
83 III, v, 52 L’immagine delle Alpi che “sputano e scaricano il loro catarro” è ripresa da un verso di
poeta minore latino («Juppiter hybernas cana nive conspuit Alpes») considerato infelice da
Quintiliano e irriso da Orazio. Può darsi che Shakespeare abbia voluto dare un tocco di goffaggine al