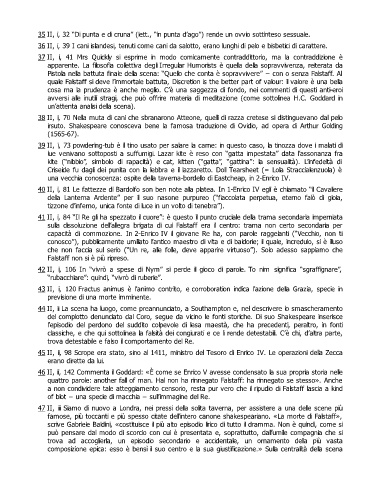Page 1740 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1740
35 II, i, 32 “Di punta e di cruna” (lett., “in punta d’ago”) rende un ovvio sottinteso sessuale.
36 II, i, 39 I cani islandesi, tenuti come cani da salotto, erano lunghi di pelo e bisbetici di carattere.
37 II, i, 41 Mrs Quickly si esprime in modo comicamente contraddittorio, ma la contraddizione è
apparente. La filosofia collettiva degli Irregular Humorists è quella della sopravvivenza, reiterata da
Pistola nella battuta finale della scena: “Quello che conta è sopravvivere” − con o senza Falstaff. Al
quale Falstaff si deve l’immortale battuta, Discretion is the better part of valour: il valore è una bella
cosa ma la prudenza è anche meglio. C’è una saggezza di fondo, nei commenti di questi anti-eroi
avversi alle inutili stragi, che può offrire materia di meditazione (come sottolinea H.C. Goddard in
un’attenta analisi della scena).
38 II, i, 70 Nella muta di cani che sbranarono Atteone, quelli di razza cretese si distinguevano dal pelo
irsuto. Shakespeare conosceva bene la famosa traduzione di Ovidio, ad opera di Arthur Golding
(1565-67).
39 II, i, 73 powdering-tub è il tino usato per salare la carne: in questo caso, la tinozza dove i malati di
lue venivano sottoposti a suffumigi. Lazar kite è reso con “gatta impestata” data l’assonanza fra
kite (“nibbio”, simbolo di rapacità) e cat, kitten (“gatta”, “gattina”: la sensualità). L’infedeltà di
Criseide fu dagli dei punita con la lebbra e il lazzaretto. Doll Tearsheet (= Lola Straccialenzuola) è
una vecchia conoscenza: ospite della taverna-bordello di Eastcheap, in 2-Enrico IV.
40 II, i, 81 Le fattezze di Bardolfo son ben note alla platea. In 1-Enrico IV egli è chiamato “il Cavaliere
della Lanterna Ardente” per il suo nasone purpureo (“fiaccolata perpetua, eterno falò di gioia,
tizzone d’inferno, unica fonte di luce in un volto di tenebra”).
41 II, i, 84 “Il Re gli ha spezzato il cuore”: è questo il punto cruciale della trama secondaria imperniata
sulla dissoluzione dell’allegra brigata di cui Falstaff era il centro: trama non certo secondaria per
capacità di commozione. In 2-Enrico IV il giovane Re ha, con parole raggelanti (“Vecchio, non ti
conosco”), pubblicamente umiliato l’antico maestro di vita e di baldorie; il quale, incredulo, si è illuso
che non faccia sul serio (“Un re, alle folle, deve apparire virtuoso”). Solo adesso sappiamo che
Falstaff non si è più ripreso.
42 II, i, 106 In “vivrò a spese di Nym” si perde il gioco di parole. To nim significa “sgraffignare”,
“rubacchiare”: quindi, “vivrò di ruberie”.
43 II, i, 120 Fractus animus è l’animo contrito, e corroboration indica l’azione della Grazia, specie in
previsione di una morte imminente.
44 II, ii La scena ha luogo, come preannunciato, a Southampton e, nel descrivere lo smascheramento
del complotto denunciato dal Coro, segue da vicino le fonti storiche. Di suo Shakespeare inserisce
l’episodio del perdono del suddito colpevole di lesa maestà, che ha precedenti, peraltro, in fonti
classiche, e che qui sottolinea la falsità dei congiurati e ce li rende detestabili. C’è chi, d’altra parte,
trova detestabile e falso il comportamento del Re.
45 II, ii, 98 Scrope era stato, sino al 1411, ministro del Tesoro di Enrico IV. Le operazioni della Zecca
erano dirette da lui.
46 II, ii, 142 Commenta il Goddard: «È come se Enrico V avesse condensato la sua propria storia nelle
quattro parole: another fall of man. Hal non ha rinnegato Falstaff: ha rinnegato se stesso». Anche
a non condividere tale atteggiamento censorio, resta pur vero che il ripudio di Falstaff lascia a kind
of blot − una specie di macchia − sull’immagine del Re.
47 II, iii Siamo di nuovo a Londra, nei pressi della solita taverna, per assistere a una delle scene più
famose, più toccanti e più spesso citate dell’intero canone shakespeariano. «La morte di Falstaff»,
scrive Gabriele Baldini, «costituisce il più alto episodio lirico di tutto il dramma. Non è quindi, come si
può pensare dal modo di scorcio con cui è presentata e, soprattutto, dall’umile compagnia che si
trova ad accoglierla, un episodio secondario e accidentale, un ornamento della più vasta
composizione epica: esso è bensì il suo centro e la sua giustificazione.» Sulla centralità della scena