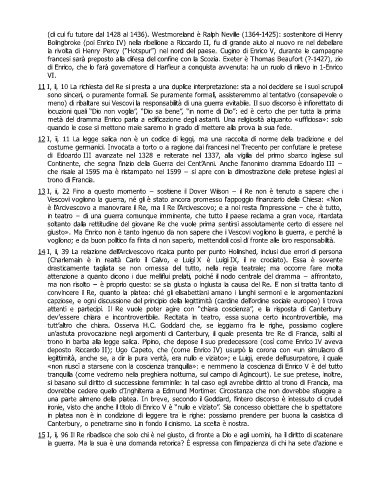Page 1737 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1737
(di cui fu tutore dal 1428 al 1436). Westmoreland è Ralph Neville (1364-1425): sostenitore di Henry
Bolingbroke (poi Enrico IV) nella ribellione a Riccardo II, fu di grande aiuto al nuovo re nel debellare
la rivolta di Henry Percy (“Hotspur”) nel nord del paese. Cugino di Enrico V, durante le campagne
francesi sarà preposto alla difesa del confine con la Scozia. Exeter è Thomas Beaufort (?-1427), zio
di Enrico, che lo farà governatore di Harfleur a conquista avvenuta: ha un ruolo di rilievo in 1-Enrico
VI.
11 I, ii, 10 La richiesta del Re si presta a una duplice interpretazione: sta a noi decidere se i suoi scrupoli
sono sinceri, o puramente formali. Se puramente formali, assisteremmo al tentativo (consapevole o
meno) di ribaltare sui Vescovi la responsabilità di una guerra evitabile. Il suo discorso è infiorettato di
locuzioni quali “Dio non voglia”, “Dio sa bene”, “in nome di Dio”: ed è certo che per tutta la prima
metà del dramma Enrico parla a edificazione degli astanti. Una religiosità alquanto «ufficiosa»: solo
quando le cose si mettono male saremo in grado di mettere alla prova la sua fede.
12 I, ii, 11 La legge salica non è un codice di leggi, ma una raccolta di norme della tradizione e del
costume germanici. Invocata a torto o a ragione dai francesi nel Trecento per confutare le pretese
di Edoardo III avanzate nel 1328 e reiterate nel 1337, alla vigilia del primo sbarco inglese sul
Continente, che segna l’inizio della Guerra dei Cent’Anni. Anche l’anonimo dramma Edoardo III −
che risale al 1595 ma è ristampato nel 1599 − si apre con la dimostrazione delle pretese inglesi al
trono di Francia.
13 I, ii, 22 Fino a questo momento − sostiene il Dover Wilson − il Re non è tenuto a sapere che i
Vescovi vogliono la guerra, né gli è stato ancora promesso l’appoggio finanziario della Chiesa: «Non
è l’Arcivescovo a manovrare il Re, ma il Re l’Arcivescovo; e a noi resta l’impressione − che è tutto,
in teatro − di una guerra comunque imminente, che tutto il paese reclama a gran voce, ritardata
soltanto dalla rettitudine del giovane Re che vuole prima sentirsi assolutamente certo di essere nel
giusto». Ma Enrico non è tanto ingenuo da non sapere che i Vescovi vogliono la guerra, e perché la
vogliono; e da buon politico fa finta di non saperlo, mettendoli così di fronte alle loro responsabilità.
14 I, ii, 39 La relazione dell’Arcivescovo ricalca punto per punto Holinshed, inclusi due errori di persona
(Charlemain è in realtà Carlo il Calvo, e Luigi X è Luigi IX, il re crociato). Essa è sovente
drasticamente tagliata se non omessa del tutto, nella regia teatrale; ma occorre fare molta
attenzione a quanto dicono i due melliflui prelati, poiché il nodo centrale del dramma − affrontato,
ma non risolto − è proprio questo: se sia giusta o ingiusta la causa del Re. E non si tratta tanto di
convincere il Re, quanto la platea: ché gli elisabettiani amano i lunghi sermoni e le argomentazioni
capziose, e ogni discussione del principio della legittimità (cardine dell’ordine sociale europeo) li trova
attenti e partecipi. Il Re vuole poter agire con “chiara coscienza”, e la risposta di Canterbury
dev’essere chiara e incontrovertibile. Recitata in teatro, essa suona certo incontrovertibile, ma
tutt’altro che chiara. Osserva H.C. Goddard che, se leggiamo fra le righe, possiamo cogliere
un’astuta provocazione negli argomenti di Canterbury, il quale presenta tre Re di Francia, saliti al
trono in barba alla legge salica. Pipino, che depose il suo predecessore (così come Enrico IV aveva
deposto Riccardo II); Ugo Capeto, che (come Enrico IV) usurpò la corona con «un simulacro di
legittimità, anche se, a dir la pura verità, era nullo e viziato»; e Luigi, erede dell’usurpatore, il quale
«non riuscì a starsene con la coscienza tranquilla»: e nemmeno la coscienza di Enrico V è del tutto
tranquilla (come vedremo nella preghiera notturna, sul campo di Agincourt). Le sue pretese, inoltre,
si basano sul diritto di successione femminile: in tal caso egli avrebbe diritto al trono di Francia, ma
dovrebbe cedere quello d’Inghilterra a Edmund Mortimer. Circostanza che non dovrebbe sfuggire a
una parte almeno della platea. In breve, secondo il Goddard, l’intero discorso è intessuto di crudeli
ironie, visto che anche il titolo di Enrico V è “nullo e viziato”. Sia concesso obiettare che lo spettatore
in platea non è in condizione di leggere tra le righe: possiamo prendere per buona la casistica di
Canterbury, o penetrarne sino in fondo il cinismo. La scelta è nostra.
15 I, ii, 96 Il Re ribadisce che solo chi è nel giusto, di fronte a Dio e agli uomini, ha il diritto di scatenare
la guerra. Ma la sua è una domanda retorica? È espressa con l’impazienza di chi ha sete d’azione e