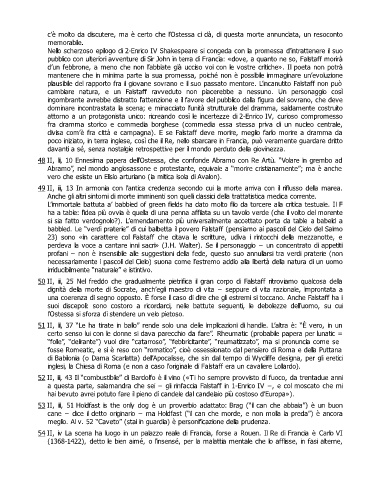Page 1741 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1741
c’è molto da discutere, ma è certo che l’Ostessa ci dà, di questa morte annunciata, un resoconto
memorabile.
Nello scherzoso epilogo di 2-Enrico IV Shakespeare si congeda con la promessa d’intrattenere il suo
pubblico con ulteriori avventure di Sir John in terra di Francia: «dove, a quanto ne so, Falstaff morirà
d’un febbrone, a meno che non l’abbiate già ucciso voi con le vostre critiche». Il poeta non potrà
mantenere che in minima parte la sua promessa, poiché non è possibile immaginare un’evoluzione
plausibile del rapporto fra il giovane sovrano e il suo passato mentore. L’incanutito Falstaff non può
cambiare natura, e un Falstaff ravveduto non piacerebbe a nessuno. Un personaggio così
ingombrante avrebbe distratto l’attenzione e il favore del pubblico dalla figura del sovrano, che deve
dominare incontrastata la scena; e minacciato l’unità strutturale del dramma, saldamente costruito
attorno a un protagonista unico: ricreando così le incertezze di 2-Enrico IV, curioso compromesso
fra dramma storico e commedia borghese (commedia essa stessa priva di un nucleo centrale,
divisa com’è fra città e campagna). E se Falstaff deve morire, meglio farlo morire a dramma da
poco iniziato, in terra inglese, così che il Re, nello sbarcare in Francia, può veramente guardare dritto
davanti a sé, senza nostalgie retrospettive per il mondo perduto della giovinezza.
48 II, iii, 10 Ennesima papera dell’Ostessa, che confonde Abramo con Re Artù. “Volare in grembo ad
Abramo”, nel mondo anglosassone e protestante, equivale a “morire cristianamente”; ma è anche
vero che esiste un Elisio arturiano (la mitica isola di Avalon).
49 II, iii, 13 In armonia con l’antica credenza secondo cui la morte arriva con il riflusso della marea.
Anche gli altri sintomi di morte imminenti son quelli classici della trattatistica medica corrente.
L’immortale battuta a’ babbled of green fields ha dato molto filo da torcere alla critica testuale. Il F
ha a table: l’idea più ovvia è quella di una penna affilata su un tavolo verde (che il volto del morente
si sia fatto verdognolo?). L’emendamento più universalmente accettato porta da table a babeld a
babbled. Le “verdi praterie” di cui balbetta il povero Falstaff (pensiamo ai pascoli del Cielo del Salmo
23) sono «in carattere col Falstaff che citava le scritture, udiva i rintocchi della mezzanotte, e
perdeva la voce a cantare inni sacri» (J.H. Walter). Se il personaggio − un concentrato di appetiti
profani − non è insensibile alle suggestioni della fede, questo suo annullarsi tra verdi praterie (non
necessariamente i pascoli del Cielo) suona come l’estremo addio alla libertà della natura di un uomo
irriducibilmente “naturale” e istintivo.
50 II, iii, 25 Nel freddo che gradualmente pietrifica il gran corpo di Falstaff ritroviamo qualcosa della
dignità della morte di Socrate, anch’egli maestro di vita − seppure di vita razionale, improntata a
una coerenza di segno opposto. È forse il caso di dire che gli estremi si toccano. Anche Falstaff ha i
suoi discepoli: sono costoro a ricordarci, nelle battute seguenti, le debolezze dell’uomo, su cui
l’Ostessa si sforza di stendere un velo pietoso.
51 II, iii, 37 “Le ha tirate in ballo” rende solo una delle implicazioni di handle. L’altra è: “È vero, in un
certo senso lui con le donne si dava parecchio da fare”. Rheumatic (probabile papera per lunatic =
“folle”, “delirante”) vuol dire “catarroso”, “febbricitante”, “reumatizzato”, ma si pronuncia come se
fosse Romeatic, e si è reso con “romatico”, cioè ossessionato dal pensiero di Roma e della Puttana
di Babilonia (o Dama Scarlatta) dell’Apocalisse, che sin dal tempo di Wycliffe designa, per gli eretici
inglesi, la Chiesa di Roma (e non a caso l’originale di Falstaff era un cavaliere Lollardo).
52 II, iii, 43 Il “combustibile” di Bardolfo è il vino («Ti ho sempre provvisto di fuoco, da trentadue anni
a questa parte, salamandra che sei − gli rinfaccia Falstaff in 1-Enrico IV −, e col moscato che mi
hai bevuto avrei potuto fare il pieno di candele dal candelaio più costoso d’Europa»).
53 II, iii, 51 Holdfast is the only dog è un proverbio adattato: Brag (“il can che abbaia”) è un buon
cane − dice il detto originario − ma Holdfast (“il can che morde, e non molla la preda”) è ancora
meglio. Al v. 52 “Caveto” (stai in guardia) è personificazione della prudenza.
54 II, iv La scena ha luogo in un palazzo reale di Francia, forse a Rouen. Il Re di Francia è Carlo VI
(1368-1422), detto le bien aimé, o l’insensé, per la malattia mentale che lo afflisse, in fasi alterne,