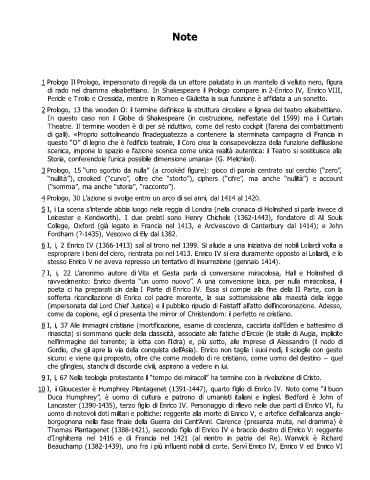Page 1736 - Shakespeare - Vol. 2
P. 1736
Note
1 Prologo Il Prologo, impersonato di regola da un attore paludato in un mantello di velluto nero, figura
di rado nel dramma elisabettiano. In Shakespeare il Prologo compare in 2-Enrico IV, Enrico VIII,
Pericle e Troilo e Cressida, mentre in Romeo e Giulietta la sua funzione è affidata a un sonetto.
2 Prologo, 13 this wooden O: il termine definisce la struttura circolare e lignea del teatro elisabettiano.
In questo caso non il Globe di Shakespeare (in costruzione, nell’estate del 1599) ma il Curtain
Theatre. Il termine wooden è di per sé riduttivo, come del resto cockpit (l’arena dei combattimenti
di galli). «Proprio sottolineando l’inadeguatezza a contenere la sterminata campagna di Francia in
questo “O” di legno che è l’edificio teatrale, il Coro crea la consapevolezza della funzione dell’illusione
scenica, impone lo spazio e l’azione scenica come unica realtà autentica: il Teatro si sostituisce alla
Storia, conferendole l’unica possibile dimensione umana» (G. Melchiori).
3 Prologo, 15 “uno sgorbio da nulla” (a crookèd figure): gioco di parola centrato sul cerchio (“zero”,
“nullità”), crooked (“curvo”, oltre che “storto”), ciphers (“cifre”, ma anche “nullità”) e account
(“somma”, ma anche “storia”, “racconto”).
4 Prologo, 30 L’azione si svolge entro un arco di sei anni, dal 1414 al 1420.
5 I, i La scena s’intende abbia luogo nella reggia di Londra (nella cronaca di Holinshed si parla invece di
Leicester e Kendworth). I due prelati sono Henry Chichele (1362-1443), fondatore di All Souls
College, Oxford (già legato in Francia nel 1413, e Arcivescovo di Canterbury dal 1414); e John
Fordham (?-1435), Vescovo di Ely dal 1382.
6 I, i, 2 Enrico IV (1366-1413) salì al trono nel 1399. Si allude a una iniziativa dei nobili Lollardi volta a
espropriare i beni del clero, rientrata poi nel 1413. Enrico IV si era duramente opposto ai Lollardi, e lo
stesso Enrico V ne aveva represso un tentativo di insurrezione (gennaio 1414).
7 I, i, 22 L’anonimo autore di Vita et Gesta parla di conversione miracolosa, Hall e Holinshed di
ravvedimento: Enrico diventa “un uomo nuovo”. A una conversione laica, per nulla miracolosa, il
poeta ci ha preparati sin dalla I Parte di Enrico IV. Essa si compie alla fine della II Parte, con la
sofferta riconciliazione di Enrico col padre morente, la sua sottomissione alla maestà della legge
(impersonata dal Lord Chief Justice) e il pubblico ripudio di Falstaff all’atto dell’incoronazione. Adesso,
come da copione, egli ci presenta the mirror of Christendom: il perfetto re cristiano.
8 I, i, 37 Alle immagini cristiane (mortificazione, esame di coscienza, cacciata dall’Eden e battesimo di
rinascita) si sommano quelle della classicità, associate alle fatiche d’Ercole (le stalle di Augia, implicite
nell’immagine del torrente; la lotta con l’Idra) e, più sotto, alle imprese di Alessandro (il nodo di
Gordio, che gli apre la via della conquista dell’Asia). Enrico non taglia i suoi nodi, li scioglie con gesto
sicuro: e viene qui proposto, oltre che come modello di re cristiano, come uomo del destino − quel
che gl’inglesi, stanchi di discordie civili, aspirano a vedere in lui.
9 I, i, 67 Nella teologia protestante il “tempo dei miracoli” ha termine con la rivelazione di Cristo.
10 I, ii Gloucester è Humphrey Plantagenet (1391-1447), quarto figlio di Enrico IV. Noto come “il buon
Duca Humphrey”, è uomo di cultura e patrono di umanisti italiani e inglesi. Bedford è John of
Lancaster (1390-1435), terzo figlio di Enrico IV. Personaggio di rilievo nelle due parti di Enrico VI, fu
uomo di notevoli doti militari e politiche: reggente alla morte di Enrico V, e artefice dell’alleanza anglo-
borgognona nella fase finale della Guerra dei Cent’Anni. Clarence (presenza muta, nel dramma) è
Thomas Plantagenet (1388-1421), secondo figlio di Enrico IV e braccio destro di Enrico V: reggente
d’Inghilterra nel 1416 e di Francia nel 1421 (al rientro in patria del Re). Warwick è Richard
Beauchamp (1382-1439), uno fra i più influenti nobili di corte. Servì Enrico IV, Enrico V ed Enrico VI