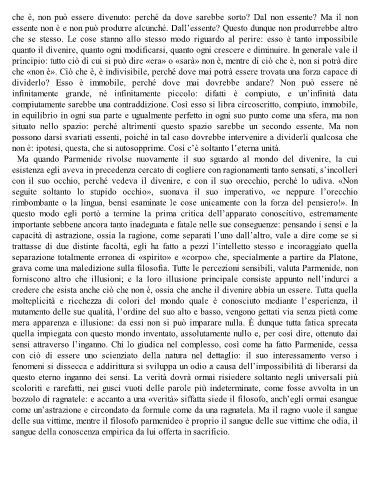Page 59 - Nietzsche - Su verità e menzogna
P. 59
che è, non può essere divenuto: perché da dove sarebbe sorto? Dal non essente? Ma il non
essente non è e non può produrre alcunché. Dall’essente? Questo dunque non produrrebbe altro
che se stesso. Le cose stanno allo stesso modo riguardo al perire: esso è tanto impossibile
quanto il divenire, quanto ogni modificarsi, quanto ogni crescere e diminuire. In generale vale il
principio: tutto ciò di cui si può dire «era» o «sarà» non è, mentre di ciò che è, non si potrà dire
che «non è». Ciò che è, è indivisibile, perché dove mai potrà essere trovata una forza capace di
dividerlo? Esso è immobile, perché dove mai dovrebbe andare? Non può essere né
infinitamente grande, né infinitamente piccolo: difatti è compiuto, e un’infinità data
compiutamente sarebbe una contraddizione. Così esso si libra circoscritto, compiuto, immobile,
in equilibrio in ogni sua parte e ugualmente perfetto in ogni suo punto come una sfera, ma non
situato nello spazio: perché altrimenti questo spazio sarebbe un secondo essente. Ma non
possono darsi svariati essenti, poiché in tal caso dovrebbe intervenire a dividerli qualcosa che
non è: ipotesi, questa, che si autosopprime. Così c’è soltanto l’eterna unità.
Ma quando Parmenide rivolse nuovamente il suo sguardo al mondo del divenire, la cui
esistenza egli aveva in precedenza cercato di cogliere con ragionamenti tanto sensati, s’incollerì
con il suo occhio, perché vedeva il divenire, e con il suo orecchio, perché lo udiva. «Non
seguite soltanto lo stupido occhio», suonava il suo imperativo, «e neppure l’orecchio
rimbombante o la lingua, bensì esaminate le cose unicamente con la forza del pensiero!». In
questo modo egli portò a termine la prima critica dell’apparato conoscitivo, estremamente
importante sebbene ancora tanto inadeguata e fatale nelle sue conseguenze: pensando i sensi e la
capacità di astrazione, ossia la ragione, come separati l’uno dall’altro, vale a dire come se si
trattasse di due distinte facoltà, egli ha fatto a pezzi l’intelletto stesso e incoraggiato quella
separazione totalmente erronea di «spirito» e «corpo» che, specialmente a partire da Platone,
grava come una maledizione sulla filosofia. Tutte le percezioni sensibili, valuta Parmenide, non
forniscono altro che illusioni; e la loro illusione principale consiste appunto nell’indurci a
credere che esista anche ciò che non è, ossia che anche il divenire abbia un essere. Tutta quella
molteplicità e ricchezza di colori del mondo quale è conosciuto mediante l’esperienza, il
mutamento delle sue qualità, l’ordine del suo alto e basso, vengono gettati via senza pietà come
mera apparenza e illusione: da essi non si può imparare nulla. È dunque tutta fatica sprecata
quella impiegata con questo mondo inventato, assolutamente nullo e, per così dire, ottenuto dai
sensi attraverso l’inganno. Chi lo giudica nel complesso, così come ha fatto Parmenide, cessa
con ciò di essere uno scienziato della natura nel dettaglio: il suo interessamento verso i
fenomeni si dissecca e addirittura si sviluppa un odio a causa dell’impossibilità di liberarsi da
questo eterno inganno dei sensi. La verità dovrà ormai risiedere soltanto negli universali più
scoloriti e rarefatti, nei gusci vuoti delle parole più indeterminate, come fosse avvolta in un
bozzolo di ragnatele: e accanto a una «verità» siffatta siede il filosofo, anch’egli ormai esangue
come un’astrazione e circondato da formule come da una ragnatela. Ma il ragno vuole il sangue
delle sua vittime, mentre il filosofo parmenideo è proprio il sangue delle sue vittime che odia, il
sangue della conoscenza empirica da lui offerta in sacrificio.