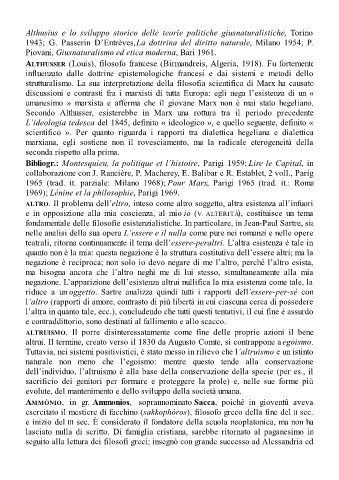Page 68 - Dizionario di Filosofia
P. 68
Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, Torino
1943; G. Passerin D’Entrèves, La dottrina del diritto naturale, Milano 1954; P.
Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Bari 1961.
ALTHUSSER (Louis), filosofo francese (Birmandreis, Algeria, 1918). Fu fortemente
influenzato dalle dottrine epistemologiche francesi e dai sistemi e metodi dello
strutturalismo. La sua interpretazione della filosofia scientifica di Marx ha causato
discussioni e contrasti fra i marxisti di tutta Europa: egli nega l’esistenza di un «
umanesimo » marxista e afferma che il giovane Marx non è mai stato hegeliano.
Secondo Althusser, esisterebbe in Marx una rottura tra il periodo precedente
L’ideologia tedesca del 1845, definito « ideologico », e quello seguente, definito «
scientifico ». Per quanto riguarda i rapporti tra dialettica hegeliana e dialettica
marxiana, egli sostiene non il rovesciamento, ma la radicale eterogeneità della
seconda rispetto alla prima.
Bibliogr.: Montesquieu, la politique et l’histoire, Parigi 1959; Lire le Capital, in
collaborazione con J. Rancière, P. Macherey, E. Balibar e R. Establet, 2 voll., Parigi
1965 (trad. it. parziale: Milano 1968); Pour Marx, Parigi 1965 (trad. it.: Roma
1969); Lénine et la philosophie, Parigi 1969.
ALTRO. Il problema dell’eltro, inteso come altro soggetto, altra esistenza all’infuori
e in opposizione alla mia coscienza, al mio io (V. ALTERITÀ), costituisce un tema
fondamentale delle filosofie esistenzialistiche. In particolare, in Jean-Paul Sartre, sia
nelle analisi della sua opera L’essere e il nulla come pure nei romanzi e nelle opere
teatrali, ritorna continuamente il tema dell’essere-peraltri. L’altra esistenza è tale in
quanto non è la mia: questa negazione è la struttura costitutiva dell’essere altri; ma la
negazione è reciproca; non solo io devo negare di me l’altro, perché l’altro esista,
ma bisogna ancora che l’altro neghi me di lui stesso, simultaneamente alla mia
negazione. L’apparizione dell’esistenza altrui nullifica la mia esistenza come tale, la
riduce a un oggetto. Sartre analizza quindi tutti i rapporti dell’essere-per-sé con
l’altro (rapporti di amore, contrasto di più libertà in cui ciascuna cerca di possedere
l’altra in quanto tale, ecc.), concludendo che tutti questi tentativi, il cui fine è assurdo
e contraddittorio, sono destinati al fallimento e allo scacco.
ALTRUISMO. Il porre disinteressatamente come fine delle proprie azioni il bene
altrui. Il termine, creato verso il 1830 da Augusto Comte, si contrappone a egoismo.
Tuttavia, nei sistemi positivistici, è stato messo in rilievo che l’altruismo e un istinto
naturale non meno che l’egoismo: mentre questo tende alla conservazione
dell’individuo, l’altruismo è alla base della conservazione della specie (per es., il
sacrificio dei genitori per formare e proteggere la prole) e, nelle sue forme più
evolute, del mantenimento e dello sviluppo della società umana.
AMMÒNIO, in gr. Ammonios, soprannominato Sacca, poiché in gioventû aveva
esercitato il mestiere di facchino (sakkophóros), filosofo greco della fine del II sec.
e inizio del III sec. È considerato il fondatore della scuola neoplatonica, ma non ha
lasciato nulla di scritto. Di famiglia cristiana, sarebbe ritornato al paganesimo in
seguito alla lettura dei filosofi greci; insegnò con grande successo ad Alessandria ed