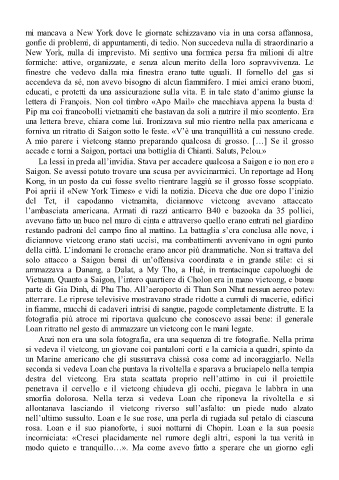Page 51 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 51
mi mancava a New York dove le giornate schizzavano via in una corsa affannosa,
gonfie di problemi, di appuntamenti, di tedio. Non succedeva nulla di straordinario a
New York, nulla di imprevisto. Mi sentivo una formica persa fra milioni di altre
formiche: attive, organizzate, e senza alcun merito della loro sopravvivenza. Le
finestre che vedevo dalla mia finestra erano tutte uguali. Il fornello del gas si
accendeva da sé, non avevo bisogno di alcun fiammifero. I miei amici erano buoni,
educati, e protetti da una assicurazione sulla vita. E in tale stato d’animo giunse la
lettera di François. Non col timbro «Apo Mail» che macchiava appena la busta di
Pip ma coi francobolli vietnamiti che bastavan da soli a nutrire il mio scontento. Era
una lettera breve, chiara come lui. Ironizzava sul mio rientro nella pax americana e
forniva un ritratto di Saigon sotto le feste. «V’è una tranquillità a cui nessuno crede.
A mio parere i vietcong stanno preparando qualcosa di grosso. […] Se il grosso
accade e torni a Saigon, portaci una bottiglia di Chianti. Saluts, Pelou.»
La lessi in preda all’invidia. Stava per accadere qualcosa a Saigon e io non ero a
Saigon. Se avessi potuto trovare una scusa per avvicinarmici. Un reportage ad Hong
Kong, in un posto da cui fosse svelto rientrare laggiù se il grosso fosse scoppiato.
Poi aprii il «New York Times» e vidi la notizia. Diceva che due ore dopo l’inizio
del Tet, il capodanno vietnamita, diciannove vietcong avevano attaccato
l’ambasciata americana. Armati di razzi anticarro B40 e bazooka da 35 pollici,
avevano fatto un buco nel muro di cinta e attraverso quello erano entrati nel giardino
restando padroni del campo fino al mattino. La battaglia s’era conclusa alle nove, i
diciannove vietcong erano stati uccisi, ma combattimenti avvenivano in ogni punto
della città. L’indomani le cronache erano ancor più drammatiche. Non si trattava del
solo attacco a Saigon bensì di un’offensiva coordinata e in grande stile: ci si
ammazzava a Danang, a Dalat, a My Tho, a Hué, in trentacinque capoluoghi del
Vietnam. Quanto a Saigon, l’intero quartiere di Cholon era in mano vietcong, e buona
parte di Gia Dinh, di Phu Tho. All’aeroporto di Than Son Nhut nessun aereo poteva
atterrare. Le riprese televisive mostravano strade ridotte a cumuli di macerie, edifici
in fiamme, mucchi di cadaveri intrisi di sangue, pagode completamente distrutte. E la
fotografia più atroce mi riportava qualcuno che conoscevo assai bene: il generale
Loan ritratto nel gesto di ammazzare un vietcong con le mani legate.
Anzi non era una sola fotografia, era una sequenza di tre fotografie. Nella prima
si vedeva il vietcong, un giovane coi pantaloni corti e la camicia a quadri, spinto da
un Marine americano che gli sussurrava chissà cosa come ad incoraggiarlo. Nella
seconda si vedeva Loan che puntava la rivoltella e sparava a bruciapelo nella tempia
destra del vietcong. Era stata scattata proprio nell’attimo in cui il proiettile
penetrava il cervello e il vietcong chiudeva gli occhi, piegava le labbra in una
smorfia dolorosa. Nella terza si vedeva Loan che riponeva la rivoltella e si
allontanava lasciando il vietcong riverso sull’asfalto: un piede nudo alzato
nell’ultimo sussulto. Loan e le sue rose, una perla di rugiada sul petalo di ciascuna
rosa. Loan e il suo pianoforte, i suoi notturni di Chopin. Loan e la sua poesia
incorniciata: «Cresci placidamente nel rumore degli altri, esponi la tua verità in
modo quieto e tranquillo…». Ma come avevo fatto a sperare che un giorno egli