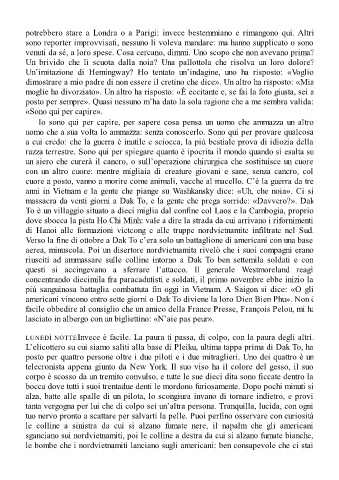Page 47 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 47
potrebbero stare a Londra o a Parigi: invece bestemmiano e rimangono qui. Altri
sono reporter improvvisati, nessuno li voleva mandare: ma hanno supplicato o sono
venuti da sé, a loro spese. Cosa cercano, dimmi. Uno scopo che non avevano prima?
Un brivido che li scuota dalla noia? Una pallottola che risolva un loro dolore?
Un’imitazione di Hemingway? Ho tentato un’indagine, uno ha risposto: «Voglio
dimostrare a mio padre di non essere il cretino che dice». Un altro ha risposto: «Mia
moglie ha divorziato». Un altro ha risposto: «È eccitante e, se fai la foto giusta, sei a
posto per sempre». Quasi nessuno m’ha dato la sola ragione che a me sembra valida:
«Sono qui per capire».
Io sono qui per capire, per sapere cosa pensa un uomo che ammazza un altro
uomo che a sua volta lo ammazza: senza conoscerlo. Sono qui per provare qualcosa
a cui credo: che la guerra è inutile e sciocca, la più bestiale prova di idiozia della
razza terrestre. Sono qui per spiegare quanto è ipocrita il mondo quando si esalta su
un siero che curerà il cancro, o sull’operazione chirurgica che sostituisce un cuore
con un altro cuore: mentre migliaia di creature giovani e sane, senza cancro, col
cuore a posto, vanno a morire come animali, vacche al macello. C’è la guerra da tre
anni in Vietnam e la gente che piange su Washkansky dice: «Uh, che noia». Ci si
massacra da venti giorni a Dak To, e la gente che prega sorride: «Davvero?». Dak
To è un villaggio situato a dieci miglia dal confine col Laos e la Cambogia, proprio
dove sbocca la pista Ho Chi Minh: vale a dire la strada da cui arrivano i rifornimenti
di Hanoi alle formazioni vietcong e alle truppe nordvietnamite infiltrate nel Sud.
Verso la fine di ottobre a Dak To c’era solo un battaglione di americani con una base
aerea, minuscola. Poi un disertore nordvietnamita rivelò che i suoi compagni erano
riusciti ad ammassare sulle colline intorno a Dak To ben settemila soldati e con
questi si accingevano a sferrare l’attacco. Il generale Westmoreland reagì
concentrando diecimila fra paracadutisti e soldati, il primo novembre ebbe inizio la
più sanguinosa battaglia combattuta fin oggi in Vietnam. A Saigon si dice: «O gli
americani vincono entro sette giorni o Dak To diviene la loro Dien Bien Phu». Non è
facile obbedire al consiglio che un amico della France Presse, François Pelou, mi ha
lasciato in albergo con un bigliettino: «N’aie pas peur».
LUNEDÌ NOTTE. Invece è facile. La paura ti passa, di colpo, con la paura degli altri.
L’elicottero su cui siamo saliti alla base di Pleiku, ultima tappa prima di Dak To, ha
posto per quattro persone oltre i due piloti e i due mitraglieri. Uno dei quattro è un
telecronista appena giunto da New York. Il suo viso ha il colore del gesso, il suo
corpo è scosso da un tremito convulso, e tutte le sue dieci dita sono ficcate dentro la
bocca dove tutti i suoi trentadue denti le mordono furiosamente. Dopo pochi minuti si
alza, batte alle spalle di un pilota, lo scongiura invano di tornare indietro, e provi
tanta vergogna per lui che di colpo sei un’altra persona. Tranquilla, lucida, con ogni
tuo nervo pronto a scattare per salvarti la pelle. Puoi perfino osservare con curiosità
le colline a sinistra da cui si alzano fumate nere, il napalm che gli americani
sganciano sui nordvietnamiti, poi le colline a destra da cui si alzano fumate bianche,
le bombe che i nordvietnamiti lanciano sugli americani: ben consapevole che ci stai