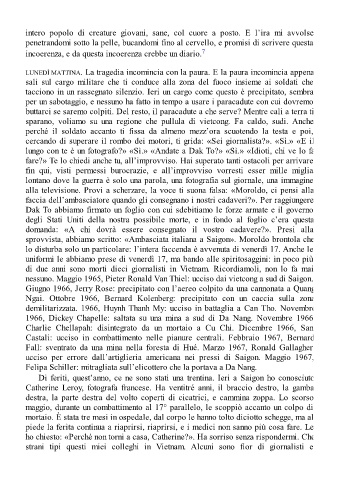Page 46 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 46
intero popolo di creature giovani, sane, col cuore a posto. E l’ira mi avvolse
penetrandomi sotto la pelle, bucandomi fino al cervello, e promisi di scrivere questa
incoerenza, e da questa incoerenza crebbe un diario. 7
LUNEDÌ MATTINA. La tragedia incomincia con la paura. E la paura incomincia appena
sali sul cargo militare che ti conduce alla zona del fuoco insieme ai soldati che
tacciono in un rassegnato silenzio. Ieri un cargo come questo è precipitato, sembra
per un sabotaggio, e nessuno ha fatto in tempo a usare i paracadute con cui dovremo
buttarci se saremo colpiti. Del resto, il paracadute a che serve? Mentre cali a terra ti
sparano, voliamo su una regione che pullula di vietcong. Fa caldo, sudi. Anche
perché il soldato accanto ti fissa da almeno mezz’ora scuotendo la testa e poi,
cercando di superare il rombo dei motori, ti grida: «Sei giornalista?». «Sì.» «E il
lungo con te è un fotografo?» «Sì.» «Andate a Dak To?» «Sì.» «Idioti, chi ve lo fa
fare?» Te lo chiedi anche tu, all’improvviso. Hai superato tanti ostacoli per arrivare
fin qui, visti permessi burocrazie, e all’improvviso vorresti esser mille miglia
lontano dove la guerra è solo una parola, una fotografia sul giornale, una immagine
alla televisione. Provi a scherzare, la voce ti suona falsa: «Moroldo, ci pensi alla
faccia dell’ambasciatore quando gli consegnano i nostri cadaveri?». Per raggiungere
Dak To abbiamo firmato un foglio con cui sdebitiamo le forze armate e il governo
degli Stati Uniti della nostra possibile morte, e in fondo al foglio c’era questa
domanda: «A chi dovrà essere consegnato il vostro cadavere?». Presi alla
sprovvista, abbiamo scritto: «Ambasciata italiana a Saigon». Moroldo brontola che
lo disturba solo un particolare: l’intera faccenda è avvenuta di venerdì 17. Anche le
uniformi le abbiamo prese di venerdì 17, ma bando alle spiritosaggini: in poco più
di due anni sono morti dieci giornalisti in Vietnam. Ricordiamoli, non lo fa mai
nessuno. Maggio 1965, Pieter Ronald Van Thiel: ucciso dai vietcong a sud di Saigon.
Giugno 1966, Jerry Rose: precipitato con l’aereo colpito da una cannonata a Quang
Ngai. Ottobre 1966, Bernard Kolenberg: precipitato con un caccia sulla zona
demilitarizzata. 1966, Huynh Thanh My: ucciso in battaglia a Can Tho. Novembre
1966, Dickey Chapelle: saltata su una mina a sud di Da Nang. Novembre 1966,
Charlie Chellapah: disintegrato da un mortaio a Cu Chi. Dicembre 1966, Sani
Castali: ucciso in combattimento nelle pianure centrali. Febbraio 1967, Bernard
Fall: sventrato da una mina nella foresta di Hué. Marzo 1967, Ronald Gallagher:
ucciso per errore dall’artiglieria americana nei pressi di Saigon. Maggio 1967,
Felipa Schiller: mitragliata sull’elicottero che la portava a Da Nang.
Di feriti, quest’anno, ce ne sono stati una trentina. Ieri a Saigon ho conosciuto
Catherine Leroy, fotografa francese. Ha ventitré anni, il braccio destro, la gamba
destra, la parte destra del volto coperti di cicatrici, e cammina zoppa. Lo scorso
maggio, durante un combattimento al 17° parallelo, le scoppiò accanto un colpo di
mortaio. È stata tre mesi in ospedale, dal corpo le hanno tolto diciotto schegge, ma al
piede la ferita continua a riaprirsi, riaprirsi, e i medici non sanno più cosa fare. Le
ho chiesto: «Perché non torni a casa, Catherine?». Ha sorriso senza rispondermi. Che
strani tipi questi miei colleghi in Vietnam. Alcuni sono fior di giornalisti e