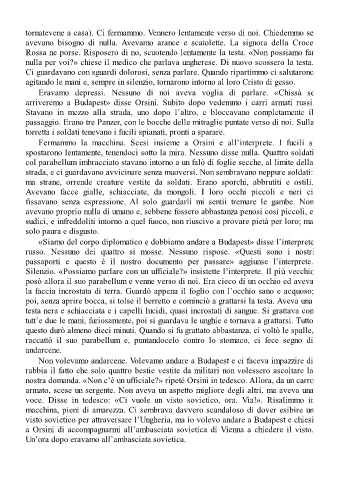Page 28 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 28
tornatevene a casa). Ci fermammo. Vennero lentamente verso di noi. Chiedemmo se
avevano bisogno di nulla. Avevamo arance e scatolette. La signora della Croce
Rossa ne porse. Risposero di no, scuotendo lentamente la testa. «Non possiamo far
nulla per voi?» chiese il medico che parlava ungherese. Di nuovo scossero la testa.
Ci guardavano con sguardi dolorosi, senza parlare. Quando ripartimmo ci salutarono
agitando le mani e, sempre in silenzio, tornarono intorno al loro Cristo di gesso.
Eravamo depressi. Nessuno di noi aveva voglia di parlare. «Chissà se
arriveremo a Budapest» disse Orsini. Subito dopo vedemmo i carri armati russi.
Stavano in mezzo alla strada, uno dopo l’altro, e bloccavano completamente il
passaggio. Erano tre Panzer, con le bocche delle mitraglie puntate verso di noi. Sulla
torretta i soldati tenevano i fucili spianati, pronti a sparare.
Fermammo la macchina. Scesi insieme a Orsini e all’interprete. I fucili si
spostarono lentamente, tenendoci sotto la mira. Nessuno disse nulla. Quattro soldati
col parabellum imbracciato stavano intorno a un falò di foglie secche, al limite della
strada, e ci guardavano avvicinare senza muoversi. Non sembravano neppure soldati:
ma strane, orrende creature vestite da soldati. Erano sporchi, abbrutiti e ostili.
Avevano facce gialle, schiacciate, da mongoli. I loro occhi piccoli e neri ci
fissavano senza espressione. Al solo guardarli mi sentii tremare le gambe. Non
avevano proprio nulla di umano e, sebbene fossero abbastanza penosi così piccoli, e
sudici, e infreddoliti intorno a quel fuoco, non riuscivo a provare pietà per loro; ma
solo paura e disgusto.
«Siamo del corpo diplomatico e dobbiamo andare a Budapest» disse l’interprete
russo. Nessuno dei quattro si mosse. Nessuno rispose. «Questi sono i nostri
passaporti e questo è il nostro documento per passare» aggiunse l’interprete.
Silenzio. «Possiamo parlare con un ufficiale?» insistette l’interprete. Il più vecchio
posò allora il suo parabellum e venne verso di noi. Era cieco di un occhio ed aveva
la faccia incrostata di terra. Guardò appena il foglio con l’occhio sano e acquoso;
poi, senza aprire bocca, si tolse il berretto e cominciò a grattarsi la testa. Aveva una
testa nera e schiacciata e i capelli lucidi, quasi incrostati di sangue. Si grattava con
tutt’e due le mani, furiosamente, poi si guardava le unghie e tornava a grattarsi. Tutto
questo durò almeno dieci minuti. Quando si fu grattato abbastanza, ci voltò le spalle,
raccattò il suo parabellum e, puntandocelo contro lo stomaco, ci fece segno di
andarcene.
Non volevamo andarcene. Volevamo andare a Budapest e ci faceva impazzire di
rabbia il fatto che solo quattro bestie vestite da militari non volessero ascoltare la
nostra domanda. «Non c’è un ufficiale?» ripeté Orsini in tedesco. Allora, da un carro
armato, scese un sergente. Non aveva un aspetto migliore degli altri, ma aveva una
voce. Disse in tedesco: «Ci vuole un visto sovietico, ora. Via!». Risalimmo in
macchina, pieni di amarezza. Ci sembrava davvero scandaloso di dover esibire un
visto sovietico per attraversare l’Ungheria, ma io volevo andare a Budapest e chiesi
a Orsini di accompagnarmi all’ambasciata sovietica di Vienna a chiedere il visto.
Un’ora dopo eravamo all’ambasciata sovietica.