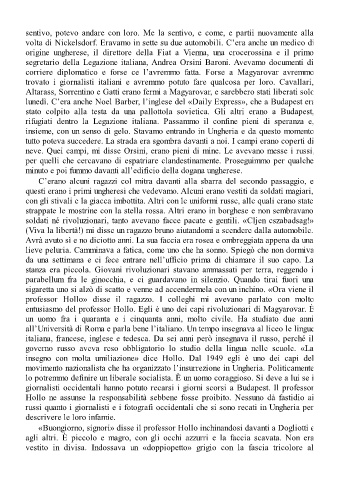Page 26 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 26
sentivo, potevo andare con loro. Me la sentivo, e come, e partii nuovamente alla
volta di Nickelsdorf. Eravamo in sette su due automobili. C’era anche un medico di
origine ungherese, il direttore della Fiat a Vienna, una crocerossina e il primo
segretario della Legazione italiana, Andrea Orsini Baroni. Avevamo documenti di
corriere diplomatico e forse ce l’avremmo fatta. Forse a Magyarovar avremmo
trovato i giornalisti italiani e avremmo potuto fare qualcosa per loro. Cavallari,
Altarass, Sorrentino e Gatti erano fermi a Magyarovar, e sarebbero stati liberati solo
lunedì. C’era anche Noel Barber, l’inglese del «Daily Express», che a Budapest era
stato colpito alla testa da una pallottola sovietica. Gli altri erano a Budapest,
rifugiati dentro la Legazione italiana. Passammo il confine pieni di speranza e,
insieme, con un senso di gelo. Stavamo entrando in Ungheria e da questo momento
tutto poteva succedere. La strada era sgombra davanti a noi. I campi erano coperti di
neve. Quei campi, mi disse Orsini, erano pieni di mine. Le avevano messe i russi,
per quelli che cercavano di espatriare clandestinamente. Proseguimmo per qualche
minuto e poi fummo davanti all’edificio della dogana ungherese.
C’erano alcuni ragazzi col mitra davanti alla sbarra del secondo passaggio, e
questi erano i primi ungheresi che vedevamo. Alcuni erano vestiti da soldati magiari,
con gli stivali e la giacca imbottita. Altri con le uniformi russe, alle quali erano state
strappate le mostrine con la stella rossa. Altri erano in borghese e non sembravano
soldati né rivoluzionari, tanto avevano facce pacate e gentili. «Cljen cszabadsag!»
(Viva la libertà!) mi disse un ragazzo bruno aiutandomi a scendere dalla automobile.
Avrà avuto sì e no diciotto anni. La sua faccia era rosea e ombreggiata appena da una
lieve peluria. Camminava a fatica, come uno che ha sonno. Spiegò che non dormiva
da una settimana e ci fece entrare nell’ufficio prima di chiamare il suo capo. La
stanza era piccola. Giovani rivoluzionari stavano ammassati per terra, reggendo i
parabellum fra le ginocchia, e ci guardavano in silenzio. Quando tirai fuori una
sigaretta uno si alzò di scatto e venne ad accendermela con un inchino. «Ora viene il
professor Hollo» disse il ragazzo. I colleghi mi avevano parlato con molto
entusiasmo del professor Hollo. Egli è uno dei capi rivoluzionari di Magyarovar. È
un uomo fra i quaranta e i cinquanta anni, molto civile. Ha studiato due anni
all’Università di Roma e parla bene l’italiano. Un tempo insegnava al liceo le lingue
italiana, francese, inglese e tedesca. Da sei anni però insegnava il russo, perché il
governo russo aveva reso obbligatorio lo studio della lingua nelle scuole. «La
insegno con molta umiliazione» dice Hollo. Dal 1949 egli è uno dei capi del
movimento nazionalista che ha organizzato l’insurrezione in Ungheria. Politicamente
lo potremmo definire un liberale socialista. È un uomo coraggioso. Si deve a lui se i
giornalisti occidentali hanno potuto recarsi i giorni scorsi a Budapest. Il professor
Hollo ne assunse la responsabilità sebbene fosse proibito. Nessuno dà fastidio ai
russi quanto i giornalisti e i fotografi occidentali che si sono recati in Ungheria per
descrivere le loro infamie.
«Buongiorno, signori» disse il professor Hollo inchinandosi davanti a Dogliotti e
agli altri. È piccolo e magro, con gli occhi azzurri e la faccia scavata. Non era
vestito in divisa. Indossava un «doppiopetto» grigio con la fascia tricolore al