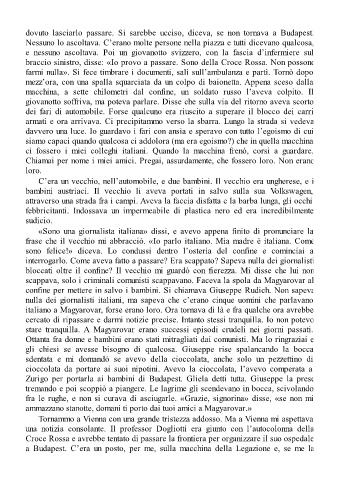Page 25 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 25
dovuto lasciarlo passare. Si sarebbe ucciso, diceva, se non tornava a Budapest.
Nessuno lo ascoltava. C’erano molte persone nella piazza e tutti dicevano qualcosa,
e nessuno ascoltava. Poi un giovanotto svizzero, con la fascia d’infermiere sul
braccio sinistro, disse: «Io provo a passare. Sono della Croce Rossa. Non possono
farmi nulla». Si fece timbrare i documenti, salì sull’ambulanza e partì. Tornò dopo
mezz’ora, con una spalla squarciata da un colpo di baionetta. Appena sceso dalla
macchina, a sette chilometri dal confine, un soldato russo l’aveva colpito. Il
giovanotto soffriva, ma poteva parlare. Disse che sulla via del ritorno aveva scorto
dei fari di automobile. Forse qualcuno era riuscito a superare il blocco dei carri
armati e ora arrivava. Ci precipitammo verso la sbarra. Lungo la strada si vedeva
davvero una luce. Io guardavo i fari con ansia e speravo con tutto l’egoismo di cui
siamo capaci quando qualcosa ci addolora (ma era egoismo?) che in quella macchina
ci fossero i miei colleghi italiani. Quando la macchina frenò, corsi a guardare.
Chiamai per nome i miei amici. Pregai, assurdamente, che fossero loro. Non erano
loro.
C’era un vecchio, nell’automobile, e due bambini. Il vecchio era ungherese, e i
bambini austriaci. Il vecchio li aveva portati in salvo sulla sua Volkswagen,
attraverso una strada fra i campi. Aveva la faccia disfatta e la barba lunga, gli occhi
febbricitanti. Indossava un impermeabile di plastica nero ed era incredibilmente
sudicio.
«Sono una giornalista italiana» dissi, e avevo appena finito di pronunciare la
frase che il vecchio mi abbracciò. «Io parlo italiano. Mia madre è italiana. Come
sono felice!» diceva. Lo condussi dentro l’osteria del confine e cominciai a
interrogarlo. Come aveva fatto a passare? Era scappato? Sapeva nulla dei giornalisti
bloccati oltre il confine? Il vecchio mi guardò con fierezza. Mi disse che lui non
scappava, solo i criminali comunisti scappavano. Faceva la spola da Magyarovar al
confine per mettere in salvo i bambini. Si chiamava Giuseppe Rudich. Non sapeva
nulla dei giornalisti italiani, ma sapeva che c’erano cinque uomini che parlavano
italiano a Magyarovar, forse erano loro. Ora tornava di là e fra qualche ora avrebbe
cercato di ripassare e darmi notizie precise. Intanto stessi tranquilla. Io non potevo
stare tranquilla. A Magyarovar erano successi episodi crudeli nei giorni passati.
Ottanta fra donne e bambini erano stati mitragliati dai comunisti. Ma lo ringraziai e
gli chiesi se avesse bisogno di qualcosa. Giuseppe rise spalancando la bocca
sdentata e mi domandò se avevo della cioccolata, anche solo un pezzettino di
cioccolata da portare ai suoi nipotini. Avevo la cioccolata, l’avevo comperata a
Zurigo per portarla ai bambini di Budapest. Gliela detti tutta. Giuseppe la prese
tremando e poi scoppiò a piangere. Le lagrime gli scendevano in bocca, scivolando
fra le rughe, e non si curava di asciugarle. «Grazie, signorina» disse, «se non mi
ammazzano stanotte, domani ti porto dai tuoi amici a Magyarovar.»
Tornammo a Vienna con una grande tristezza addosso. Ma a Vienna mi aspettava
una notizia consolante. Il professor Dogliotti era giunto con l’autocolonna della
Croce Rossa e avrebbe tentato di passare la frontiera per organizzare il suo ospedale
a Budapest. C’era un posto, per me, sulla macchina della Legazione e, se me la