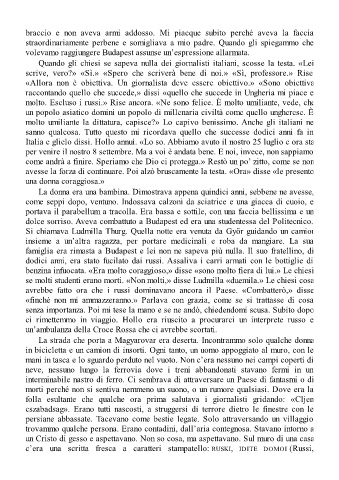Page 27 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 27
braccio e non aveva armi addosso. Mi piacque subito perché aveva la faccia
straordinariamente perbene e somigliava a mio padre. Quando gli spiegammo che
volevamo raggiungere Budapest assunse un’espressione allarmata.
Quando gli chiesi se sapeva nulla dei giornalisti italiani, scosse la testa. «Lei
scrive, vero?» «Sì.» «Spero che scriverà bene di noi.» «Sì, professore.» Rise.
«Allora non è obiettiva. Un giornalista deve essere obiettivo.» «Sono obiettiva
raccontando quello che succede,» dissi «quello che succede in Ungheria mi piace e
molto. Escluso i russi.» Rise ancora. «Ne sono felice. È molto umiliante, vede, che
un popolo asiatico domini un popolo di millenaria civiltà come quello ungherese. È
molto umiliante la dittatura, capisce?» Lo capivo benissimo. Anche gli italiani ne
sanno qualcosa. Tutto questo mi ricordava quello che successe dodici anni fa in
Italia e glielo dissi. Hollo annuì. «Lo so. Abbiamo avuto il nostro 25 luglio e ora sta
per venire il nostro 8 settembre. Ma a voi è andata bene. E noi, invece, non sappiamo
come andrà a finire. Speriamo che Dio ci protegga.» Restò un po’ zitto, come se non
avesse la forza di continuare. Poi alzò bruscamente la testa. «Ora» disse «le presento
una donna coraggiosa.»
La donna era una bambina. Dimostrava appena quindici anni, sebbene ne avesse,
come seppi dopo, ventuno. Indossava calzoni da sciatrice e una giacca di cuoio, e
portava il parabellum a tracolla. Era bassa e sottile, con una faccia bellissima e un
dolce sorriso. Aveva combattuto a Budapest ed era una studentessa del Politecnico.
Si chiamava Ludmilla Thurg. Quella notte era venuta da Györ guidando un camion
insieme a un’altra ragazza, per portare medicinali e roba da mangiare. La sua
famiglia era rimasta a Budapest e lei non ne sapeva più nulla. Il suo fratellino, di
dodici anni, era stato fucilato dai russi. Assaliva i carri armati con le bottiglie di
benzina infuocata. «Era molto coraggioso,» disse «sono molto fiera di lui.» Le chiesi
se molti studenti erano morti. «Non molti,» disse Ludmilla «duemila.» Le chiesi cosa
avrebbe fatto ora che i russi dominavano ancora il Paese. «Combatterò,» disse
«finché non mi ammazzeranno.» Parlava con grazia, come se si trattasse di cosa
senza importanza. Poi mi tese la mano e se ne andò, chiedendomi scusa. Subito dopo
ci rimettemmo in viaggio. Hollo era riuscito a procurarci un interprete russo e
un’ambulanza della Croce Rossa che ci avrebbe scortati.
La strada che porta a Magyarovar era deserta. Incontrammo solo qualche donna
in bicicletta e un camion di insorti. Ogni tanto, un uomo appoggiato al muro, con le
mani in tasca e lo sguardo perduto nel vuoto. Non c’era nessuno nei campi coperti di
neve, nessuno lungo la ferrovia dove i treni abbandonati stavano fermi in un
interminabile nastro di ferro. Ci sembrava di attraversare un Paese di fantasmi o di
morti perché non si sentiva nemmeno un suono, o un rumore qualsiasi. Dove era la
folla esultante che qualche ora prima salutava i giornalisti gridando: «Cljen
cszabadsag». Erano tutti nascosti, a struggersi di terrore dietro le finestre con le
persiane abbassate. Tacevano come bestie legate. Solo attraversando un villaggio
trovammo qualche persona. Erano contadini, dall’aria contegnosa. Stavano intorno a
un Cristo di gesso e aspettavano. Non so cosa, ma aspettavano. Sul muro di una casa
c’era una scritta fresca a caratteri stampatello: RUSKI, IDITE DOMOI (Russi,