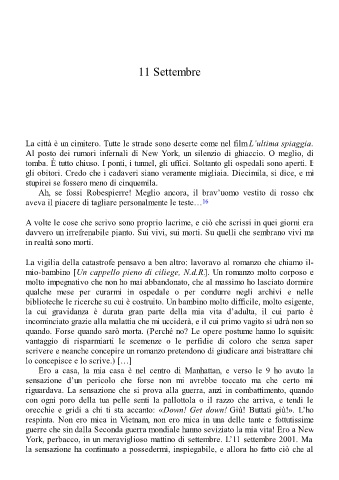Page 149 - Oriana Fallaci - Solo io posso scrivere la mia storia
P. 149
11 Settembre
La città è un cimitero. Tutte le strade sono deserte come nel film L’ultima spiaggia.
Al posto dei rumori infernali di New York, un silenzio di ghiaccio. O meglio, di
tomba. È tutto chiuso. I ponti, i tunnel, gli uffici. Soltanto gli ospedali sono aperti. E
gli obitori. Credo che i cadaveri siano veramente migliaia. Diecimila, si dice, e mi
stupirei se fossero meno di cinquemila.
Ah, se fossi Robespierre! Meglio ancora, il brav’uomo vestito di rosso che
aveva il piacere di tagliare personalmente le teste… 16
A volte le cose che scrivo sono proprio lacrime, e ciò che scrissi in quei giorni era
davvero un irrefrenabile pianto. Sui vivi, sui morti. Su quelli che sembrano vivi ma
in realtà sono morti.
La vigilia della catastrofe pensavo a ben altro: lavoravo al romanzo che chiamo il-
mio-bambino [Un cappello pieno di ciliege, N.d.R.]. Un romanzo molto corposo e
molto impegnativo che non ho mai abbandonato, che al massimo ho lasciato dormire
qualche mese per curarmi in ospedale o per condurre negli archivi e nelle
biblioteche le ricerche su cui è costruito. Un bambino molto difficile, molto esigente,
la cui gravidanza è durata gran parte della mia vita d’adulta, il cui parto è
incominciato grazie alla malattia che mi ucciderà, e il cui primo vagito si udrà non so
quando. Forse quando sarò morta. (Perché no? Le opere postume hanno lo squisito
vantaggio di risparmiarti le scemenze o le perfidie di coloro che senza saper
scrivere e neanche concepire un romanzo pretendono di giudicare anzi bistrattare chi
lo concepisce e lo scrive.) […]
Ero a casa, la mia casa è nel centro di Manhattan, e verso le 9 ho avuto la
sensazione d’un pericolo che forse non mi avrebbe toccato ma che certo mi
riguardava. La sensazione che si prova alla guerra, anzi in combattimento, quando
con ogni poro della tua pelle senti la pallottola o il razzo che arriva, e tendi le
orecchie e gridi a chi ti sta accanto: «Down! Get down! Giù! Buttati giù!». L’ho
respinta. Non ero mica in Vietnam, non ero mica in una delle tante e fottutissime
guerre che sin dalla Seconda guerra mondiale hanno seviziato la mia vita! Ero a New
York, perbacco, in un meraviglioso mattino di settembre. L’11 settembre 2001. Ma
la sensazione ha continuato a possedermi, inspiegabile, e allora ho fatto ciò che al