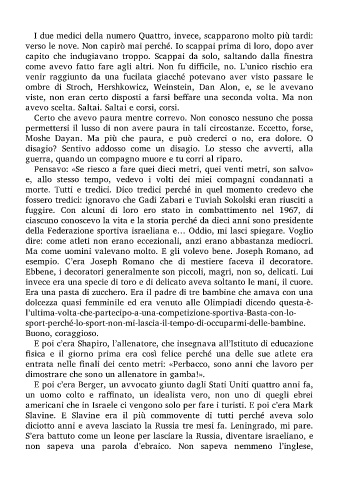Page 164 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 164
I due medici della numero Quattro, invece, scapparono molto più tardi:
verso le nove. Non capirò mai perché. Io scappai prima di loro, dopo aver
capito che indugiavano troppo. Scappai da solo, saltando dalla nestra
come avevo fatto fare agli altri. Non fu di cile, no. L’unico rischio era
venir raggiunto da una fucilata giacché potevano aver visto passare le
ombre di Stroch, Hershkowicz, Weinstein, Dan Alon, e, se le avevano
viste, non eran certo disposti a farsi be are una seconda volta. Ma non
avevo scelta. Saltai. Saltai e corsi, corsi.
Certo che avevo paura mentre correvo. Non conosco nessuno che possa
permettersi il lusso di non avere paura in tali circostanze. Eccetto, forse,
Moshe Dayan. Ma più che paura, e può crederci o no, era dolore. O
disagio? Sentivo addosso come un disagio. Lo stesso che avverti, alla
guerra, quando un compagno muore e tu corri al riparo.
Pensavo: «Se riesco a fare quei dieci metri, quei venti metri, son salvo»
e, allo stesso tempo, vedevo i volti dei miei compagni condannati a
morte. Tutti e tredici. Dico tredici perché in quel momento credevo che
fossero tredici: ignoravo che Gadi Zabari e Tuviah Sokolski eran riusciti a
fuggire. Con alcuni di loro ero stato in combattimento nel 1967, di
ciascuno conoscevo la vita e la storia perché da dieci anni sono presidente
della Federazione sportiva israeliana e… Oddio, mi lasci spiegare. Voglio
dire: come atleti non erano eccezionali, anzi erano abbastanza mediocri.
Ma come uomini valevano molto. E gli volevo bene. Joseph Romano, ad
esempio. C’era Joseph Romano che di mestiere faceva il decoratore.
Ebbene, i decoratori generalmente son piccoli, magri, non so, delicati. Lui
invece era una specie di toro e di delicato aveva soltanto le mani, il cuore.
Era una pasta di zucchero. Era il padre di tre bambine che amava con una
dolcezza quasi femminile ed era venuto alle Olimpiadi dicendo questa-è-
l’ultima-volta-che-partecipo-a-una-competizione-sportiva-Basta-con-lo-
sport-perché-lo-sport-non-mi-lascia-il-tempo-di-occuparmi-delle-bambine.
Buono, coraggioso.
E poi c’era Shapiro, l’allenatore, che insegnava all’Istituto di educazione
sica e il giorno prima era così felice perché una delle sue atlete era
entrata nelle nali dei cento metri: «Perbacco, sono anni che lavoro per
dimostrare che sono un allenatore in gamba!».
E poi c’era Berger, un avvocato giunto dagli Stati Uniti quattro anni fa,
un uomo colto e ra nato, un idealista vero, non uno di quegli ebrei
americani che in Israele ci vengono solo per fare i turisti. E poi c’era Mark
Slavine. E Slavine era il più commovente di tutti perché aveva solo
diciotto anni e aveva lasciato la Russia tre mesi fa. Leningrado, mi pare.
S’era battuto come un leone per lasciare la Russia, diventare israeliano, e
non sapeva una parola d’ebraico. Non sapeva nemmeno l’inglese,