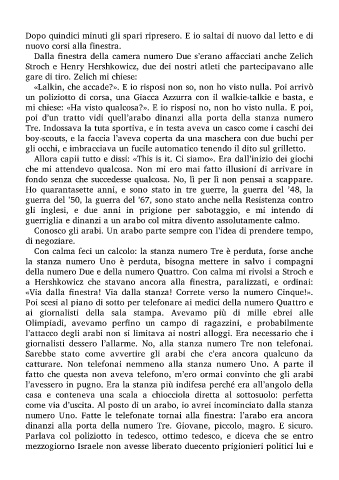Page 162 - Oriana Fallaci - Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam
P. 162
Dopo quindici minuti gli spari ripresero. E io saltai di nuovo dal letto e di
nuovo corsi alla finestra.
Dalla nestra della camera numero Due s’erano a acciati anche Zelich
Stroch e Henry Hershkowicz, due dei nostri atleti che partecipavano alle
gare di tiro. Zelich mi chiese:
«Lalkin, che accade?». E io risposi non so, non ho visto nulla. Poi arrivò
un poliziotto di corsa, una Giacca Azzurra con il walkie-talkie e basta, e
mi chiese: «Ha visto qualcosa?». E io risposi no, non ho visto nulla. E poi,
poi d’un tratto vidi quell’arabo dinanzi alla porta della stanza numero
Tre. Indossava la tuta sportiva, e in testa aveva un casco come i caschi dei
boy-scouts, e la faccia l’aveva coperta da una maschera con due buchi per
gli occhi, e imbracciava un fucile automatico tenendo il dito sul grilletto.
Allora capii tutto e dissi: «This is it. Ci siamo». Era dall’inizio dei giochi
che mi attendevo qualcosa. Non mi ero mai fatto illusioni di arrivare in
fondo senza che succedesse qualcosa. No, lì per lì non pensai a scappare.
Ho quarantasette anni, e sono stato in tre guerre, la guerra del ’48, la
guerra del ’50, la guerra del ’67, sono stato anche nella Resistenza contro
gli inglesi, e due anni in prigione per sabotaggio, e mi intendo di
guerriglia e dinanzi a un arabo col mitra divento assolutamente calmo.
Conosco gli arabi. Un arabo parte sempre con l’idea di prendere tempo,
di negoziare.
Con calma feci un calcolo: la stanza numero Tre è perduta, forse anche
la stanza numero Uno è perduta, bisogna mettere in salvo i compagni
della numero Due e della numero Quattro. Con calma mi rivolsi a Stroch e
a Hershkowicz che stavano ancora alla nestra, paralizzati, e ordinai:
«Via dalla nestra! Via dalla stanza! Correte verso la numero Cinque!».
Poi scesi al piano di sotto per telefonare ai medici della numero Quattro e
ai giornalisti della sala stampa. Avevamo più di mille ebrei alle
Olimpiadi, avevamo per no un campo di ragazzini, e probabilmente
l’attacco degli arabi non si limitava ai nostri alloggi. Era necessario che i
giornalisti dessero l’allarme. No, alla stanza numero Tre non telefonai.
Sarebbe stato come avvertire gli arabi che c’era ancora qualcuno da
catturare. Non telefonai nemmeno alla stanza numero Uno. A parte il
fatto che questa non aveva telefono, m’ero ormai convinto che gli arabi
l’avessero in pugno. Era la stanza più indifesa perché era all’angolo della
casa e conteneva una scala a chiocciola diretta al sottosuolo: perfetta
come via d’uscita. Al posto di un arabo, io avrei incominciato dalla stanza
numero Uno. Fatte le telefonate tornai alla nestra: l’arabo era ancora
dinanzi alla porta della numero Tre. Giovane, piccolo, magro. E sicuro.
Parlava col poliziotto in tedesco, ottimo tedesco, e diceva che se entro
mezzogiorno Israele non avesse liberato duecento prigionieri politici lui e