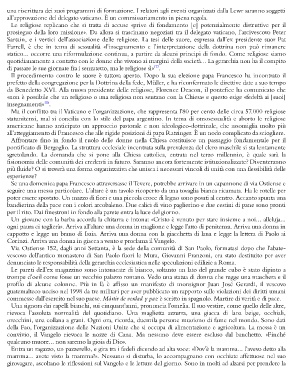Page 55 - Francesco tra i lupi
P. 55
una riscrittura dei suoi programmi di formazione. I relatori agli eventi organizzati dalla Lcwr saranno soggetti
all’approvazione del delegato vaticano. È un commissariamento in piena regola.
Le religiose replicano che si tratta di accuse «prive di fondamento [e] potenzialmente distruttive per il
prosieguo della loro missione». Da allora si trascinano negoziati tra il delegato vaticano, l’arcivescovo Peter
Sartain, e i vertici dell’associazione delle religiose. La tesi delle suore, espressa dall’ex presidente suor Pat
Farrell, è che in tema di sessualità «l’insegnamento e l’interpretazione della dottrina non può rimanere
statico... occorre una riformulazione continua, a partire da alcuni principi di fondo. Come religiose siamo
quotidianamente a contatto con le donne che vivono ai margini della società... La gerarchia non ha il compito
177
di passare le sue giornate fra i senzatetto, ma le religiose sì» .
Il procedimento contro le suore è tuttora aperto. Dopo la sua elezione papa Francesco ha incontrato il
prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, Müller, e ha riconfermato le direttive date a suo tempo
da Benedetto XVI. Alla nuova presidente delle religiose, Florence Deacon, il pontefice ha comunicato che
«non è possibile che un religioso o una religiosa non sentano con la Chiesa» e questo esige «fedeltà ai [suoi]
178
insegnamenti» .
Ma il conflitto tra il Vaticano e l’organizzazione, che rappresenta l’80 per cento delle circa 57.000 religiose
statunitensi, mal si concilia con lo stile del papa argentino. In tema di omosessualità e aborto le religiose
americane hanno anticipato un approccio pastorale e non ideologico-dottrinale, che assomiglia molto più
all’atteggiamento di Francesco che alle rigide posizioni di papa Ratzinger. È un nodo complicato da sciogliere.
Affrontare fino in fondo il ruolo delle donne nella Chiesa costituisce un passaggio fondamentale per il
pontificato di Bergoglio. La struttura ecclesiale incentrata sulla prevalenza del clero maschile si sta lentamente
sgretolando. La domanda che si pone alla Chiesa cattolica, entrata nel terzo millennio, è quale sarà la
fisionomia delle comunità dei credenti in futuro. Saranno ancora fortemente istituzionalizzate? Diventeranno
più fluide? O si troverà una forma organizzativa che unisca i necessari vincoli di unità con una flessibilità delle
esperienze?
Se una domenica papa Francesco attraversasse il Tevere, potrebbe arrivare in un capannone di via Ostiense e
seguire una messa particolare. L’altare è un tavolo ricoperto da una tovaglia bianca ricamata. Ha le rotelle per
poter essere spostato. Un mazzo di fiori e una piccola croce di legno sono posati al centro. Accanto spunta una
bandierina della pace con i colori arcobaleno. Due calici di vino paglierino e due cestini di pane sono pronti
per il rito. Dai finestroni in fondo alla parete entra la luce del giorno.
Un giovane con la barba accorda la chitarra e intona: «Cristo è venuto per stare insieme a noi... alleluja...
ogni paura ci toglierà». Arriva all’altare una donna in maglione e legge l’atto di penitenza. Arriva una donna in
cappotto e legge un brano di Isaia. Arriva una donna con la giacchetta di lana e legge la lettera di Paolo ai
Corinzi. Arriva una donna in giacca a vento e proclama il Vangelo.
Via Ostiense 152, dagli anni Settanta, è la sede della comunità di San Paolo, formatasi dopo che l’abate-
vescovo dell’antico monastero di San Paolo fuori le Mura, Giovanni Franzoni, era stato destituito per aver
denunciato le responsabilità della gerarchia ecclesiastica nelle speculazioni edilizie a Roma.
Le pareti dell’ex magazzino sono intonacate di bianco, soltanto un lato del grande cubo è stato dipinto a
trompe d’oeil come fosse un vecchio palazzo romano. Vedo una statua di donna che regge una maschera e il
profilo di alcune colonne. Più in là è affisso un manifesto di monsignor Juan José Gerardi, il vescovo
guatemalteco ucciso nel 1998 da tre militari per aver pubblicato un rapporto sulle violazioni dei diritti umani
commesse dall’esercito nel suo paese. Mártir de verdad y paz è scritto in spagnolo. Martire di verità e di pace.
Una signora dai capelli bianchi, sui cinquant’anni, pronuncia l’omelia. Il suo vestire, come quello delle altre,
rievoca l’assoluta normalità del quotidiano. Una maglietta azzurra, una giacca di lana beige, occhiali,
orecchini, una collana a grani. Ogni ora, ricorda, duemila persone muoiono di fame nel mondo. Sono dati
della Fao, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura. La messa è un
convivio, il Vangelo rievoca le nozze di Cana. Ma nessuno deve essere escluso dal banchetto. «Finché
qualcuno muore... non saremo la gioia di Dio».
Entra un ragazzo, un pazzerello, e gira tra i fedeli dicendo ad alta voce: «Dov’è la mamma... l’avevo detto alla
mamma... avete visto la mamma?». Nessuno si disturba, lo accompagnano con occhiate affettuose nel suo
girovagare, ascoltano le riflessioni sul Vangelo e le letture del giorno. Sono in molti ad alzarsi per prendere la