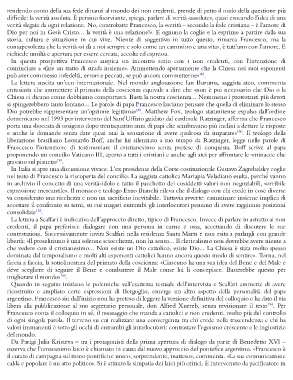Page 47 - Francesco tra i lupi
P. 47
rendendo conto della sua fede dinanzi al mondo dei non credenti, prende di petto il nodo della questione più
difficile: la verità assoluta. È persino fuorviante, spiega, parlare di verità «assolute», quasi evocando l’idea di una
verità slegata da ogni relazione. No, controbatte Francesco, la «verità – secondo la fede cristiana – è l’amore di
Dio per noi in Gesù Cristo... la verità è una relazione!». E ognuno la coglie e la esprime a partire dalla sua
storia, cultura e situazione in cui vive. Niente di soggettivo in tutto questo, rimarca Francesco, ma la
consapevolezza che la verità «si dà a noi sempre e solo come un cammino e una vita», è tutt’uno con l’amore. E
richiede umiltà e apertura per essere cercata, accolta ed espressa.
In questa prospettiva Francesco auspica un incontro serio con i non credenti, con l’intenzione di
cominciare a «fare un tratto di strada insieme». Ammettendo apertamente che la Chiesa nei suoi esponenti
148
può aver commesso infedeltà, errori e peccati, «e può ancora commetterne» .
La lettera suscita un’eco internazionale. Nel mondo anglosassone Ian Buruma, saggista ateo, commenta
entusiasta che ammettere il primato della coscienza equivale a dire che «non è poi necessario che Dio o la
Chiesa ci dicano come dobbiamo comportarci. Basta la nostra coscienza... Nemmeno i protestanti più devoti
si spingerebbero tanto lontano... Le parole di papa Francesco lasciano pensare che quella di eliminare lo stesso
149
Dio potrebbe rappresentare un’opzione legittima» . Matthew Fox, teologo statunitense espulso dall’ordine
domenicano nel 1993 per intervento del Sant’Uffizio guidato dal cardinale Ratzinger, afferma che Francesco
porta una «boccata di ossigeno dopo trentaquattro anni di papi che sembravano più inclini a dettare le risposte
150
e anche le domande senza dare quasi mai la sensazione di avere qualcosa da imparare» . Il teologo della
liberazione brasiliano Leonardo Boff, anche lui silenziato a suo tempo da Ratzinger, legge nelle parole di
Francesco l’intenzione di testimoniare il cristianesimo senza pretese di conquista. Boff scrive al papa
proponendo un concilio Vaticano III, aperto a tutti i cristiani e anche agli atei per affrontare le «minacce che
151
gravano sul pianeta» .
In Italia si apre una discussione vivace. L’ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky coglie
nel testo di Francesco la riscoperta del concilio. La saggista cattolica Mariapia Veladiano esulta, perché vanno
in archivio il concetto di una verità-idolo e tutto il pacchetto dei cosiddetti valori non negoziabili, «orribile
espressione mercantile». Il monaco e teologo Enzo Bianchi rileva che il dialogo con chi crede in cose diverse
va considerato una ricchezza e non un sacrificio inevitabile. Tuttavia avverte: camminare insieme implica di
accettare il confronto su temi, su cui magari entrambi gli interlocutori pensano di avere raggiunto posizioni
152
consolidate .
La lettera a Scalfari è indicativa dell’approccio diretto, tipico di Francesco. Invece di parlare in astratto ai non
credenti, il papa preferisce dialogare con una persona in carne e ossa, accettando di discutere le sue
contestazioni. Successivamente invita Scalfari nella residenza Santa Marta e non esita a parlargli con grande
libertà: «Il proselitismo è una solenne sciocchezza, non ha senso... Il clericalismo non dovrebbe avere niente a
che vedere con il cristianesimo... Non esiste un Dio cattolico, esiste Dio... La Chiesa è stata molto spesso
dominata dal temporalismo e molti alti esponenti cattolici hanno ancora questo modo di sentire». Torna, nel
faccia a faccia, la sottolineatura del primato della coscienza: «Ciascuno ha una sua idea del Bene e del Male e
deve scegliere di seguire il Bene e combattere il Male come lui li concepisce. Basterebbe questo per
153
migliorare il mondo» .
Quando in seguito iniziano le polemiche sull’esattezza testuale dell’intervista e Scalfari ammette di avere
ricostruito e ampliato certe espressioni di Bergoglio, emerge un altro aspetto della personalità del papa
argentino. Francesco sin dall’inizio non ha preteso di leggere la versione definitiva del colloquio e ha dato il via
154
libera alla pubblicazione al suo segretario personale, don Alfred Xuereb, senza revisionare il testo . Per
Francesco conta il colloquio in sé, il messaggio che manda a cattolici e non credenti, molto più del controllo
di ogni singola parola. Il terreno su cui realizzare una convergenza tra chi crede nella trascendenza e chi ha
valori immanenti è sotto gli occhi di entrambi gli interlocutori: contrastare l’egoismo crescente e le ingiustizie
del mondo.
Da Parigi Julia Kristeva – tra i protagonisti della prima apertura di dialogo da parte di Benedetto XVI –
osserva che l’umanesimo laico è chiamato in causa dal nuovo approccio del pontefice argentino. «Francesco è
il curato di campagna sul trono pontificio: unico, sorprendente, inatteso», commenta. «La sua comunicazione
calda e popolare è un atto politico». Si è attirato la simpatia dei laici più critici. È intervenuto da pacificatore in