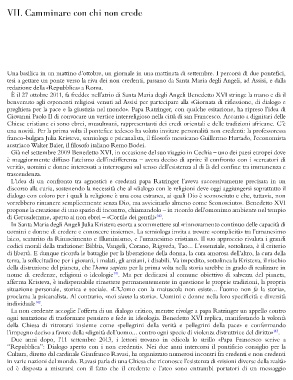Page 45 - Francesco tra i lupi
P. 45
VII. Camminare con chi non crede
Una basilica in un mattino d’ottobre, un giornale in una mattinata di settembre. I percorsi di due pontefici,
tesi a gettare un ponte verso la riva dei non credenti, passano da Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, e dalla
redazione della «Repubblica» a Roma.
È il 27 ottobre 2011, fa freddo: nell’atrio di Santa Maria degli Angeli Benedetto XVI stringe la mano e dà il
benvenuto agli esponenti religiosi venuti ad Assisi per partecipare alla «Giornata di riflessione, di dialogo e
preghiera per la pace e la giustizia nel mondo». Papa Ratzinger, con qualche esitazione, ha ripreso l’idea di
Giovanni Paolo II di convocare un vertice interreligioso nella città di san Francesco. Accanto a dignitari delle
Chiese cristiane ci sono ebrei, musulmani, rappresentanti dei credi orientali e delle tradizioni africane. C’è
una novità. Per la prima volta il pontefice tedesco ha voluto invitare personalità non credenti: la professoressa
franco-bulgara Julia Kristeva, semiologa e psicanalista, il filosofo messicano Guillermo Hurtado, l’economista
austriaco Walter Baier, il filosofo italiano Remo Bodei.
Già nel settembre 2009 Benedetto XVI, in occasione del suo viaggio in Cechia – uno dei paesi europei dove
è maggiormente diffuso l’ateismo dell’indifferenza – aveva deciso di aprire il confronto con i «cercatori di
verità», uomini e donne interessati a interrogarsi sul senso dell’esistenza al di là del confine tra immanenza e
trascendenza.
L’idea di un confronto tra agnostici e credenti papa Ratzinger l’aveva successivamente precisata in un
discorso alla curia, sostenendo la necessità che al «dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il
dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che, tuttavia, non
vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come Sconosciuto». Benedetto XVI
propone la creazione di uno spazio di incontro, chiamandolo – in ricordo dell’omonimo ambiente nel tempio
140
di Gerusalemme, aperto ai non ebrei – «Cortile dei gentili» .
In Santa Maria degli Angeli Julia Kristeva esorta a scommettere sul «rinnovamento continuo delle capacità di
uomini e donne di credere e conoscere insieme». La semiologa invita a trovare «complicità» tra l’umanesimo
laico, scaturito da Rinascimento e Illuminismo, e l’umanesimo cristiano. Il suo approccio rivaluta i grandi
codici morali della tradizione: Bibbia, Vangeli, Corano, Rigveda, Tao... L’essenziale, sottolinea, è il criterio
di libertà. E dunque ricorda le battaglie per la liberazione della donna, la cura amorosa dell’altro, la cura della
terra, la sollecitudine per i giovani, i malati, gli anziani, i disabili. Va impedito, sottolinea la Kristeva, il rischio
della distruzione del pianeta, che l’homo sapiens per la prima volta nella storia sarebbe in grado di realizzare in
141
nome di credenze, religioni o ideologie . Ma per dedicarsi al comune obiettivo di salvezza del pianeta,
afferma Kristeva, è indispensabile rimettere permanentemente in questione le proprie tradizioni, la propria
situazione personale, storica e sociale. «L’Uomo con la maiuscola non esiste... l’uomo non fa la storia»,
proclama la psicanalista. Al contrario, «noi siamo la storia». Uomini e donne nella loro specificità e diversità
142
individuale .
La non credente accoglie l’offerta di un dialogo critico, mentre rivolge a papa Ratzinger un appello contro
ogni tentazione di trasformare pensiero e fede in ideologia. Benedetto XVI replica, manifestando la volontà
della Chiesa di ritrovarsi insieme come «pellegrini della verità e pellegrini della pace» e confermando
143
l’impegno deciso a favore della «dignità dell’uomo... contro ogni specie di violenza distruttrice del diritto» .
Due anni dopo, l’11 settembre 2013, i lettori trovano in edicola lo strillo «Papa Francesco scrive a
“Repubblica”: Dialogo aperto con i non credenti». Nei due anni intercorsi il pontificio consiglio per la
Cultura, diretto dal cardinale Gianfranco Ravasi, ha organizzato numerosi incontri fra credenti e non credenti
in varie nazioni del mondo. Ravasi parla di una Chiesa che riconosce l’esistenza di «visioni diverse della realtà»
ed è disposta a misurarsi con il fatto che il credente e l’ateo sono entrambi portatori di un messaggio