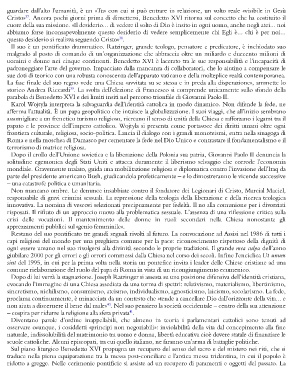Page 17 - Francesco tra i lupi
P. 17
guardare dall’alto l’umanità, è un «Tu» con cui si può entrare in relazione, un volto reale «visibile in Gesù
37
Cristo» . Ancora pochi giorni prima di dimettersi, Benedetto XVI ritorna sul concetto che ha costituito il
cuore della sua missione. «Il desiderio... di vedere il volto di Dio è insito in ogni uomo, anche negli atei... noi
abbiamo forse inconsapevolmente questo desiderio di vedere semplicemente chi Egli è... chi è per noi...
38
questo desiderio si realizza seguendo Cristo» .
Il suo è un pontificato drammatico. Ratzinger, grande teologo, pensatore e predicatore, è inchiodato suo
malgrado al posto di comando di un’organizzazione che abbraccia oltre un miliardo e duecento milioni di
uomini e donne nei cinque continenti. Benedetto XVI è lacerato tra le sue responsabilità e l’incapacità di
padroneggiare l’arte del governo. Impacciato dalla mancanza di collaboratori, che lo aiutino a compensare le
sue doti di teorico con una robusta conoscenza dell’apparato vaticano e della molteplice realtà contemporanea.
La fase finale del suo regno vede una Chiesa «avvitata su se stessa e in preda alla disperazione», ammette lo
39
storico Andrea Riccardi . La svolta dell’elezione di Francesco si comprende unicamente sullo sfondo della
parabola di Benedetto XVI e dei limiti insiti nel percorso trionfale di Giovanni Paolo II.
Karol Wojtyla interpreta la salvaguardia dell’identità cattolica in modo dinamico. Non difende la fede, ne
afferma l’attualità. È un papa geopolitico che intuisce la globalizzazione. I suoi viaggi, che all’inizio sembrano
assomigliare a un frenetico turismo religioso, ricreano il senso di unità della Chiesa e rafforzano i legami tra il
papato e le province dell’impero cattolico. Wojtyla si presenta come portavoce dei diritti umani oltre ogni
frontiera culturale, religiosa, socio-politica. Lancia il dialogo con i grandi monoteismi, entra nella sinagoga di
Roma e nella moschea di Damasco per cementare la fede nel Dio Unico e contrastare il fondamentalismo e il
terrorismo di matrice religiosa.
Dopo il crollo dell’Unione sovietica e la liberazione della Polonia sua patria, Giovanni Paolo II denuncia la
solitudine egemonica degli Stati Uniti e attacca duramente il liberismo selvaggio che corrode l’economia
mondiale. Gravemente malato, guida una mobilitazione religiosa e diplomatica contro l’invasione dell’Iraq da
parte del presidente americano Bush, giudicandola profeticamente – e lo dimostreranno le vicende successive
– una catastrofe politica e umanitaria.
Non mancano ombre. Le denunce insabbiate contro il fondatore dei Legionari di Cristo, Marcial Maciel,
responsabile di gravi crimini sessuali. La repressione della teologia della liberazione e della ricerca teologica
innovativa. La nomina di vescovi selezionati precipuamente per fedeltà. Il no alla comunione per i divorziati
risposati. Il rifiuto di un approccio nuovo alla problematica sessuale. L’assenza di una riflessione critica sulla
crisi delle vocazioni. Il mantenimento delle donne in ruoli secondari nella Chiesa nonostante gli
apprezzamenti pubblici sul «genio femminile».
Restano del suo pontificato tre grandi segnali rivolti al futuro. La convocazione ad Assisi nel 1986 di tutti i
capi religiosi del mondo per una preghiera comune per la pace: riconoscimento rispettoso della dignità di
ogni essere umano nel suo rivolgersi alla divinità secondo le proprie tradizioni. Il grande mea culpa dell’anno
giubilare 2000 per gli errori e gli orrori commessi dalla Chiesa nel corso dei secoli. Infine l’enciclica Ut unum
sint del 1995, in cui per la prima volta nella storia un pontefice invita i leader delle Chiese cristiane ad una
comune rielaborazione del ruolo del papa di Roma in vista di un ricongiungimento ecumenico.
Dopo di lui verrà la stagnazione. Joseph Ratzinger si assesta su una posizione difensiva dell’identità cristiana,
evocando l’immagine di una Chiesa assediata da una torma di spettri: relativismo, materialismo, libertinismo,
sincretismo, nichilismo, consumismo, ateismo, individualismo, agnosticismo, laicismo, secolarismo. La fede,
proclama continuamente, è minacciata da un contesto che «tende a cancellare Dio dall’orizzonte della vita... e
40
non aiuta a discernere il bene dal male» . Nel suo pensiero la società occidentale – centro della sua attenzione
41
– cospira per ridurre la religione alla sfera privata .
Diventano parole d’ordine inappellabili, che almeno in teoria i parlamentari cattolici sono tenuti ad
osservare ovunque, i cosiddetti «principi non negoziabili»: inviolabilità della vita dal concepimento alla fine
naturale, indissolubilità del matrimonio tra uomo e donna, libertà educativa cioè dovere statale di finanziare le
scuole cattoliche. Alcuni episcopati, tra cui quello italiano, ne faranno un’arma di battaglie politiche.
Sul piano liturgico Benedetto XVI propugna un recupero del senso del sacro e del mistero nei riti, che si
traduce nella piena equiparazione tra la messa post-conciliare e l’antica messa tridentina, in cui il popolo è
ridotto a gregge. Nelle cerimonie pontificie si assiste ad un recupero di paramenti e oggetti del passato. La