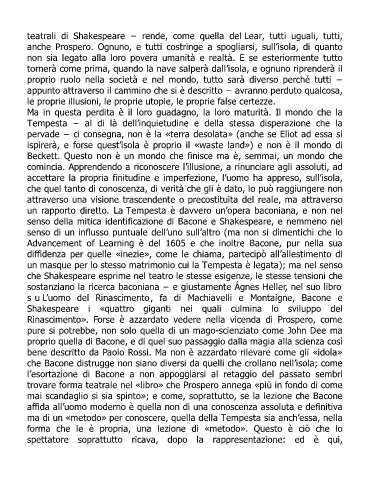Page 892 - Shakespeare - Vol. 4
P. 892
teatrali di Shakespeare − rende, come quella del Lear, tutti uguali, tutti,
anche Prospero. Ognuno, e tutti costringe a spogliarsi, sull’isola, di quanto
non sia legato alla loro povera umanità e realtà. E se esteriormente tutto
tornerà come prima, quando la nave salperà dall’isola, e ognuno riprenderà il
proprio ruolo nella società e nel mondo, tutto sarà diverso perché tutti −
appunto attraverso il cammino che si è descritto − avranno perduto qualcosa,
le proprie illusioni, le proprie utopie, le proprie false certezze.
Ma in questa perdita è il loro guadagno, la loro maturità. Il mondo che la
Tempesta − al di là dell’inquietudine e della stessa disperazione che la
pervade − ci consegna, non è la «terra desolata» (anche se Eliot ad essa si
ispirerà, e forse quest’isola è proprio il «waste land») e non è il mondo di
Beckett. Questo non è un mondo che finisce ma è, semmai, un mondo che
comincia. Apprendendo a riconoscere l’illusione, a rinunciare agli assoluti, ad
accettare la propria finitudine e imperfezione, l’uomo ha appreso, sull’isola,
che quel tanto di conoscenza, di verità che gli è dato, lo può raggiungere non
attraverso una visione trascendente o precostituita del reale, ma attraverso
un rapporto diretto. La Tempesta è davvero un’opera baconiana, e non nel
senso della mitica identificazione di Bacone e Shakespeare, e nemmeno nel
senso di un influsso puntuale dell’uno sull’altro (ma non si dimentichi che lo
Advancement of Learning è del 1605 e che inoltre Bacone, pur nella sua
diffidenza per quelle «inezie», come le chiama, partecipò all’allestimento di
un masque per lo stesso matrimonio cui la Tempesta è legata); ma nel senso
che Shakespeare esprime nel teatro le stesse esigenze, le stesse tensioni che
sostanziano la ricerca baconiana − e giustamente Ágnes Heller, nel suo libro
s u L’uomo del Rinascimento, fa di Machiavelli e Montaigne, Bacone e
Shakespeare i «quattro giganti nei quali culmina lo sviluppo del
Rinascimento». Forse è azzardato vedere nella vicenda di Prospero, come
pure si potrebbe, non solo quella di un mago-scienziato come John Dee ma
proprio quella di Bacone, e di quel suo passaggio dalla magia alla scienza così
bene descritto da Paolo Rossi. Ma non è azzardato rilevare come gli «idola»
che Bacone distrugge non siano diversi da quelli che crollano nell’isola; come
l’esortazione di Bacone a non appoggiarsi al retaggio del passato sembri
trovare forma teatrale nel «libro» che Prospero annega «più in fondo di come
mai scandaglio si sia spinto»; e come, soprattutto, se la lezione che Bacone
affida all’uomo moderno è quella non di una conoscenza assoluta e definitiva
ma di un «metodo» per conoscere, quella della Tempesta sia anch’essa, nella
forma che le è propria, una lezione di «metodo». Questo è ciò che lo
spettatore soprattutto ricava, dopo la rappresentazione: ed è qui,