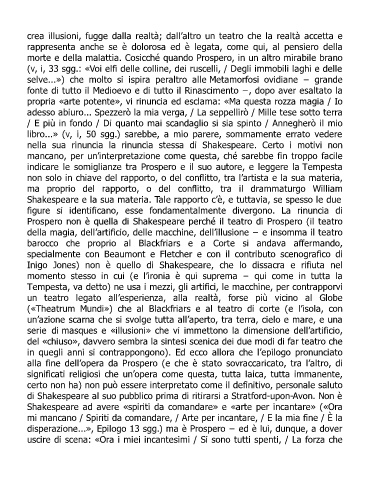Page 887 - Shakespeare - Vol. 4
P. 887
crea illusioni, fugge dalla realtà; dall’altro un teatro che la realtà accetta e
rappresenta anche se è dolorosa ed è legata, come qui, al pensiero della
morte e della malattia. Cosicché quando Prospero, in un altro mirabile brano
(V, i, 33 sgg.: «Voi elfi delle colline, dei ruscelli, / Degli immobili laghi e delle
selve...») che molto si ispira peraltro alle Metamorfosi ovidiane − grande
fonte di tutto il Medioevo e di tutto il Rinascimento −, dopo aver esaltato la
propria «arte potente», vi rinuncia ed esclama: «Ma questa rozza magia / Io
adesso abiuro... Spezzerò la mia verga, / La seppellirò / Mille tese sotto terra
/ E più in fondo / Di quanto mai scandaglio si sia spinto / Annegherò il mio
libro...» (V, i, 50 sgg.) sarebbe, a mio parere, sommamente errato vedere
nella sua rinuncia la rinuncia stessa di Shakespeare. Certo i motivi non
mancano, per un’interpretazione come questa, ché sarebbe fin troppo facile
indicare le somiglianze tra Prospero e il suo autore, e leggere la Tempesta
non solo in chiave del rapporto, o del conflitto, tra l’artista e la sua materia,
ma proprio del rapporto, o del conflitto, tra il drammaturgo William
Shakespeare e la sua materia. Tale rapporto c’è, e tuttavia, se spesso le due
figure si identificano, esse fondamentalmente divergono. La rinuncia di
Prospero non è quella di Shakespeare perché il teatro di Prospero (il teatro
della magia, dell’artificio, delle macchine, dell’illusione − e insomma il teatro
barocco che proprio al Blackfriars e a Corte si andava affermando,
specialmente con Beaumont e Fletcher e con il contributo scenografico di
Inigo Jones) non è quello di Shakespeare, che lo dissacra e rifiuta nel
momento stesso in cui (e l’ironia è qui suprema − qui come in tutta la
Tempesta, va detto) ne usa i mezzi, gli artifici, le macchine, per contrapporvi
un teatro legato all’esperienza, alla realtà, forse più vicino al Globe
(«Theatrum Mundi») che al Blackfriars e al teatro di corte (e l’isola, con
un’azione scarna che si svolge tutta all’aperto, tra terra, cielo e mare, e una
serie di masques e «illusioni» che vi immettono la dimensione dell’artificio,
del «chiuso», davvero sembra la sintesi scenica dei due modi di far teatro che
in quegli anni si contrappongono). Ed ecco allora che l’epilogo pronunciato
alla fine dell’opera da Prospero (e che è stato sovraccaricato, tra l’altro, di
significati religiosi che un’opera come questa, tutta laica, tutta immanente,
certo non ha) non può essere interpretato come il definitivo, personale saluto
di Shakespeare al suo pubblico prima di ritirarsi a Stratford-upon-Avon. Non è
Shakespeare ad avere «spiriti da comandare» e «arte per incantare» («Ora
mi mancano / Spiriti da comandare, / Arte per incantare, / E la mia fine / È la
disperazione...», Epilogo 13 sgg.) ma è Prospero − ed è lui, dunque, a dover
uscire di scena: «Ora i miei incantesimi / Si sono tutti spenti, / La forza che