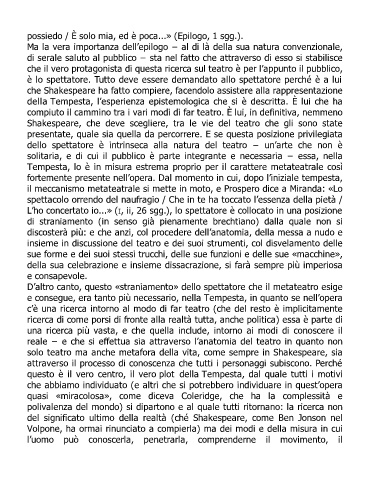Page 888 - Shakespeare - Vol. 4
P. 888
possiedo / È solo mia, ed è poca...» (Epilogo, 1 sgg.).
Ma la vera importanza dell’epilogo − al di là della sua natura convenzionale,
di serale saluto al pubblico − sta nel fatto che attraverso di esso si stabilisce
che il vero protagonista di questa ricerca sul teatro è per l’appunto il pubblico,
è lo spettatore. Tutto deve essere demandato allo spettatore perché è a lui
che Shakespeare ha fatto compiere, facendolo assistere alla rappresentazione
della Tempesta, l’esperienza epistemologica che si è descritta. È lui che ha
compiuto il cammino tra i vari modi di far teatro. È lui, in definitiva, nemmeno
Shakespeare, che deve scegliere, tra le vie del teatro che gli sono state
presentate, quale sia quella da percorrere. E se questa posizione privilegiata
dello spettatore è intrinseca alla natura del teatro − un’arte che non è
solitaria, e di cui il pubblico è parte integrante e necessaria − essa, nella
Tempesta, lo è in misura estrema proprio per il carattere metateatrale così
fortemente presente nell’opera. Dal momento in cui, dopo l’iniziale tempesta,
il meccanismo metateatrale si mette in moto, e Prospero dice a Miranda: «Lo
spettacolo orrendo del naufragio / Che in te ha toccato l’essenza della pietà /
L’ho concertato io...» (I, ii, 26 sgg.), lo spettatore è collocato in una posizione
di straniamento (in senso già pienamente brechtiano) dalla quale non si
discosterà più: e che anzi, col procedere dell’anatomia, della messa a nudo e
insieme in discussione del teatro e dei suoi strumenti, col disvelamento delle
sue forme e dei suoi stessi trucchi, delle sue funzioni e delle sue «macchine»,
della sua celebrazione e insieme dissacrazione, si farà sempre più imperiosa
e consapevole.
D’altro canto, questo «straniamento» dello spettatore che il metateatro esige
e consegue, era tanto più necessario, nella Tempesta, in quanto se nell’opera
c’è una ricerca intorno al modo di far teatro (che del resto è implicitamente
ricerca di come porsi di fronte alla realtà tutta, anche politica) essa è parte di
una ricerca più vasta, e che quella include, intorno ai modi di conoscere il
reale − e che si effettua sia attraverso l’anatomia del teatro in quanto non
solo teatro ma anche metafora della vita, come sempre in Shakespeare, sia
attraverso il processo di conoscenza che tutti i personaggi subiscono. Perché
questo è il vero centro, il vero plot della Tempesta, dal quale tutti i motivi
che abbiamo individuato (e altri che si potrebbero individuare in quest’opera
quasi «miracolosa», come diceva Coleridge, che ha la complessità e
polivalenza del mondo) si dipartono e al quale tutti ritornano: la ricerca non
del significato ultimo della realtà (ché Shakespeare, come Ben Jonson nel
Volpone, ha ormai rinunciato a compierla) ma dei modi e della misura in cui
l’uomo può conoscerla, penetrarla, comprenderne il movimento, il