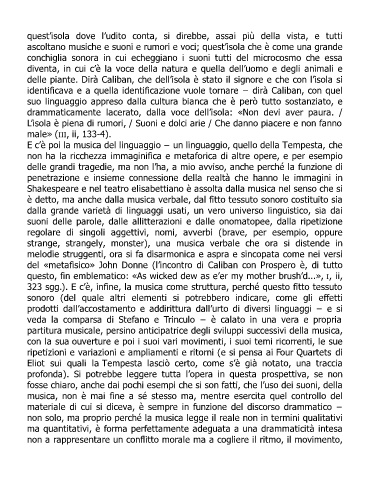Page 883 - Shakespeare - Vol. 4
P. 883
quest’isola dove l’udito conta, si direbbe, assai più della vista, e tutti
ascoltano musiche e suoni e rumori e voci; quest’isola che è come una grande
conchiglia sonora in cui echeggiano i suoni tutti del microcosmo che essa
diventa, in cui c’è la voce della natura e quella dell’uomo e degli animali e
delle piante. Dirà Caliban, che dell’isola è stato il signore e che con l’isola si
identificava e a quella identificazione vuole tornare − dirà Caliban, con quel
suo linguaggio appreso dalla cultura bianca che è però tutto sostanziato, e
drammaticamente lacerato, dalla voce dell’isola: «Non devi aver paura. /
L’isola è piena di rumori, / Suoni e dolci arie / Che danno piacere e non fanno
male» (III, ii, 133-4).
E c’è poi la musica del linguaggio − un linguaggio, quello della Tempesta, che
non ha la ricchezza immaginifica e metaforica di altre opere, e per esempio
delle grandi tragedie, ma non l’ha, a mio avviso, anche perché la funzione di
penetrazione e insieme connessione della realtà che hanno le immagini in
Shakespeare e nel teatro elisabettiano è assolta dalla musica nel senso che si
è detto, ma anche dalla musica verbale, dal fitto tessuto sonoro costituito sia
dalla grande varietà di linguaggi usati, un vero universo linguistico, sia dai
suoni delle parole, dalle allitterazioni e dalle onomatopee, dalla ripetizione
regolare di singoli aggettivi, nomi, avverbi (brave, per esempio, oppure
strange, strangely, monster), una musica verbale che ora si distende in
melodie struggenti, ora si fa disarmonica e aspra e sincopata come nei versi
del «metafisico» John Donne (l’incontro di Caliban con Prospero è, di tutto
questo, fin emblematico: «As wicked dew as e’er my mother brush’d...», I, ii,
323 sgg.). E c’è, infine, la musica come struttura, perché questo fitto tessuto
sonoro (del quale altri elementi si potrebbero indicare, come gli effetti
prodotti dall’accostamento e addirittura dall’urto di diversi linguaggi − e si
veda la comparsa di Stefano e Trinculo − è calato in una vera e propria
partitura musicale, persino anticipatrice degli sviluppi successivi della musica,
con la sua ouverture e poi i suoi vari movimenti, i suoi temi ricorrenti, le sue
ripetizioni e variazioni e ampliamenti e ritorni (e si pensa ai Four Quartets di
Eliot sui quali la Tempesta lasciò certo, come s’è già notato, una traccia
profonda). Si potrebbe leggere tutta l’opera in questa prospettiva, se non
fosse chiaro, anche dai pochi esempi che si son fatti, che l’uso dei suoni, della
musica, non è mai fine a sé stesso ma, mentre esercita quel controllo del
materiale di cui si diceva, è sempre in funzione del discorso drammatico −
non solo, ma proprio perché la musica legge il reale non in termini qualitativi
ma quantitativi, è forma perfettamente adeguata a una drammaticità intesa
non a rappresentare un conflitto morale ma a cogliere il ritmo, il movimento,