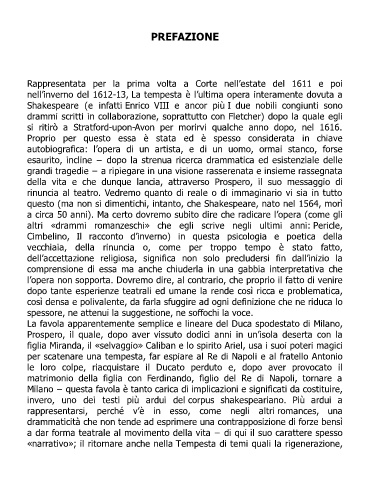Page 880 - Shakespeare - Vol. 4
P. 880
PREFAZIONE
Rappresentata per la prima volta a Corte nell’estate del 1611 e poi
nell’inverno del 1612-13, La tempesta è l’ultima opera interamente dovuta a
Shakespeare (e infatti Enrico VIII e ancor più I due nobili congiunti sono
drammi scritti in collaborazione, soprattutto con Fletcher) dopo la quale egli
si ritirò a Stratford-upon-Avon per morirvi qualche anno dopo, nel 1616.
Proprio per questo essa è stata ed è spesso considerata in chiave
autobiografica: l’opera di un artista, e di un uomo, ormai stanco, forse
esaurito, incline − dopo la strenua ricerca drammatica ed esistenziale delle
grandi tragedie − a ripiegare in una visione rasserenata e insieme rassegnata
della vita e che dunque lancia, attraverso Prospero, il suo messaggio di
rinuncia al teatro. Vedremo quanto di reale o di immaginario vi sia in tutto
questo (ma non si dimentichi, intanto, che Shakespeare, nato nel 1564, morì
a circa 50 anni). Ma certo dovremo subito dire che radicare l’opera (come gli
altri «drammi romanzeschi» che egli scrive negli ultimi anni: Pericle,
Cimbelino, Il racconto d’inverno) in questa psicologia e poetica della
vecchiaia, della rinuncia o, come per troppo tempo è stato fatto,
dell’accettazione religiosa, significa non solo precludersi fin dall’inizio la
comprensione di essa ma anche chiuderla in una gabbia interpretativa che
l’opera non sopporta. Dovremo dire, al contrario, che proprio il fatto di venire
dopo tante esperienze teatrali ed umane la rende così ricca e problematica,
così densa e polivalente, da farla sfuggire ad ogni definizione che ne riduca lo
spessore, ne attenui la suggestione, ne soffochi la voce.
La favola apparentemente semplice e lineare del Duca spodestato di Milano,
Prospero, il quale, dopo aver vissuto dodici anni in un’isola deserta con la
figlia Miranda, il «selvaggio» Caliban e lo spirito Ariel, usa i suoi poteri magici
per scatenare una tempesta, far espiare al Re di Napoli e al fratello Antonio
le loro colpe, riacquistare il Ducato perduto e, dopo aver provocato il
matrimonio della figlia con Ferdinando, figlio del Re di Napoli, tornare a
Milano − questa favola è tanto carica di implicazioni e significati da costituire,
invero, uno dei testi più ardui del corpus shakespeariano. Più ardui a
rappresentarsi, perché v’è in esso, come negli altri romances, una
drammaticità che non tende ad esprimere una contrapposizione di forze bensì
a dar forma teatrale al movimento della vita − di qui il suo carattere spesso
«narrativo»; il ritornare anche nella Tempesta di temi quali la rigenerazione,