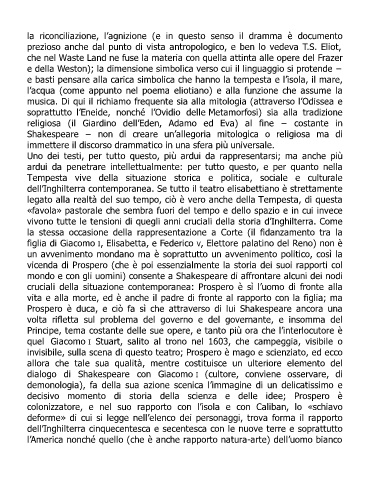Page 881 - Shakespeare - Vol. 4
P. 881
la riconciliazione, l’agnizione (e in questo senso il dramma è documento
prezioso anche dal punto di vista antropologico, e ben lo vedeva T.S. Eliot,
che nel Waste Land ne fuse la materia con quella attinta alle opere del Frazer
e della Weston); la dimensione simbolica verso cui il linguaggio si protende −
e basti pensare alla carica simbolica che hanno la tempesta e l’isola, il mare,
l’acqua (come appunto nel poema eliotiano) e alla funzione che assume la
musica. Di qui il richiamo frequente sia alla mitologia (attraverso l’Odissea e
soprattutto l’Eneide, nonché l’Ovidio delle Metamorfosi) sia alla tradizione
religiosa (il Giardino dell’Eden, Adamo ed Eva) al fine − costante in
Shakespeare − non di creare un’allegoria mitologica o religiosa ma di
immettere il discorso drammatico in una sfera più universale.
Uno dei testi, per tutto questo, più ardui da rappresentarsi; ma anche più
ardui da penetrare intellettualmente: per tutto questo, e per quanto nella
Tempesta vive della situazione storica e politica, sociale e culturale
dell’Inghilterra contemporanea. Se tutto il teatro elisabettiano è strettamente
legato alla realtà del suo tempo, ciò è vero anche della Tempesta, di questa
«favola» pastorale che sembra fuori del tempo e dello spazio e in cui invece
vivono tutte le tensioni di quegli anni cruciali della storia d’Inghilterra. Come
la stessa occasione della rappresentazione a Corte (il fidanzamento tra la
figlia di Giacomo I, Elisabetta, e Federico V, Elettore palatino del Reno) non è
un avvenimento mondano ma è soprattutto un avvenimento politico, così la
vicenda di Prospero (che è poi essenzialmente la storia dei suoi rapporti col
mondo e con gli uomini) consente a Shakespeare di affrontare alcuni dei nodi
cruciali della situazione contemporanea: Prospero è sì l’uomo di fronte alla
vita e alla morte, ed è anche il padre di fronte al rapporto con la figlia; ma
Prospero è duca, e ciò fa sì che attraverso di lui Shakespeare ancora una
volta rifletta sul problema del governo e del governante, e insomma del
Principe, tema costante delle sue opere, e tanto più ora che l’interlocutore è
quel Giacomo I Stuart, salito al trono nel 1603, che campeggia, visibile o
invisibile, sulla scena di questo teatro; Prospero è mago e scienziato, ed ecco
allora che tale sua qualità, mentre costituisce un ulteriore elemento del
dialogo di Shakespeare con Giacomo I (cultore, conviene osservare, di
demonologia), fa della sua azione scenica l’immagine di un delicatissimo e
decisivo momento di storia della scienza e delle idee; Prospero è
colonizzatore, e nel suo rapporto con l’isola e con Caliban, lo «schiavo
deforme» di cui si legge nell’elenco dei personaggi, trova forma il rapporto
dell’Inghilterra cinquecentesca e secentesca con le nuove terre e soprattutto
l’America nonché quello (che è anche rapporto natura-arte) dell’uomo bianco