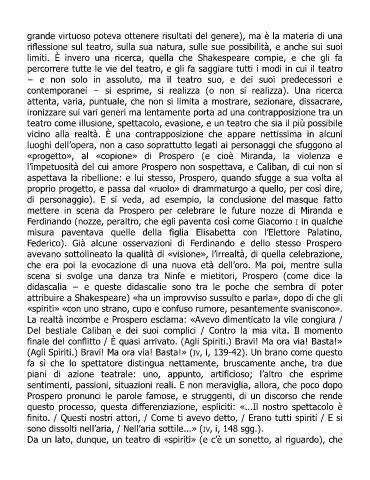Page 886 - Shakespeare - Vol. 4
P. 886
grande virtuoso poteva ottenere risultati del genere), ma è la materia di una
riflessione sul teatro, sulla sua natura, sulle sue possibilità, e anche sui suoi
limiti. È invero una ricerca, quella che Shakespeare compie, e che gli fa
percorrere tutte le vie del teatro, e gli fa saggiare tutti i modi in cui il teatro
− e non solo in assoluto, ma il teatro suo, e dei suoi predecessori e
contemporanei − si esprime, si realizza (o non si realizza). Una ricerca
attenta, varia, puntuale, che non si limita a mostrare, sezionare, dissacrare,
ironizzare sui vari generi ma lentamente porta ad una contrapposizione tra un
teatro come illusione, spettacolo, evasione, e un teatro che sia il più possibile
vicino alla realtà. È una contrapposizione che appare nettissima in alcuni
luoghi dell’opera, non a caso soprattutto legati ai personaggi che sfuggono al
«progetto», al «copione» di Prospero (e cioè Miranda, la violenza e
l’impetuosità del cui amore Prospero non sospettava, e Caliban, di cui non si
aspettava la ribellione: e lui stesso, Prospero, quando sfugge a sua volta al
proprio progetto, e passa dal «ruolo» di drammaturgo a quello, per così dire,
di personaggio). E si veda, ad esempio, la conclusione del masque fatto
mettere in scena da Prospero per celebrare le future nozze di Miranda e
Ferdinando (nozze, peraltro, che egli paventa così come Giacomo I in qualche
misura paventava quelle della figlia Elisabetta con l’Elettore Palatino,
Federico). Già alcune osservazioni di Ferdinando e dello stesso Prospero
avevano sottolineato la qualità di «visione», l’irrealtà, di quella celebrazione,
che era poi la evocazione di una nuova età dell’oro. Ma poi, mentre sulla
scena si svolge una danza tra Ninfe e mietitori, Prospero (come dice la
didascalia − e queste didascalie sono tra le poche che sembra di poter
attribuire a Shakespeare) «ha un improvviso sussulto e parla», dopo di che gli
«spiriti» «con uno strano, cupo e confuso rumore, pesantemente svaniscono».
La realtà incombe e Prospero esclama: «Avevo dimenticato la vile congiura /
Del bestiale Caliban e dei suoi complici / Contro la mia vita. Il momento
finale del conflitto / È quasi arrivato. (Agli Spiriti.) Bravi! Ma ora via! Basta!»
(Agli Spiriti.) Bravi! Ma ora via! Basta!» (IV, i, 139-42). Un brano come questo
fa sì che lo spettatore distingua nettamente, bruscamente anche, tra due
piani di azione teatrale: uno, appunto, artificioso; l’altro che esprime
sentimenti, passioni, situazioni reali. E non meraviglia, allora, che poco dopo
Prospero pronunci le parole famose, e struggenti, di un discorso che rende
questo processo, questa differenziazione, espliciti: «...Il nostro spettacolo è
finito. / Questi nostri attori, / Come ti avevo detto, / Erano tutti spiriti / E si
sono dissolti nell’aria, / Nell’aria sottile...» (IV, i, 148 sgg.).
Da un lato, dunque, un teatro di «spiriti» (e c’è un sonetto, al riguardo), che