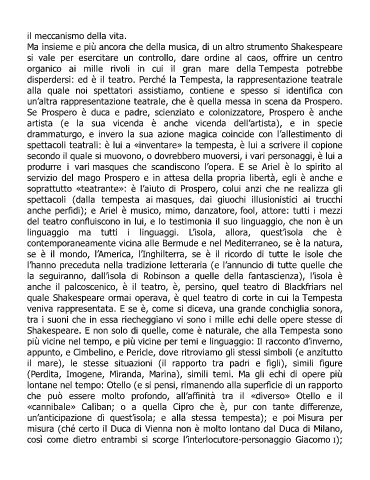Page 884 - Shakespeare - Vol. 4
P. 884
il meccanismo della vita.
Ma insieme e più ancora che della musica, di un altro strumento Shakespeare
si vale per esercitare un controllo, dare ordine al caos, offrire un centro
organico ai mille rivoli in cui il gran mare della Tempesta potrebbe
disperdersi: ed è il teatro. Perché la Tempesta, la rappresentazione teatrale
alla quale noi spettatori assistiamo, contiene e spesso si identifica con
un’altra rappresentazione teatrale, che è quella messa in scena da Prospero.
Se Prospero è duca e padre, scienziato e colonizzatore, Prospero è anche
artista (e la sua vicenda è anche vicenda dell’artista), e in specie
drammaturgo, e invero la sua azione magica coincide con l’allestimento di
spettacoli teatrali: è lui a «inventare» la tempesta, è lui a scrivere il copione
secondo il quale si muovono, o dovrebbero muoversi, i vari personaggi, è lui a
produrre i vari masques che scandiscono l’opera. E se Ariel è lo spirito al
servizio del mago Prospero e in attesa della propria libertà, egli è anche e
soprattutto «teatrante»: è l’aiuto di Prospero, colui anzi che ne realizza gli
spettacoli (dalla tempesta ai masques, dai giuochi illusionistici ai trucchi
anche perfidi); e Ariel è musico, mimo, danzatore, fool, attore: tutti i mezzi
del teatro confluiscono in lui, e lo testimonia il suo linguaggio, che non è un
linguaggio ma tutti i linguaggi. L’isola, allora, quest’isola che è
contemporaneamente vicina alle Bermude e nel Mediterraneo, se è la natura,
se è il mondo, l’America, l’Inghilterra, se è il ricordo di tutte le isole che
l’hanno preceduta nella tradizione letteraria (e l’annuncio di tutte quelle che
la seguiranno, dall’isola di Robinson a quelle della fantascienza), l’isola è
anche il palcoscenico, è il teatro, è, persino, quel teatro di Blackfriars nel
quale Shakespeare ormai operava, è quel teatro di corte in cui la Tempesta
veniva rappresentata. E se è, come si diceva, una grande conchiglia sonora,
tra i suoni che in essa riecheggiano vi sono i mille echi delle opere stesse di
Shakespeare. E non solo di quelle, come è naturale, che alla Tempesta sono
più vicine nel tempo, e più vicine per temi e linguaggio: Il racconto d’inverno,
appunto, e Cimbelino, e Pericle, dove ritroviamo gli stessi simboli (e anzitutto
il mare), le stesse situazioni (il rapporto tra padri e figli), simili figure
(Perdita, Imogene, Miranda, Marina), simili temi. Ma gli echi di opere più
lontane nel tempo: Otello (e si pensi, rimanendo alla superficie di un rapporto
che può essere molto profondo, all’affinità tra il «diverso» Otello e il
«cannibale» Caliban; o a quella Cipro che è, pur con tante differenze,
un’anticipazione di quest’isola; e alla stessa tempesta); e poi Misura per
misura (ché certo il Duca di Vienna non è molto lontano dal Duca di Milano,
così come dietro entrambi si scorge l’interlocutore-personaggio Giacomo I);