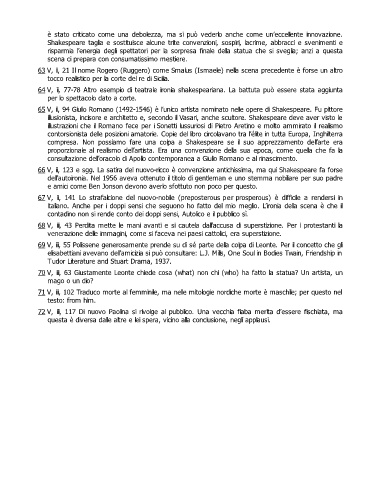Page 878 - Shakespeare - Vol. 4
P. 878
è stato criticato come una debolezza, ma si può vederlo anche come un’eccellente innovazione.
Shakespeare taglia e sostituisce alcune trite convenzioni, sospiri, lacrime, abbracci e svenimenti e
risparmia l’energia degli spettatori per la sorpresa finale della statua che si sveglia; anzi a questa
scena ci prepara con consumatissimo mestiere.
63 V, ii, 21 Il nome Rogero (Ruggero) come Smalus (Ismaele) nella scena precedente è forse un altro
tocco realistico per la corte del re di Sicilia.
64 V, ii, 77-78 Altro esempio di teatrale ironia shakespeariana. La battuta può essere stata aggiunta
per lo spettacolo dato a corte.
65 V, ii, 94 Giulio Romano (1492-1546) è l’unico artista nominato nelle opere di Shakespeare. Fu pittore
illusionista, incisore e architetto e, secondo il Vasari, anche scultore. Shakespeare deve aver visto le
illustrazioni che il Romano fece per i Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino e molto ammirato il realismo
contorsionista delle posizioni amatorie. Copie del libro circolavano tra l’élite in tutta Europa, Inghilterra
compresa. Non possiamo fare una colpa a Shakespeare se il suo apprezzamento dell’arte era
proporzionale al realismo dell’artista. Era una convenzione della sua epoca, come quella che fa la
consultazione dell’oracolo di Apollo contemporanea a Giulio Romano e al rinascimento.
66 V, ii, 123 e sgg. La satira del nuovo-ricco è convenzione antichissima, ma qui Shakespeare fa forse
dell’autoironia. Nel 1956 aveva ottenuto il titolo di gentleman e uno stemma nobiliare per suo padre
e amici come Ben Jonson devono averlo sfottuto non poco per questo.
67 V, ii, 141 Lo strafalcione del nuovo-nobile (preposterous per prosperous) è difficile a rendersi in
italiano. Anche per i doppi sensi che seguono ho fatto del mio meglio. L’ironia della scena è che il
contadino non si rende conto dei doppi sensi, Autolico e il pubblico sì.
68 V, iii, 43 Perdita mette le mani avanti e si cautela dall’accusa di superstizione. Per i protestanti la
venerazione delle immagini, come si faceva nei paesi cattolici, era superstizione.
69 V, iii, 55 Polissene generosamente prende su di sé parte della colpa di Leonte. Per il concetto che gli
elisabettiani avevano dell’amicizia si può consultare: L.J. Mills, One Soul in Bodies Twain, Friendship in
Tudor Literature and Stuart Drama, 1937.
70 V, iii, 63 Giustamente Leonte chiede cosa (what) non chi (who) ha fatto la statua? Un artista, un
mago o un dio?
71 V, iii, 102 Traduco morte al femminile, ma nelle mitologie nordiche morte è maschile; per questo nel
testo: from him.
72 V, iii, 117 Di nuovo Paolina si rivolge al pubblico. Una vecchia fiaba merita d’essere fischiata, ma
questa è diversa dalle altre e lei spera, vicino alla conclusione, negli applausi.