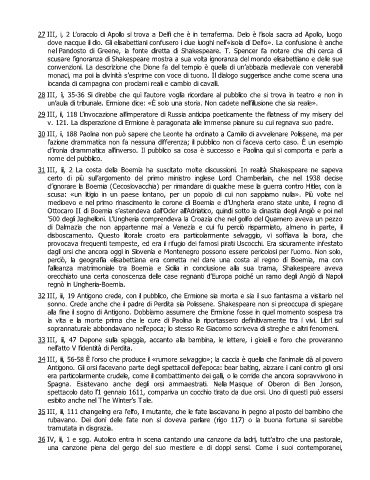Page 875 - Shakespeare - Vol. 4
P. 875
27 III, i, 2 L’oracolo di Apollo si trova a Delfi che è in terraferma. Delo è l’isola sacra ad Apollo, luogo
dove nacque il dio. Gli elisabettiani confusero i due luoghi nell’«isola di Delfo». La confusione è anche
nel Pandosto di Greene, la fonte diretta di Shakespeare. T. Spencer fa notare che chi cerca di
scusare l’ignoranza di Shakespeare mostra a sua volta ignoranza del mondo elisabettiano e delle sue
convenzioni. La descrizione che Dione fa del tempio è quella di un’abbazia medievale con venerabili
monaci, ma poi la divinità s’esprime con voce di tuono. Il dialogo suggerisce anche come scena una
locanda di campagna con proclami reali e cambio di cavalli.
28 III, ii, 35-36 Si direbbe che qui l’autore voglia ricordare al pubblico che si trova in teatro e non in
un’aula di tribunale. Ermione dice: «È solo una storia. Non cadete nell’illusione che sia reale».
29 III, ii, 118 L’invocazione all’imperatore di Russia anticipa poeticamente the flatness of my misery del
v. 121. La disperazione di Ermione è paragonata alle immense pianure su cui regnava suo padre.
30 III, ii, 188 Paolina non può sapere che Leonte ha ordinato a Camillo di avvelenare Polissene, ma per
l’azione drammatica non fa nessuna differenza; il pubblico non ci faceva certo caso. È un esempio
d’ironia drammatica all’inverso. Il pubblico sa cosa è successo e Paolina qui si comporta e parla a
nome del pubblico.
31 III, iii, 2 La costa della Boemia ha suscitato molte discussioni. In realtà Shakespeare ne sapeva
certo di più sull’argomento del primo ministro inglese Lord Chamberlain, che nel 1938 decise
d’ignorare la Boemia (Cecoslovacchia) per rimandare di qualche mese la guerra contro Hitler, con la
scusa: «un litigio in un paese lontano, per un popolo di cui non sappiamo nulla». Più volte nel
medioevo e nel primo rinascimento le corone di Boemia e d’Ungheria erano state unite, il regno di
Ottocaro II di Boemia s’estendeva dall’Oder all’Adriatico, quindi sotto la dinastia degli Angiò e poi nel
’500 degli Jaghelloni. L’Ungheria comprendeva la Croazia che nel golfo del Quarnero aveva un pezzo
di Dalmazia che non appartenne mai a Venezia e cui fu perciò risparmiato, almeno in parte, il
disboscamento. Questo litorale croato era particolarmente selvaggio, vi soffiava la bora, che
provocava frequenti tempeste, ed era il rifugio dei famosi pirati Uscocchi. Era sicuramente infestato
dagli orsi che ancora oggi in Slovenia e Montenegro possono essere pericolosi per l’uomo. Non solo,
perciò, la geografia elisabettiana era corretta nel dare una costa al regno di Boemia, ma con
l’alleanza matrimoniale tra Boemia e Sicilia in conclusione alla sua trama, Shakespeare aveva
orecchiato una certa conoscenza delle case regnanti d’Europa poiché un ramo degli Angiò di Napoli
regnò in Ungheria-Boemia.
32 III, iii, 19 Antigono crede, con il pubblico, che Ermione sia morta e sia il suo fantasma a visitarlo nel
sonno. Crede anche che il padre di Perdita sia Polissene. Shakespeare non si preoccupa di spiegare
alla fine il sogno di Antigono. Dobbiamo assumere che Ermione fosse in quel momento sospesa tra
la vita e la morte prima che le cure di Paolina la riportassero definitivamente tra i vivi. Libri sul
soprannaturale abbondavano nell’epoca; lo stesso Re Giacomo scriveva di streghe e altri fenomeni.
33 III, iii, 47 Depone sulla spiaggia, accanto alla bambina, le lettere, i gioielli e l’oro che proveranno
nell’atto V l’identità di Perdita.
34 III, iii, 56-58 È l’orso che produce il «rumore selvaggio»; la caccia è quella che l’animale dà al povero
Antigono. Gli orsi facevano parte degli spettacoli dell’epoca: bear baiting, aizzare i cani contro gli orsi
era particolarmente crudele, come il combattimento dei galli, o le corride che ancora sopravvivono in
Spagna. Esistevano anche degli orsi ammaestrati. Nella Masque of Oberon di Ben Jonson,
spettacolo dato l’1 gennaio 1611, compariva un cocchio tirato da due orsi. Uno di questi può essersi
esibito anche nel The Winter’s Tale.
35 III, iii, 111 changeling era l’elfo, il mutante, che le fate lasciavano in pegno al posto del bambino che
rubavano. Dei doni delle fate non si doveva parlare (rigo 117) o la buona fortuna si sarebbe
tramutata in disgrazia.
36 IV, iii, 1 e sgg. Autolico entra in scena cantando una canzone da ladri, tutt’altro che una pastorale,
una canzone piena del gergo del suo mestiere e di doppi sensi. Come i suoi contemporanei,