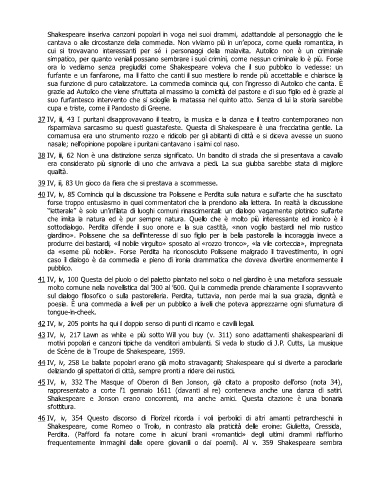Page 876 - Shakespeare - Vol. 4
P. 876
Shakespeare inseriva canzoni popolari in voga nei suoi drammi, adattandole al personaggio che le
cantava o alle circostanze della commedia. Non viviamo più in un’epoca, come quella romantica, in
cui si trovavano interessanti per sé i personaggi della malavita. Autolico non è un criminale
simpatico, per quanto veniali possano sembrare i suoi crimini, come nessun criminale lo è più. Forse
ora lo vediamo senza pregiudizi come Shakespeare voleva che il suo pubblico lo vedesse: un
furfante e un fanfarone, ma il fatto che canti il suo mestiere lo rende più accettabile e chiarisce la
sua funzione di puro catalizzatore. La commedia comincia qui, con l’ingresso di Autolico che canta. È
grazie ad Autolico che viene sfruttata al massimo la comicità del pastore e di suo figlio ed è grazie al
suo furfantesco intervento che si scioglie la matassa nel quinto atto. Senza di lui la storia sarebbe
cupa e triste, come il Pandosto di Greene.
37 IV, iii, 43 I puritani disapprovavano il teatro, la musica e la danza e il teatro contemporaneo non
risparmiava sarcasmo su questi guastafeste. Questa di Shakespeare è una frecciatina gentile. La
cornamusa era uno strumento rozzo e ridicolo per gli abitanti di città e si diceva avesse un suono
nasale; nell’opinione popolare i puritani cantavano i salmi col naso.
38 IV, iii, 62 Non è una distinzione senza significato. Un bandito di strada che si presentava a cavallo
era considerato più signorile di uno che arrivava a piedi. La sua giubba sarebbe stata di migliore
qualità.
39 IV, iii, 83 Un gioco da fiera che si prestava a scommesse.
40 IV, iv, 85 Comincia qui la discussione tra Polissene e Perdita sulla natura e sull’arte che ha suscitato
forse troppo entusiasmo in quei commentatori che la prendono alla lettera. In realtà la discussione
“letterale” è solo un’infilata di luoghi comuni rinascimentali: un dialogo vagamente plotinico sull’arte
che imita la natura ed è pur sempre natura. Quello che è molto più interessante ed ironico è il
sottodialogo. Perdita difende il suo onore e la sua castità, «non voglio bastardi nel mio rustico
giardino». Polissene che sa dell’interesse di suo figlio per la bella pastorella la incoraggia invece a
produrre dei bastardi, «il nobile virgulto» sposato al «rozzo tronco», «la vile corteccia», impregnata
da «seme più nobile». Forse Perdita ha riconosciuto Polissene malgrado il travestimento, in ogni
caso il dialogo è da commedia e pieno di ironia drammatica che doveva divertire enormemente il
pubblico.
41 IV, iv, 100 Questa del piuolo o del paletto piantato nel solco o nel giardino è una metafora sessuale
molto comune nella novellistica dal ’300 al ’600. Qui la commedia prende chiaramente il sopravvento
sul dialogo filosofico o sulla pastorelleria. Perdita, tuttavia, non perde mai la sua grazia, dignità e
poesia. È una commedia a livelli per un pubblico a livelli che poteva apprezzarne ogni sfumatura di
tongue-in-cheek.
42 IV, iv, 205 points ha qui il doppio senso di punti di ricamo e cavilli legali.
43 IV, iv, 217 Lawn as white e più sotto Will you buy (v. 311) sono adattamenti shakespeariani di
motivi popolari e canzoni tipiche da venditori ambulanti. Si veda lo studio di J.P. Cutts, La musique
de Scène de la Troupe de Shakespeare, 1959.
44 IV, iv, 258 Le ballate popolari erano già molto stravaganti; Shakespeare qui si diverte a parodiarle
deliziando gli spettatori di città, sempre pronti a ridere dei rustici.
45 IV, iv, 332 The Masque of Oberon di Ben Jonson, già citato a proposito dell’orso (nota 34),
rappresentato a corte l’1 gennaio 1611 (davanti al re) conteneva anche una danza di satiri.
Shakespeare e Jonson erano concorrenti, ma anche amici. Questa citazione è una bonaria
sfottitura.
46 IV, iv, 354 Questo discorso di Florizel ricorda i voli iperbolici di altri amanti petrarcheschi in
Shakespeare, come Romeo o Troilo, in contrasto alla praticità delle eroine: Giulietta, Cressida,
Perdita. (Pafford fa notare come in alcuni brani «romantici» degli ultimi drammi riaffiorino
frequentemente immagini dalle opere giovanili o dai poemi). Al v. 359 Shakespeare sembra