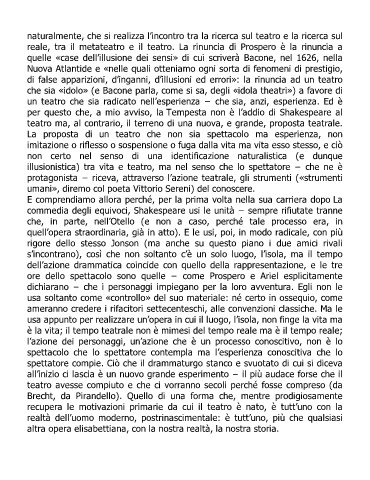Page 893 - Shakespeare - Vol. 4
P. 893
naturalmente, che si realizza l’incontro tra la ricerca sul teatro e la ricerca sul
reale, tra il metateatro e il teatro. La rinuncia di Prospero è la rinuncia a
quelle «case dell’illusione dei sensi» di cui scriverà Bacone, nel 1626, nella
Nuova Atlantide e «nelle quali otteniamo ogni sorta di fenomeni di prestigio,
di false apparizioni, d’inganni, d’illusioni ed errori»: la rinuncia ad un teatro
che sia «idolo» (e Bacone parla, come si sa, degli «idola theatri») a favore di
un teatro che sia radicato nell’esperienza − che sia, anzi, esperienza. Ed è
per questo che, a mio avviso, la Tempesta non è l’addio di Shakespeare al
teatro ma, al contrario, il terreno di una nuova, e grande, proposta teatrale.
La proposta di un teatro che non sia spettacolo ma esperienza, non
imitazione o riflesso o sospensione o fuga dalla vita ma vita esso stesso, e ciò
non certo nel senso di una identificazione naturalistica (e dunque
illusionistica) tra vita e teatro, ma nel senso che lo spettatore − che ne è
protagonista − riceva, attraverso l’azione teatrale, gli strumenti («strumenti
umani», diremo col poeta Vittorio Sereni) del conoscere.
E comprendiamo allora perché, per la prima volta nella sua carriera dopo La
commedia degli equivoci, Shakespeare usi le unità − sempre rifiutate tranne
che, in parte, nell’Otello (e non a caso, perché tale processo era, in
quell’opera straordinaria, già in atto). E le usi, poi, in modo radicale, con più
rigore dello stesso Jonson (ma anche su questo piano i due amici rivali
s’incontrano), così che non soltanto c’è un solo luogo, l’isola, ma il tempo
dell’azione drammatica coincide con quello della rappresentazione, e le tre
ore dello spettacolo sono quelle − come Prospero e Ariel esplicitamente
dichiarano − che i personaggi impiegano per la loro avventura. Egli non le
usa soltanto come «controllo» del suo materiale: né certo in ossequio, come
ameranno credere i rifacitori settecenteschi, alle convenzioni classiche. Ma le
usa appunto per realizzare un’opera in cui il luogo, l’isola, non finge la vita ma
è la vita; il tempo teatrale non è mimesi del tempo reale ma è il tempo reale;
l’azione dei personaggi, un’azione che è un processo conoscitivo, non è lo
spettacolo che lo spettatore contempla ma l’esperienza conoscitiva che lo
spettatore compie. Ciò che il drammaturgo stanco e svuotato di cui si diceva
all’inizio ci lascia è un nuovo grande esperimento − il più audace forse che il
teatro avesse compiuto e che ci vorranno secoli perché fosse compreso (da
Brecht, da Pirandello). Quello di una forma che, mentre prodigiosamente
recupera le motivazioni primarie da cui il teatro è nato, è tutt’uno con la
realtà dell’uomo moderno, postrinascimentale: è tutt’uno, più che qualsiasi
altra opera elisabettiana, con la nostra realtà, la nostra storia.