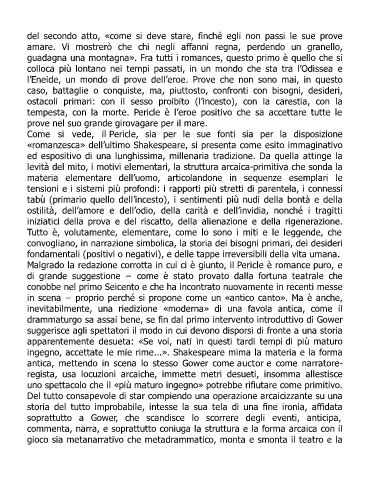Page 16 - Shakespeare - Vol. 4
P. 16
del secondo atto, «come si deve stare, finché egli non passi le sue prove
amare. Vi mostrerò che chi negli affanni regna, perdendo un granello,
guadagna una montagna». Fra tutti i romances, questo primo è quello che si
colloca più lontano nei tempi passati, in un mondo che sta tra l’Odissea e
l’Eneide, un mondo di prove dell’eroe. Prove che non sono mai, in questo
caso, battaglie o conquiste, ma, piuttosto, confronti con bisogni, desideri,
ostacoli primari: con il sesso proibito (l’incesto), con la carestia, con la
tempesta, con la morte. Pericle è l’eroe positivo che sa accettare tutte le
prove nel suo grande girovagare per il mare.
Come si vede, il Pericle, sia per le sue fonti sia per la disposizione
«romanzesca» dell’ultimo Shakespeare, si presenta come esito immaginativo
ed espositivo di una lunghissima, millenaria tradizione. Da quella attinge la
levità del mito, i motivi elementari, la struttura arcaica-primitiva che sonda la
materia elementare dell’uomo, articolandone in sequenze esemplari le
tensioni e i sistemi più profondi: i rapporti più stretti di parentela, i connessi
tabù (primario quello dell’incesto), i sentimenti più nudi della bontà e della
ostilità, dell’amore e dell’odio, della carità e dell’invidia, nonché i tragitti
iniziatici della prova e del riscatto, della alienazione e della rigenerazione.
Tutto è, volutamente, elementare, come lo sono i miti e le leggende, che
convogliano, in narrazione simbolica, la storia dei bisogni primari, dei desideri
fondamentali (positivi o negativi), e delle tappe irreversibili della vita umana.
Malgrado la redazione corrotta in cui ci è giunto, il Pericle è romance puro, e
di grande suggestione − come è stato provato dalla fortuna teatrale che
conobbe nel primo Seicento e che ha incontrato nuovamente in recenti messe
in scena − proprio perché si propone come un «antico canto». Ma è anche,
inevitabilmente, una riedizione «moderna» di una favola antica, come il
drammaturgo sa assai bene, se fin dal primo intervento introduttivo di Gower
suggerisce agli spettatori il modo in cui devono disporsi di fronte a una storia
apparentemente desueta: «Se voi, nati in questi tardi tempi di più maturo
ingegno, accettate le mie rime...». Shakespeare mima la materia e la forma
antica, mettendo in scena lo stesso Gower come auctor e come narratore-
regista, usa locuzioni arcaiche, immette metri desueti, insomma allestisce
uno spettacolo che il «più maturo ingegno» potrebbe rifiutare come primitivo.
Del tutto consapevole di star compiendo una operazione arcaicizzante su una
storia del tutto improbabile, intesse la sua tela di una fine ironia, affidata
soprattutto a Gower, che scandisce lo scorrere degli eventi, anticipa,
commenta, narra, e soprattutto coniuga la struttura e la forma arcaica con il
gioco sia metanarrativo che metadrammatico, monta e smonta il teatro e la