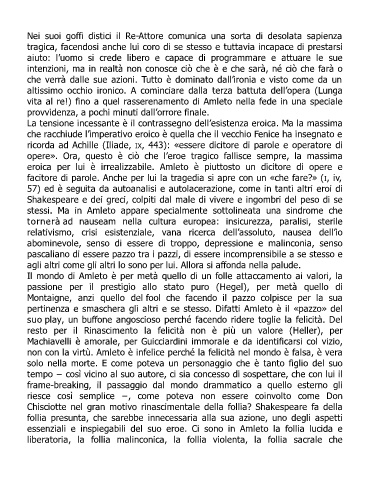Page 10 - Shakespeare - Vol. 3
P. 10
Nei suoi goffi distici il Re-Attore comunica una sorta di desolata sapienza
tragica, facendosi anche lui coro di se stesso e tuttavia incapace di prestarsi
aiuto: l’uomo si crede libero e capace di programmare e attuare le sue
intenzioni, ma in realtà non conosce ciò che è e che sarà, né ciò che farà o
che verrà dalle sue azioni. Tutto è dominato dall’ironia e visto come da un
altissimo occhio ironico. A cominciare dalla terza battuta dell’opera (Lunga
vita al re!) fino a quel rasserenamento di Amleto nella fede in una speciale
provvidenza, a pochi minuti dall’orrore finale.
La tensione incessante è il contrassegno dell’esistenza eroica. Ma la massima
che racchiude l’imperativo eroico è quella che il vecchio Fenice ha insegnato e
ricorda ad Achille (Iliade, IX, 443): «essere dicitore di parole e operatore di
opere». Ora, questo è ciò che l’eroe tragico fallisce sempre, la massima
eroica per lui è irrealizzabile. Amleto è piuttosto un dicitore di opere e
facitore di parole. Anche per lui la tragedia si apre con un «che fare?» (I, iv,
57) ed è seguita da autoanalisi e autolacerazione, come in tanti altri eroi di
Shakespeare e dei greci, colpiti dal male di vivere e ingombri del peso di se
stessi. Ma in Amleto appare specialmente sottolineata una sindrome che
tornerà ad nauseam nella cultura europea: insicurezza, paralisi, sterile
relativismo, crisi esistenziale, vana ricerca dell’assoluto, nausea dell’io
abominevole, senso di essere di troppo, depressione e malinconia, senso
pascaliano di essere pazzo tra i pazzi, di essere incomprensibile a se stesso e
agli altri come gli altri lo sono per lui. Allora si affonda nella palude.
Il mondo di Amleto è per metà quello di un folle attaccamento ai valori, la
passione per il prestigio allo stato puro (Hegel), per metà quello di
Montaigne, anzi quello del fool che facendo il pazzo colpisce per la sua
pertinenza e smaschera gli altri e se stesso. Difatti Amleto è il «pazzo» del
suo play, un buffone angoscioso perché facendo ridere toglie la felicità. Del
resto per il Rinascimento la felicità non è più un valore (Heller), per
Machiavelli è amorale, per Guicciardini immorale e da identificarsi col vizio,
non con la virtù. Amleto è infelice perché la felicità nel mondo è falsa, è vera
solo nella morte. E come poteva un personaggio che è tanto figlio del suo
tempo − così vicino al suo autore, ci sia concesso di sospettare, che con lui il
frame-breaking, il passaggio dal mondo drammatico a quello esterno gli
riesce così semplice −, come poteva non essere coinvolto come Don
Chisciotte nel gran motivo rinascimentale della follia? Shakespeare fa della
follia presunta, che sarebbe innecessaria alla sua azione, uno degli aspetti
essenziali e inspiegabili del suo eroe. Ci sono in Amleto la follia lucida e
liberatoria, la follia malinconica, la follia violenta, la follia sacrale che