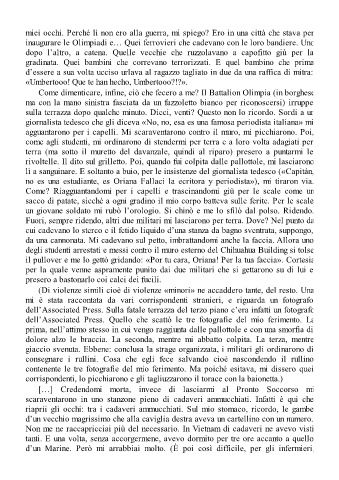Page 64 - Oriana Fallaci - La vita è una guerra ripetuta ogni giorno
P. 64
miei occhi. Perché lì non ero alla guerra, mi spiego? Ero in una città che stava per
inaugurare le Olimpiadi e… Quei ferrovieri che cadevano con le loro bandiere. Uno
dopo l’altro, a catena. Quelle vecchie che ruzzolavano a capofitto giù per la
gradinata. Quei bambini che correvano terrorizzati. E quel bambino che prima
d’essere a sua volta ucciso urlava al ragazzo tagliato in due da una raffica di mitra:
«Umbertooo! Que te han hecho, Umbertooo?!?».
Come dimenticare, infine, ciò che fecero a me? Il Battalion Olimpia (in borghese
ma con la mano sinistra fasciata da un fazzoletto bianco per riconoscersi) irruppe
sulla terrazza dopo qualche minuto. Dieci, venti? Questo non lo ricordo. Sordi a un
giornalista tedesco che gli diceva «No, no, esa es una famosa periodista italiana» mi
agguantarono per i capelli. Mi scaraventarono contro il muro, mi picchiarono. Poi,
come agli studenti, mi ordinarono di stendermi per terra e a loro volta adagiati per
terra (ma sotto il muretto del davanzale, quindi al riparo) presero a puntarmi le
rivoltelle. Il dito sul grilletto. Poi, quando fui colpita dalle pallottole, mi lasciarono
lì a sanguinare. E soltanto a buio, per le insistenze del giornalista tedesco («Capitán,
no es una estudiante, es Oriana Fallaci la ecritora y periodista»), mi tiraron via.
Come? Riagguantandomi per i capelli e trascinandomi giù per le scale come un
sacco di patate, sicché a ogni gradino il mio corpo batteva sulle ferite. Per le scale
un giovane soldato mi rubò l’orologio. Si chinò e me lo sfilò dal polso. Ridendo.
Fuori, sempre ridendo, altri due militari mi lasciarono per terra. Dove? Nel punto da
cui cadevano lo sterco e il fetido liquido d’una stanza da bagno sventrata, suppongo,
da una cannonata. Mi cadevano sul petto, imbrattandomi anche la faccia. Allora uno
degli studenti arrestati e messi contro il muro esterno del Chihuahua Building si tolse
il pullover e me lo gettò gridando: «Por tu cara, Oriana! Per la tua faccia». Cortesia
per la quale venne aspramente punito dai due militari che si gettarono su di lui e
presero a bastonarlo coi calci dei fucili.
(Di violenze simili cioè di violenze «minori» ne accaddero tante, del resto. Una
mi è stata raccontata da vari corrispondenti stranieri, e riguarda un fotografo
dell’Associated Press. Sulla fatale terrazza del terzo piano c’era infatti un fotografo
dell’Associated Press. Quello che scattò le tre fotografie del mio ferimento. La
prima, nell’attimo stesso in cui vengo raggiunta dalle pallottole e con una smorfia di
dolore alzo le braccia. La seconda, mentre mi abbatto colpita. La terza, mentre
giaccio svenuta. Ebbene: conclusa la strage organizzata, i militari gli ordinarono di
consegnare i rullini. Cosa che egli fece salvando cioè nascondendo il rullino
contenente le tre fotografie del mio ferimento. Ma poiché esitava, mi dissero quei
corrispondenti, lo picchiarono e gli tagliuzzarono il torace con la baionetta.)
[…] Credendomi morta, invece di lasciarmi al Pronto Soccorso mi
scaraventarono in uno stanzone pieno di cadaveri ammucchiati. Infatti è qui che
riaprii gli occhi: tra i cadaveri ammucchiati. Sul mio stomaco, ricordo, le gambe
d’un vecchio magrissimo che alla caviglia destra aveva un cartellino con un numero.
Non me ne raccapricciai più del necessario. In Vietnam di cadaveri ne avevo visti
tanti. E una volta, senza accorgermene, avevo dormito per tre ore accanto a quello
d’un Marine. Però mi arrabbiai molto. (È poi così difficile, per gli infermieri,