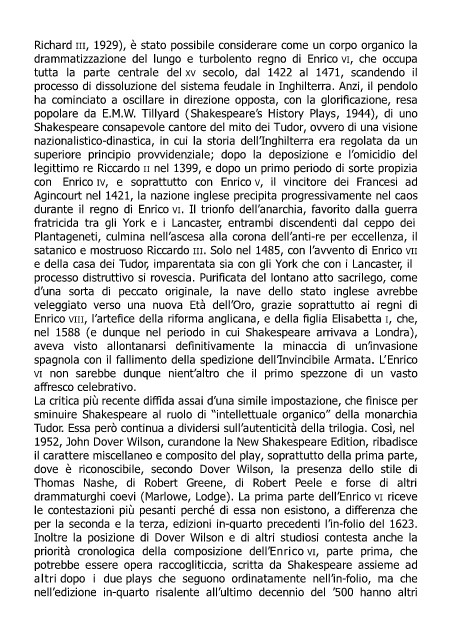Page 39 - Shakespeare - Vol. 1
P. 39
Richard III, 1929), è stato possibile considerare come un corpo organico la
drammatizzazione del lungo e turbolento regno di Enrico VI, che occupa
tutta la parte centrale del XV secolo, dal 1422 al 1471, scandendo il
processo di dissoluzione del sistema feudale in Inghilterra. Anzi, il pendolo
ha cominciato a oscillare in direzione opposta, con la glorificazione, resa
popolare da E.M.W. Tillyard ( Shakespeare’s History Plays, 1944), di uno
Shakespeare consapevole cantore del mito dei Tudor, ovvero di una visione
nazionalistico-dinastica, in cui la storia dell’Inghilterra era regolata da un
superiore principio provvidenziale; dopo la deposizione e l’omicidio del
legittimo re Riccardo II nel 1399, e dopo un primo periodo di sorte propizia
con Enrico IV, e soprattutto con Enrico V, il vincitore dei Francesi ad
Agincourt nel 1421, la nazione inglese precipita progressivamente nel caos
durante il regno di Enrico VI. Il trionfo dell’anarchia, favorito dalla guerra
fratricida tra gli York e i Lancaster, entrambi discendenti dal ceppo dei
Plantageneti, culmina nell’ascesa alla corona dell’anti-re per eccellenza, il
satanico e mostruoso Riccardo III. Solo nel 1485, con l’avvento di Enrico VII
e della casa dei Tudor, imparentata sia con gli York che con i Lancaster, il
processo distruttivo si rovescia. Purificata del lontano atto sacrilego, come
d’una sorta di peccato originale, la nave dello stato inglese avrebbe
veleggiato verso una nuova Età dell’Oro, grazie soprattutto ai regni di
Enrico VIII, l’artefice della riforma anglicana, e della figlia Elisabetta I, che,
nel 1588 (e dunque nel periodo in cui Shakespeare arrivava a Londra),
aveva visto allontanarsi definitivamente la minaccia di un’invasione
spagnola con il fallimento della spedizione dell’Invincibile Armata. L’Enrico
VI non sarebbe dunque nient’altro che il primo spezzone di un vasto
affresco celebrativo.
La critica più recente diffida assai d’una simile impostazione, che finisce per
sminuire Shakespeare al ruolo di “intellettuale organico” della monarchia
Tudor. Essa però continua a dividersi sull’autenticità della trilogia. Così, nel
1952, John Dover Wilson, curandone la New Shakespeare Edition, ribadisce
il carattere miscellaneo e composito del play, soprattutto della prima parte,
dove è riconoscibile, secondo Dover Wilson, la presenza dello stile di
Thomas Nashe, di Robert Greene, di Robert Peele e forse di altri
drammaturghi coevi (Marlowe, Lodge). La prima parte dell’Enrico VI riceve
le contestazioni più pesanti perché di essa non esistono, a differenza che
per la seconda e la terza, edizioni in-quarto precedenti l’in-folio del 1623.
Inoltre la posizione di Dover Wilson e di altri studiosi contesta anche la
priorità cronologica della composizione dell’Enrico VI, parte prima, che
potrebbe essere opera raccogliticcia, scritta da Shakespeare assieme ad
altri dopo i due plays che seguono ordinatamente nell’in-folio, ma che
nell’edizione in-quarto risalente all’ultimo decennio del ’500 hanno altri