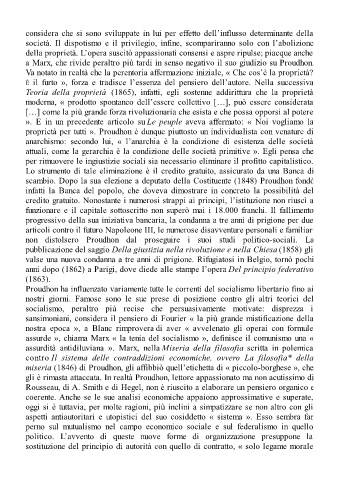Page 680 - Dizionario di Filosofia
P. 680
considera che si sono sviluppate in lui per effetto dell’influsso determinante della
società. Il dispotismo e il privilegio, infine, scompariranno solo con l’abolizione
della proprietà. L’opera suscitò appassionati consensi e aspre ripulse; piacque anche
a Marx, che rivide peraltro più tardi in senso negativo il suo giudizio su Proudhon.
Va notato in realtà che la perentoria affermazione iniziale, « Che cos’è la proprietà?
È il furto », forza e tradisce l’essenza del pensiero dell’autore. Nella successiva
Teoria della proprietà (1865), infatti, egli sostenne addirittura che la proprietà
moderna, « prodotto spontaneo dell’essere collettivo […], può essere considerata
[…] come la più grande forza rivoluzionaria che esista e che possa opporsi al potere
». E in un precedente articolo su Le peuple aveva affermato: « Noi vogliamo la
proprietà per tutti ». Proudhon è dunque piuttosto un individualista con venature di
anarchismo: secondo lui, « l’anarchia è la condizione di esistenza delle società
attuali, come la gerarchia è la condizione delle società primitive ». Egli pensa che
per rimuovere le ingiustizie sociali sia necessario eliminare il profitto capitalistico.
Lo strumento di tale eliminazione è il credito gratuito, assicurato da una Banca di
scambio. Dopo la sua elezione a deputato della Costituente (1848) Proudhon fondò
infatti la Banca del popolo, che doveva dimostrare in concreto la possibilità del
credito gratuito. Nonostante i numerosi strappi ai principi, l’istituzione non riuscì a
funzionare e il capitale sottoscritto non superò mai i 18.000 franchi. Il fallimento
progressivo della sua iniziativa bancaria, la condanna a tre anni di prigione per due
articoli contro il futuro Napoleone III, le numerose disavventure personali e familiari
non distolsero Proudhon dal proseguire i suoi studi politico-sociali. La
pubblicazione del saggio Della giustizia nella rivoluzione e nella Chiesa (1858) gli
valse una nuova condanna a tre anni di prigione. Rifugiatosi in Belgio, tornò pochi
anni dopo (1862) a Parigi, dove diede alle stampe l’opera Del principio federativo
(1863).
Proudhon ha influenzato variamente tutte le correnti del socialismo libertario fino ai
nostri giorni. Famose sono le sue prese di posizione contro gli altri teorici del
socialismo, peraltro più recise che persuasivamente motivate: disprezza i
sansimoniani, considera il pensiero di Fourier « la più grande mistificazione della
nostra epoca », a Blanc rimprovera di aver « avvelenato gli operai con formule
assurde », chiama Marx « la tenia del socialismo », definisce il comunismo una «
assurdità antidiluviana ». Marx, nella Miseria della filosofia scritta in polemica
contro Il sistema delle contraddizioni economiche, ovvero La filosofia* della
miseria (1846) di Proudhon, gli affibbiò quell’etichetta di « piccolo-borghese », che
gli è rimasta attaccata. In realtà Proudhon, lettore appassionato ma non acutissimo di
Rousseau, di A. Smith e di Hegel, non è riuscito a elaborare un pensiero organico e
coerente. Anche se le sue analisi economiche appaiono approssimative e superate,
oggi si è tuttavia, per molte ragioni, più inclini a simpatizzare se non altro con gli
aspetti antiautoritari e utopistici del suo cosiddetto « sistema ». Esso sembra far
perno sul mutualismo nel campo economico sociale e sul federalismo in quello
politico. L’avvento di queste nuove forme di organizzazione presuppone la
sostituzione del principio di autorità con quello di contratto, « solo legame morale